Case in Italia - Istituto Aveta
Menu principale:
- Home
- Chi siamo
-
Il Santuario
-
Madonna Pellegrina
- Pellegrina Anno 1950
- Pellegrina Anno 1977
- Pellegrina Anno 1982
- Pellegrina Anno 1984
- Pellegrina Anno 1988
- Pellegrina Anno 1992
- Pellegrina Anno 2005
- Pellegrina Anno 2006
- Pellegrina Anno 2007
- Pellegrina Anno 2008
- Pellegrina Anno 2009
- Pellegrina Anno 2010
- Pellegrina Anno 2011
- Pellegrina Anno 2012
- Pellegrina Anno 2013
- Pellegrina Anno 2014
- Storia del Santuario
- Bartolo Longo
- Rivista del Santuario
- Delegati Pontifici
- L'Ora del Mondo
- Gli Ex Voto
-
Madonna Pellegrina
-
La Scuola
- Documenti condivisi
- Scuola dell'Infanzia
- Scuola Primaria
- Uffici Amministrativi
- Modulistica
- Con Gesù
-
Il mio Santo
-
Santi di Gennaio
- Santi del 1 gennaio
- Santi del 2 gennaio
- Santi del 3 gennaio
- Santi del 4 gennaio
- Santi del 5 gennaio
- Santi del 6 gennaio
- Santi del 7 gennaio
- Santi del 8 gennaio
- Santi del 9 gennaio
- Santi del 10 gennaio
- Santi del 11 gennaio
- Santi del 12 gennaio
- Santi del 13 gennaio
- Santi del 14 gennaio
- Santi del 15 gennaio
- Santi del 16 gennaio
- Santi del 17 gennaio
- Santi del 18 gennaio
- Santi del 19 gennaio
- Santi del 20 gennaio
- Santi del 21 gennaio
- Santi del 22 gennaio
- Santi del 23 gennaio
- Santi del 24 gennaio
- Santi del 25 gennaio
- Santi del 26 gennaio
- Santi del 27 gennaio
- Santi del 28 gennaio
- Santi del 29 gennaio
- Santi del 30 gennaio
- Santi del 31 gennaio
-
I Santi di Febbraio
- Santi del 1 Febbraio
- Santi del 2 Febbraio
- Santi del 3 Febbraio
- Santi del 4 Febbraio
- Santi del 5 Febbraio
- Santi del 6 Febbraio
- Santi del 7 Febbraio
- Santi del 8 Febbraio
- Santi del 9 Febbraio
- Santi del 10 Febbraio
- Santi del 11 Febbraio
- Santi del 12 Febbraio
- Santi del 13 Febbraio
- Santi del 14 Febbraio
- Santi del 15 Febbraio
- Santi del 16 Febbraio
-
I Santi di Marzo
- Santi del 1 Marzo
- Santi del 2 Marzo
- Santi del 3 Marzo
- Santi del 4 Marzo
- Santi del 5 Marzo
- Santi del 6 Marzo
- Santi del 7 Marzo
- Santi del 8 Marzo
- Santi del 9 Marzo
- Santi del 10 Marzo
- Santi dell' 11 Marzo
- Santi del 12 Marzo
- Santi del 13 Marzo
- Santi del 14 Marzo
- Santi del 15 Marzo
- Santi del 16 Marzo
- Santi del 17 Marzo
- Santi del 18 Marzo
- Santi del 19 Marzo
- Santi del 20 Marzo
- Santi del 21 Marzo
- Santi del 22 Marzo
- Santi del 23 Marzo
- Santi del 24 Marzo
- Santi del 25 Marzo
- Santi del 26 Marzo
- Santi del 27 Marzo
- Santi del 28 Marzo
- Santi del 29 Marzo
- Santi del 30 Marzo
- Santi del 31 Marzo
- I Santi di Aprile
- I Santi di Maggio
- I Santi di Giugno
- I Santi di Luglio
- I Santi di Agosto
- I Santi di Settembre
- I Santi di Ottobre
- I Santi di Novembre
- I Santi di Dicembre
- Schede dei Gruppi
-
Santi di Gennaio
Case in Italia


La nostra casa di Agerola (Napoli)
Regione
La Campania è una regione dell'Italia meridionale. Conta 5.701.931 residenti (censimento 2001 ed  ha la più alta densità di popolazione tra le regioni italiane, ma è seconda dopo la Lombardia per numero totale di abitanti.
ha la più alta densità di popolazione tra le regioni italiane, ma è seconda dopo la Lombardia per numero totale di abitanti.
Il suo capoluogo è Napoli. Confina a ovest, sud-
Il nome Campania deriva dal termine latino campus, che vuol dire campagna, e per commistione linguistica, dal termine osco Kampanom, con il quale si indicava l'area nei pressi della città di Capua.
Città
Le prime tracce di presenza umana riscontrate sul territorio agerolese risalgono all'età del bronzo (III-
In epoca romana numerose "ville rustiche" attestano che il territorio, almeno nella sua parte pianeggiante, doveva presentarsi già coperto da coltivazioni.
La vocazione fortemente agricola del paese ha indotto a far risalire il toponimo Agerola dal latino ager=campo; esiste, tuttavia, una seconda ipotesi avanzata dallo storico Matteo Camera secondo il quale sembra che dovesse piuttosto derivare dalla voce latina aëreus, come luogo elevato (Camera M., Memorie storico-
Un'ulteriore tesi farebbe derivare il toponimo Agerola dall'antico Jerula (Gerla=conca) essendo riportata in molti documenti antichi.
Dopo i danni arrecati dall'eruzione del Vesuvio del 79 D.C. (il suolo fu coperto da un metro e mezzo di pomici) si registrò un certo spopolamento; ma almeno l'allevamento bovino deve essersi ripreso rapidamente, tanto che nella seconda metà del II secolo D.C., Galeno il celebre medico di Marco Aurelio e Commodo in "De metodo memendi" (V, 12) vanta la bontà e le qualità terapeutiche del latte prodotto sui Monti Lattari (Lactarius mons).
Campeggio Ostello Cassiodoro (Variae, XI 10) scrive tra il 533 ed il 537 d.C. che il re dei Goti aveva  ordinato ad un suo servo (Famulus) di ricorrere ai "rimedia lactarii montis", poiché le cure dei medici non gli giovavano.
ordinato ad un suo servo (Famulus) di ricorrere ai "rimedia lactarii montis", poiché le cure dei medici non gli giovavano.
Nei secoli centrali del medioevo, parallelamente al rifiorire dell'intera Costiera ed al costituirsi del Ducato Amalfitano, la conca di Agerola si ripopola e sviluppa i suoi 5 casali: Campulo, Memoranum, Planillum, Ponte e San Lazzaro; come parte integrante del territorio di Amalfi, Agerola ne condivide gli intensi scambi commerciali che in tale periodo collegavano la repubblica marinara ai Paesi dell'intero Mediterraneo, a Bisanzio e, ovviamente, a Napoli, destinataria dei tessuti in seta nella cui manifattura gli agerolesi erano specializzati. Paese tipicamente montano, Agerola vanta un'antica storia. La scoperta di reperti quali anfore, lucerne, vasi e monete appartenenti ai primi Cesari di Roma, nonché tombe, abituri, cunicoli e strade, avvalorano la tesi che questo villaggio fosse già noto agli antichi Romani, Bizantini e Longobardi.AGEROLA
Il nome Agerola deriva, quasi sicuramente, da "ager", termine latino che significa campo. Infatti, alle sue origini, i primi abitanti dissodarono piccoli campi fra le fitte foreste che rivestivano l'intero territorio, ricavandosi, in questo modo, una piccola area su cui si sviluppò nei secoli il centro urbano. Attualmente il paese conserva ancora questa caratteristica con il territorio frazionato in numerosi piccoli campi ricavati operando una sistemazione a "terrazze" dei pendii montani. In età medioevale Agerola, con le sue cinque frazioni, fece parte del territorio della Repubblica di Amalfi che si estendeva da Ravello fino a Positano e, con i suoi vasti territori boschivi, riforniva di legname gli arsenali della Repubblica per la costruzione delle navi.
Ad Amalfi, dove un monumento ricorda Flavio Gioia, gloria cittadina e “inventore della bussola” nel 1302. Ma, per alcuni storici, Flavio Gioia fu solo un personaggio leggendario che riuniva in sé le capacità nautiche e imprenditoriali della gloriosa Repubblica marinara di Amalfi, bruscamente decaduta dopo il rovinoso maremoto del 1343 che ne distrusse completamente il porto mai più ricostruito. Come parte integrante del territorio di Amalfi, Agerola ne condivise le vicende storiche e tra queste le guerre contro i Saraceni.
In tale periodo il paese intratteneva scambi commerciali con Napoli, soprattutto per i tessuti in seta nella cui manifattura gli agerolesi erano specializzati.
Nell'anno 1068 finì che anche il Ducato di Amalfi, per l'incapacità e la debolezza del suo governo cadde sotto l'influenza Normanna.
Nel maggio del 1198 salì al trono di Sicilia Federico II di Svevia, il quale per la sua minore età fu posto sotto la tutela del papa Innocenzo III.
Dell'autonomia agerolese verrà gettato il seme con l'avvento angioino, quando Agerola avrà i primi eletti del popolo ai quali Roberto d'Angiò riconoscerà, nel 1339, il diritto parziale all'amministrazione.
Nel 1381 il duca Carlo di Durazzo, vivendo presso la corte della regina Giovanna, s'impadronì del regno.
Nel 1423 Giovanna II venne in disaccordo col Colonna ed allora inviò nel Ducato il maresciallo del Regno Petraccone Caracciolo ad assumerne il governo in nome suo.
Alla morte di Giovanna II, avvenuta il 2 febbraio 1435 dopo venti anni di regno, risultò erede testamentario sul regno Alfonso D'Aragona, il Magnanimo.  Agerola il 10 novembre 1436 innalzò i simboli aragonesi, altre città dell'ex Ducato si schierarono con gli Angioini. Nel 1493 morto il Piccolomini e gli successe il figlio Alfonso che sposò Giovanna d'Aragona. Siamo ormai verso la fine del dominio aragonese, durato cinquantanove anni; la fine fu segnata nel 1503, quando il Regno di Napoli fu conquistato dagli Spagnoli.
Agerola il 10 novembre 1436 innalzò i simboli aragonesi, altre città dell'ex Ducato si schierarono con gli Angioini. Nel 1493 morto il Piccolomini e gli successe il figlio Alfonso che sposò Giovanna d'Aragona. Siamo ormai verso la fine del dominio aragonese, durato cinquantanove anni; la fine fu segnata nel 1503, quando il Regno di Napoli fu conquistato dagli Spagnoli.
Si tramanda che nel 1600 i monti di Agerola fossero infestati dai briganti, che fra i fitti boschi trovavano un sicuro nascondiglio. Nei secoli che seguirono il Comune entrò a far parte del Regno di Napoli di cui seguì le alterne vicende fino all'unità d'Italia.
Nel Settecento Agerola visse un periodo assai prospero attestato anche dalla crescita esponenziale del numero di abitanti. Migliorarono le condizioni economiche grazie alle riforme borboniche e con la riduzione delle tassazioni, scomparve quasi del tutto il brigantaggio. Le idee ispiratrici della rivoluzione francese furono accolte dai dotti agerolesi che vivevano a Napoli, sicché Agerola fu il primo paese della provincia ad aderire alla costituzione democratica della Repubblica Partenopea.Agerola -
Dopo la restaurazione del 1815, i patrioti non potevano esprimersi liberamente perché sarebbero stati arrestati. Essi si riunirono e si svilupparono anche ad Agerola le società segrete la più importante delle quali fu la Carboneria. I carbonari si proponevano di ottenere statuti e riforme liberali dai governi assoluti: erano organizzati in sezioni, chiamate vendite, e che avevano a capo un Maestro. L'ammissione era regolata da un rituale ricco di simboli: giuramento, parole d'ordine, segni convenzionali, ecc. . La figura dominante nell'ultimo periodo borbonico fu il generale Avitabile, che nel 1844 ottenne la scissione di Agerola dalla provincia di Salerno per aggregarla a quella di Napoli: la città venne, così, separata dal territorio di Amalfi, con il quale aveva condiviso secoli di storia, rimanendovi legata unicamente per la giurisdizione religiosa (Cattolica).
Nel marzo del 1862 fu eletto il primo Consiglio Comunale. Agerola, forte di un passato assai ricco, oltre alle bellezze naturali, offre al visitatore un patrimonio artistico ed architettonico di grande interesse. Presso l'Arciconfraternita del SS. Sacramento, nella frazione di San Lazzaro, è possibile ammirare, solo per fare qualche esempio, una statua lignea del XVI secolo raffigurante la Madonna delle rose, mentre nella Chiesa di S. Pietro Apostolo, alla frazione Pianillo, è esposto un crocifisso d'argento del XV secolo.
Inoltre, va precisato che quest'ultima Chiesa è l'unica delle cinque chiese medievali che esistevano nella frazione. Di particolare interesse è, anche, la Chiesa di Santa Maria la Manna. La Chiesa, che risale al 1400, custodisce una statua della "Madonna in manna" che la tradizione vuole sia stata trasportata dall'Oriente durante la persecuzione iconoclasta. Rimanendo nell'ambito delle bellezze artistiche ed architettoniche di ispirazione religiosa, vanno segnalate: la Chiesa di S. Matteo Apostolo che, localizzata nella Frazione di Bomerano, dove si conserva un crocifisso ligneo e un busto reliquario d'argento di San Matteo del XVIII secolo, mentre sulla sua volta vi è un pregevole dipinto del 1632 opera del pittore siciliano Michele Regolia; il Santuario di Maria SS. del Rosario, alla Frazione di Bomerano, in località tutti i Santi, dove si possono ammirare una pala raffigurante la Madonna con i Santi e una statua ritenuta miracolosa; la Chiesa di S. Martino, (Frazione Campora) che fu eretta per conservare le spoglie del generale Avitabile, di cui conserva la tomba in marmo.
Infine, va segnalato il Castello Lauritano, di grande rilevanza architettonica, situato in frazione San Lazzaro. Si tratta dei resti di una roccaforte cui si giunge dalla frazione S. Lazzaro attraverso una comoda strada asfaltata immersa in un bosco ceduo castanile. Dagli spazi antistanti si gode di una delle più belle viste panoramiche della costiera Amalfitana, fino al golfo di Salerno (Monti Lattari).
La particolarità del castello è di tipo strutturale: infatti, esso è costruito con pietrame calcareo e malta bastarda, sull'esempio delle mura di sostegno dei terrazzamenti dei pendii montani. Nel corso dell'anno ad Agerola vengono organizzate numerose manifestazioni, sia folcloristiche che religiose, che testimoniano la volontà di conservare inalterato un patrimonio culturale che si perde nei secoli. Tra le tante, come manifestazioni più significative, per il numero di visitatori che riescono ad attrarre, ricordiamo: la Processione della Settimana Santa, che si svolge presso le località di Bomerano e di S. Lazzaro nel periodo Pasqua; la Sagra del Fior di Latte, che si tiene in località Pianillo la prima domenica di agosto; la Mostra dell'artigianato locale, un appuntamento della Frazione Campora per il periodo febbraio-
Tutto il territorio è ricoperto di una folta vegetazione, costituita per la maggior parte da bosco ceduo misto con essenza di latifoglie (castagno, ontano, noce, ecc.). Per quanto concerne la flora, va segnalato che notevole risulta l'incremento demografico del cinghiale riprodottosi abbondantemente a seguito del ripopolamento operato da associazioni venatorie locali.
Oltre al cinghiale, numerosissime sono anche le volpi ed i ricci. Per quanto concerne le bellezze naturali del Comune di Agerola, la parte più significativa di tale patrimonio è rappresentata dal Parco Colonia Montana. Localizzato nella Frazione di S. Lazzaro, il Parco è di proprietà della Regione Campania e copre una superficie di 1,5 ettari. L'area appartenne al Generale Avitabile (prima metà dell'Ottocento) che lo percorreva a cavallo al rientro dalle sue imprese belliche.
Inizialmente di dimensioni maggiori, ora è privo dell'area adibita anticamente a scuderie, attuale sede di un campeggio. In epoca fascista fu arricchito di una costruzione centrale ed era utilizzato per le colonie estive dei giovani. A San Lazzaro il poeta Salvatore di Giacomo, trovò ispirazione per la famosa "Luna di Agerola". Beata Solitudo
L'area a verde è alberata con essenze arboree non autoctone. Di dimensioni maggiori ma di pari bellezza, è il Parco Corona. Sito in frazione Bomerano, il Parco costeggia la Strada Statale per Amalfi.
Di proprietà dell'Istituto di sostentamento del clero della diocesi di Amalfi, è un bosco ceduo castanile dell'estensione di 3,5 ettari circa. Oggetto di manutenzione da parte della Comunità Montana, è interamente fruibile dal pubblico. Infine, va segnalata la località Bolvito-
È possibile raggiungere il sito da Via Radicosa. La manutenzione è assicurata dalla Comunità Montana della Penisola Sorrentina che ha sede ad Agerola (Frazione San Lazzaro).
Fondazione della Casa di Agerola
x
Responsabile della Comunità di Agerola
Madre Remigia Martello
Comunità di Agerola
Attualmente le Suore appartenenti alla comunità sono:
Sr. Maria Isabel Babo (Indonesiana) -
Ad Agerola le suore sono tra la gente una presenza fattiva e discreta, di conforto e a sostegno delle loro necessità fisiche, spirituali e familiari. Danno il proprio apporto nell’animazione domenicale della Liturgia e sono gli “angeli custodi” nella formazione dei ragazzi della città. Certamente la Regina del Rosario sorride compiacente per il singolare evento, vissuto dalle “Sue” Figlie, e il Beato Bartolo Longo gioisce per l’impegno di testimonianza evangelica intrapresa.
News da Agerola
x
La nostra casa di Busseto (Parma)
Regione -
Questa regione, abitata fin dall'antichità, ottenne una vera e propria organizzazione politica verso la fine del VI secolo, con l'espansione etrusca sulle rive del Po.
Importantissima per i suoi porti (Spina, Adria, Ravenna e Rimini), la regione vide fiorire molti centri urbani commerciali lungo la linea della Via Emilia, come Cesena, Modena, Parma, Piacenza e, sulle colline dell'alto corso del Reno, Misa (oggi Marzabotto).
All'inizio del IV sec. a.C., l'invasione celtica minò la prosperità della regione, e nel III sec. a.C., i Romani la acquisirono e la ordinarono in provincia insieme alla Liguria. In questo nuovo ordinamento, la regione ebbe un incredibile sviluppo; divenuta punto centrale dell'Italia di allora, fu anche teatro di grandi scontri militari: il passaggio del Rubicone da parte di Cesare, la guerra di Modena, la stipulazione del secondo triumvirato. Augusto ne fece la sua VIII regione, col nome appunto di Emilia, con i suoi importanti centri urbani come Forum Livii (Forlì), Forum Cornelii (Imola), Faventia (Faenza), bonomia (Bologna), Mutina (Modena), Regium (Reggio), Parma, etc... Nel V sec. d.C., Onorio trasportò la capitale a Ravenna (402), e la parte orientale dell'Emilia, che prese poi il nome  di Romania (Romagna), divenne il centro politico dell'Impero d'Occidente, ormai giunto al suo declino. Ravenna fu anche capitale dei Goti, sede dell'esarcato Bizantino. Con l'invasione longobarda (568), la regione fu divisa in due; da una parte Modena, Parma, Piacenza e Reggio, ducati longobardi, e dall'altra, da Ravenna a Bologna, città bizantine. Con i re carolingi (754-
di Romania (Romagna), divenne il centro politico dell'Impero d'Occidente, ormai giunto al suo declino. Ravenna fu anche capitale dei Goti, sede dell'esarcato Bizantino. Con l'invasione longobarda (568), la regione fu divisa in due; da una parte Modena, Parma, Piacenza e Reggio, ducati longobardi, e dall'altra, da Ravenna a Bologna, città bizantine. Con i re carolingi (754-
Il congresso di Vienna restaurò gli equilibri di potere e il dominio temporale della Chiesa, e la partecipazione degli emiliani ai moti risorgimentali fu estremamente intensa, attraverso congiure e operazioni militari. Fallito il tentativo di unirsi al Piemonte nel 1848, la fusione tra Emilia-
operazioni militari. Fallito il tentativo di unirsi al Piemonte nel 1848, la fusione tra Emilia-
Città
x
Fondazione della Casa di Busseto
x
Responsabile della Comunità di Busseto
Madre Nazarena Libonati
Comunità di Busseto
Attualmente le Suore appartenenti alla comunità sono:
Suor Maria Gilda Legaspino (Filippina) -
x
a nostra Casa di Camposano (Napoli)
Regione -
La Campania è una regione dell'Italia meridionale. Conta 5.701.931 residenti (censimento 2001 ed ha la più alta densità di popolazione tra le regioni italiane, ma è seconda dopo la Lombardia per numero totale di abitanti. Il suo capoluogo è Napoli. Confina a ovest, sud-
Città di Camposano -
Era uno dei sedici casali di Nola, alla quale fu soggetto non solo nel diritto civile, ma anche in quello ecclesiastico fino al XVII sec. , allorchè acquistò propria autonomia. La tradizione fa risalire l'origine di Camposano al tempo della seconda guerra punica, quando Annibale fu sconfitto dal console Claudio Marcello.
Controversa è la genesi del nome: alcuni la fanno derivare da Campus Jani, per la presenza probabile di un tempio dedicato al dio Giano, altri attribuiscono alla salubrità dei luoghi il toponimo.
Un momento di floridezza economica e culturale e segnato dalla costruzione della chiesa parrocchiale dedicata a S. Gavino e dalla realizzazione della strada principale. Da ricordare, inoltre, la piccola chiesa detta di S. Donato, nei pressi del luogo dove scorreva l'antico Clanio, ed il Palazzo Scotti in stile barocco.
Perchè le contrade?
Rivisitazione della memoria storica di Camposano o suggestiva lettura della leggenda oramai consegnata al mito delle origini del nostro comune, il “Palio” camposanese vuole rievocare la discesa di Annibale Barca, eroico condottiero delle armate dell’indomita città di Cartagine, nelle terre dell’Agro Nolano tra il 217 ed il 216 a. C.
La forza attrattiva del “Palio delle Contrade -
Il Palio del Casale, l'avvincente corsa su asini.
Manifestazione d'interesse: "Il Palio del Casale" "La corsa degli asini", organizzato dall'associazione socio culturale ISIDE.
Si tiene ogni anno nel mese di maggio. "ERMES" il mercatino dell'antiquariato, organizzato sempre dall'associazione ISIDE e si tiene nei giorni del Palio.Image:Provincia di Napoli-
Le ragioni del palio La causa per la conquista dell´indipendenza da Nola, da parte dei 16 Casali, inizia nel 1643. Quando il duca Carafa li vendette alla famiglia Mastrilli (A.S.N. Quinternione dei feudi. Repertorio III).
La lunga marcia che portò alla trasformazione dai Casali nella prima forma di Comune, perdurò per molti anni e si concluse nel 1767, allorquando fu intimato: "alli magnifici del Governo della Città di Nola ed esattore della tassa Catastale sottopena di 500 docati di non ardire a molestare i cittadini dei Casali, dovendo ogni casalese portare i pesi nella propria patria,, (cfr. Conti Comunali, a. 1787-
l'Associazione "Iside" rievoca quei momenti attraverso una gara con asini, che rappresentano i partecipanti alla festa tenuta nel Casale di Camposano per la libertà acquisita.
L'Iniziativa ha lo scopo di rivalutare l'asino, un animale ormai in via di estinzione, la storia dell'intera area Nolana e nello stesso momento proporre una seria riflessione sull´ambiente.
Il "Palio del Casale", quindi, rappresenta una sfida importante da affrontare con la certezza di realizzare qualcosa che non e´ solo folklore, ma che va oltre.
A questo è legato la possibilità di insediare all´interno del nostro territorio, piccoli allevamenti di asini, creando cosi occasione di lavoro e attività del tipo:
Opoterapia, ricreativa, Trekking per ragazzi, Attività didattiche per le scuole, Educazione ambientale, produzione di latte d'asina.
Camposano è un comune di 5.300 abitanti della provincia di Napoli.
Altitudine: 48 m.s.l.m.
Superficie: 3,22 km²
Abitanti: 5.389
Densità: 1767 ab./Km²
Frazioni: Faibano
Comuni contigui: Cicciano – Cimitile – Comiziano – Nola.
CAP: 80030
Pref. tel.: 081Codice ISTAT: 063013
Codice catasto: B565
Nomi abitanti: Camposanesi
Santo Patrono: San Gavino Martire
Giorno festivo: 25 ottobre
Come arrivare a Camposano
In auto
IL Comune di Camposano è situato a trenta chilometri da Napoli e a sole due miglia dalla città di Nola, è collegato ai maggiori centri della provincia dalla S.S. Variante 7 bis e dall'Autostrada A16 Napoli-
Camposano è coperto dal servizio di trasporto offerto dalla Circumvesuviana, sia con treni sulla linea Napoli-
L'aeroporto più vicino è Napoli -
Fondazione della Casa di Camposano
Camposano (22 febbraio 2004)
Un centro del Nolano, a circa 50 km da Pompei. Un sogno a lungo accarezzato: avere una comunità di Suore Figlie del Santo Rosario di Pompei.
Questo desiderio risale a diversi anni fa, quando il benemerito Mons. Carlo Polimene, figura di sacerdote molto impegnato nel sociale, divenuto parroco della Chiesa di San Gravino Martire, protettore del paese, realizzò a Camposano un’Opera destinata ad accogliere tutti i bambini della zona.
Nacque, così, una scuola materna parrocchiale.
In seguito, il complesso edilizio fu utilizzato per le attività ricreative e pastorali.
Nei parroci che successero a Mons. Polimene, tale aspirazione non si affievolì, anzi s’ingigantì e divenne più forte ed operativa, prima con Don Antonio Federico e dopo, con il trasferimento di questi a Scafati, con Don Umberto Sorrentino che è riuscito ad ottenere una piccola comunità di tre suore: Madre Irma Santarpia, Sr. M. Teresa Magpaio e Sr. M. Merceditha Quiblado.
Esse sono ospitate in un’accogliente casetta adiacente alla Parrocchia costruita ex novo, con sacrifici di giovani volontari, che hanno utilizzato con piacere il loro tempo libero per alcuni mesi.
Responsabile della Comunità di Camposano
Madre Irma Santarpia
Comunità di Camposano
Attualmente le Suore appartenenti alla comunità sono:
Sr. M. Angelina T. Pojadas (Filippina) -
(Indonesiana)
A Camposano le suore sono tra la gente una presenza fattiva e discreta, di conforto e a sostegno delle loro necessità fisiche, spirituali e familiari. Danno il proprio apporto nell’animazione domenicale della Liturgia e sono gli “angeli custodi” nella formazione dei ragazzi della città. Certamente la Regina del Rosario sorride compiacente per il singolare evento, vissuto dalle “Sue” Figlie, e il Beato Bartolo Longo gioisce per l’impegno di testimonianza evangelica intrapresa.
News da Camposano
x
La nostra casa di Casa Madre (Pompei)
Regione -
Città di Pompei
Sorge su un altopiano di formazione vulcanica, sul versante meridionale del Vesuvio, a circa 30 metri sul livello del mare ed a breve distanza dalla foce del fiume Sarno, in una suggestiva posizione, decantata in epoca romana anche da Seneca. La mancanza di sorgenti o corsi d'acqua sull'altopiano impedì il suo popolamento nelle epoche più remote, anche se nel corso dell' VIII secolo a. C. nella vicina valle del Sarno si erano formati alcuni insediamenti , come testimoniano numerose tombe a fossa.
La popolazione che fondò Pompei era sicuramente osca, ma è dubbio se il nome stesso della città derivi dal greco o dall'osco.
La fortuna della città fu sin dall'inizio legata alla sua posizione sul mare, che la rendeva il porto dei centri dell'entroterra campano, in concorrenza con le città greche della costa.
Naturalmente l'osca Pompei non poteva sottrarsi all'influenza greca, che si estendeva nel golfo di Napoli fino alla penisola sorrentina, includendo anche le isole di Capri e Ischia.
L'egemonia greca sulla costa campana venne però ben presto minacciata dall'avanzare prepotente di una nuova, formidabile potenza: quella degli Etruschi, che conquistò anche Pompei, risale infatti a quel periodo il Tempio di Apollo e le Terme Stabiane.
Contemporaneamente, però, dovette cominciare una lenta ma inarrestabile discesa delle popolazioni sannitiche provenienti dalle zone montane conquistando nel corso del V secolo a.C. tutta la Campania, ad eccezione di Neapolis e la unificarono sotto il loro dominio.
Pompei dovette subire notevoli trsformazioni urbanistiche ed architettoniche, nel compiere le quali i Sanniti non riuscirono a prescindere dall'influenza greca.
Finalmente, nel II secolo a. C. col dominio di Roma sul Mediterraneo che facilitò la circolazione delle merci, la città conobbe un periodo di grande crescita a livello economico, soprattutto attraverso la produzione e l'esportazione di vino e olio.
Questo stato di benessere si riflette in un notevolissimo sviluppo dell'edilizia pubblica e privata: furono realizzati in questo momento il Tempio di Giove e la Basilica nell'area del Foro, mentre a livello privato una dimora signorile come la Casa del Fauno compete per la grandezza e magnificenza.
La situazione economica restò florida per molto tempo e furono creati nuovi importanti edifici pubblici, come l'Anfiteatro e l'Odeon.
L'età imperiale si apre con l'ingresso a Pompei di nuove famiglie filoaugustee della quale sono un chiaro esempio l'Edificio di Eumachia e il Tempio della Fortuna Augusta.
Nel 62 d. C. un disastroso terremoto provocò gravissimi danni agli edifici della città; gli anni successivi furono impiegati nell'imponente opera di ristrutturazione, ancora in atto al momento della fatale eruzione del Vesuvio del 24 agosto del 79 d. C., quando Pompei fu seppellita completamente e definitivamente da una fitta pioggia di lapilli.
Fondazione di Casa Madre
La Comunità costituita da circa 80 membri è la più numerosa
La casa Madre è la “culla” della fondazione delle Suore Domenicane “Figlie del S. Rosario di Pompei” e, con ragione è considerata il “cuore” della Congregazione, sia perché è annessa al Santuario, luogo privilegiato ove troneggia l’Immagine taumaturga della Regina del Rosario, sia perché essa costituisce un punto di riferimento molto caro per ciascuna suora che, in particolari circostanze della vita quotidiana, vi trova serenità, conforto, ascolto dei propri problemi, essendo Pompei anche la sede abituale della Superiora Generale.
La comunità, con un pizzico di predilezione, è, inoltre, spettatrice di numerosi prodigi di grazia e di pietà mariana che, giornalmente, si verificano in questa terra benedetta, ingigantendo sempre più la figura del suo Fondatore, il Beato Bartolo Longo.
L’Uomo della Madonna, l’Apostolo ardente del rosario e della carità nelle sue molteplici forme.
Ma, quali sono i ruoli che le suore di Casa Madre svolgono? Essi sono numerosi e complessi, con un ritmo apostolico molto vario, sui generis.
C’è tutta una vasta gamma di persone che giornalmente ci interpellano nei nostri ambienti di servizio e di contatto: dalla nostra gioiosa presenza nel Santuario, attraverso l’animazione liturgica, alle suore che si trovano a dirigere il personale addetto alle cucine e alle lavanderie o che operano nelle sale e negli uffici amministrativi o, comunque, a contatto spirituale con le numerose anime che 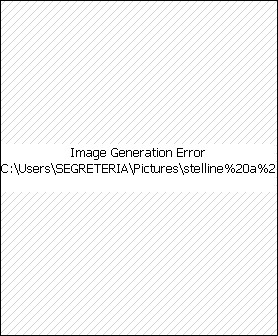 esprimono telefonicamente o in forma epistolare.
esprimono telefonicamente o in forma epistolare.
Casa Madre è il luogo ove annuLa Casa Madre è vicina alla casa della Madre divina. Una vista della casa con l'antistante piazzale Giovanni XXIII.almente si “riaccendono nuove stelline” di giovani vite che si consacrano all’Amore divino con la Professione religiosa, ed è anche il luogo ove, di tanto in tanto, nella linea della Volontà di Dio, si “spegne una candelina umana”, “guizzando” serenamente, dopo aver illuminato e testimoniato per tanti anni il Volto tenero dello Sposo divino e dell’Amico fedele: Gesù.
È davvero uno spettacolo edificante quello offerto dalle nostre suore anziane e dalle malate dell’infermeria! Esse sono serene, pur nel loro pesante carico di anni e di sofferenze, felici di svolgere un ruolo irrinunciabile in seno a tutta la nostra famiglia religiosa: essere “seme fecondo” per il germoglio e la vitalità spirituale di ciascuna sorella.
Le suore inferme pregano, amano, soffrono pazientemente. Con la corona in mano, elevano a Maria l’eterno canto della loro filiale riconoscenza e devozione.
Quali “novelle Mosè”, le sorelle meno giovani sostengono, con la loro fede e le loro continue implorazioni al Signore, le altre impegnate nelle complesse attività dell’Opera Pompeiana, facendone un “olocausto gradito a Dio”.
Accanto alla dimensione “preghiera”, le suore di Casa Madre hanno un ruolo particolare, specifico al servizio del Santuario della Regina del Rosario.
Bartolo Longo ribadisce a più riprese lo stesso concetto, nei riguardi delle “sue suore”: “Son dette figlie e non sorelle del Rosario, perché sono chiamate a vivere come altrettante figlie al servizio del Tempio. (Cost. B.L. 1900) – Un gesto di predilezione e di profonda fiducia del nostro Fondatore.
Il salesiano P. Adolfo l’Arco, nella biografia del nostro Beato, sottolinea: “Se la Basilica primeggia per lindore, il merito va, in gran parte, a queste figlie che curano con passione il decoro della Casa paterna”.
E le nostre suore, addette alla cura della Basilica e alla custodia degli arredi sacri, sono davvero ammirabili nella loro scrupolosa e delicata missione; lavorano con competenza, amore, femminilità; si rivelano “portatrici simpatiche” dell’amore alla Madonna e al Beato B. Longo.
Le nostre sorelle di Casa Madre sono presenti in tutti gli ambienti della Basilica, con un lavoro assiduo, scrupoloso, responsabile, paziente, di gioiosa testimonianza.
C’è tutta una folla di pellegrini devoti di Maria che le interpellano con le loro accorate preghiere, considerandole “fortunate sentinelle” della Vergine di Pompei.
Il contatto con il mondo intero prende, poi, gigantesche dimensioni in alcuni giorni o periodi dell’anno: nella festa della Supplica di maggio e di ottobre e nei mesi dedicati in modo speciale alla Mamma celeste.
Bartolo Longo nei suoi scritti sottolinea ed esalta la bellezza della nostra vocazione, dono fatto ad anime che Egli “pone a custodia del Santuario”.
Una missione molto delicata e che va assumendo forme sempre più grandi, è quella svolta dall’ufficio corrispondenza, un “filo rosso di carità” che intercorre tra molte devote di Maria e le suore di Pompei, mediante i mezzi che la società dell’oggi ci offre: il telefono e la corrispondenza.
Sono accorati appelli di madri, di spose, di figlie, che aprono il loro animo all’ ”amica suora”, sicure di riceverne una parola di conforto, di fede, di incoraggiamento, di speranza per un futuro migliore.
Chi ha avuto modo di essere protagonista di queste confidenze, proprio perché suora, ne è profondamente commossa.
Ecco alcuni stralci delle tantissime lettere giunte in segreteria:
● La mia modestissima penna non è capace di descriverle l’infinita gioia recatami dall’affettuosa, esauriente, bellissima lettera giuntami questa sera …
● Non abbandonarmi, carissima, perché dalle tue parole traggo la forza necessaria, la carica spirituale per andare avanti in quest’ultimo scorcio di vita … (ha 90 anni)
● Faccio fatica a scriverle, per l’età, ma il beneficio che ricevo dalla sua risposta, mi ripaga della stanchezza …
● Il conforto che ricevo dalle sue missive è così redditizio da ritemprare tutte le mie forze cadute in una prostrazione spaventosa …
● Sono molto pPompei, Cappella di Casa Madre.reoccupata del suo silenzio; mi manca quell’ossigeno indispensabile per la mia sopravvivenza …
● Sento nel cuore tanta tranquillità per le sue parole cariche di amore …
● Mia carissima amica, dolce mia consolatrice e sollievo, mi è gradito risponderle subito per esprimerle la mia intensa gratitudine per il suo biglietto meraviglioso, giunto fra i tanti regali del mio onomastico.
Ne sono rimasta commossa. Le sue parole, la sua fiducia nella Vergine irrobustiscono la mia fede quando vacilla e mi fa vedere tutto nero …
Voglio che lei sappia al più presto quanto mi renda felice la sua collaborazione nel chiedere alla Vergine la salute di mio figlio e quella pace in famiglia che attendo da anni.
Le sue parole incoraggianti agiscono in me alla stessa stregua di una medicina che ha il potere di calmare tanta ansia e di attutire la depressione che mi impedisce di riposare …
● La ringrazio e le sono grata per il coraggio che m’infonde: è un balsamo che non riesco a descrivere …
Certamente la Madonna che si serve di noi, piccole Sue figlie, per operare nell’animo di chi ha fede grandi cambiamenti spirituali.
Dal cuore s’innalza umilmente un “grazie” sincero nel comune sforzo di lavorare solo e sempre per la gloria del Signore e per il bene di tante anime assetate di pace.
Un ruolo particolare, infine, viene svolto da suore della nostra comunità, che si rivelano “grandi missionarie” pur restando nelle loro accoglienti cellette del monastero.
Tale nobile compito trova la sua fecondità sia attraverso una costante preghiera per le nostre case di missioni estere, sia con un certosino e fervido lavoro di iniziative varie e di collegamento con le altre comunità per sostenere anche materialmente le sorelle missionarie e le loro attività tra la gente del luogo.
La comunità di Casa Madre, come del resto anche le altre, con gioia, gratitudine e intensa partecipazione, vive le varie feste e ricorrenze che si susseguono in questo luogo benedetto nel corso dell’anno; sono celebrazioni che arricchiscono spiritualmente e rinsaldano gli animi attraverso anche i momenti di serena distensione e di agape fraterna.
Mi piace ricordare, fra le tante feste che si vivono a Casa Madre, quella della sera della Vigilia di Natale, una festa che ha sempre tanto fascino per tutte noi.
Si assiste allora ad uno spettacolo suggestivo. Il folto stuolo delle suore e delle novizie, con la paterna ed affettuosa presenza del Prelato di Pompei, è pronto con i flabeaux nel corridoio attiguo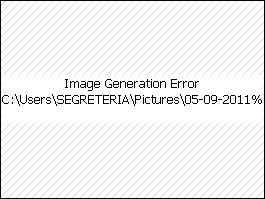 alla Cappella, in attesa che si avvii la processione con Gesù Bambino, portato tra le braccia dello stesso Vescovo.
alla Cappella, in attesa che si avvii la processione con Gesù Bambino, portato tra le braccia dello stesso Vescovo.
Si procede, cantando e pregando, lungo i corridoi, su per le scale del monastero, illuminato da molte luci, perché il Bambinello divino benedica le nostre stanzette e i vari punti della Casa. La sosta è più lunga nell’infermeria, ben addobbata per la grande solennità natalizia.
Sulla soglia di ogni stanza sono ad attendere le suore inferme, felici di essere protagoniste di un particolare sorriso del Bambinello e imprimere un caldo bacio sulla sua Immagine. Bello è il ritorno nel corridoio della Cappella.
Qui una “pioggia” di stelline illumina i volti sereni delle suore e fa vibrare ogni cuore di indicibile gioia, pregustando così lo spettacolo che, qualche ora dopo, si verificherà con l’attualizzazione del Mistero della Nascita, nel tempo, del Creatore del mondo. (Autore: Concetta Fabbricatore)
Casa Madre
Animate di Buona volontà…
La comunità di Casa Madre è la culla della nostra Congregazione, dove risiede la Madre Generale.
È composta da Suore giovani e meno giovani, tutte animate di buona volontà e si aiutano scambievolmente nei diversi uffici del Santuario e della Casa.
Ognuna dà il meglio di se stessa.
In questa bella comunità regna la pace, l’aiuto scambievole e tanto spirito di preghiera.
La corona del santo Rosario pende dalle mani delle nostre Suore; pregano la Madonna seguendo l’esempio del Fondatore. Il Beato Bartolo Longo diceva che le Suore sono le “figlie predilette” di Maria, le “custodi” del Santuario.
Nella nostra comunità le feste sono molto sentite
CONTINUA......................................................................
La Madre Generale -
Nona Madre Generale dal 2001, attualmente è al primo anno del suo secondo sessennio ...
La Rev. Madre Generale, Madre Angelica Bruno, nasce in Belmonte Calabro il 20/08/1942 da una famiglia di sani principi religiosi e come figlia unica, riceve tutte le attenzioni e le cure dei genitori che avevano progettato per lei un futuro certamente diverso da quello che si realizzò.
Suo Padre Antonio, consigliere comunale del suo paese e proprietario terriero, molto simile alla figlia nelle qualità caratteriali, tenero, saggio e austero, volle che la figlia, Angela, a 13 anni frequentasse la Scuola dell’Istituto Magistrale di Paola e fu lì che la giovane manifestò la sua intenzione di diventare suora.
La mamma, donna dal carattere concreto e deciso, sulle prime, non accettò questa sua decisione; provò anche a distoglierla da questo “desiderio” ma, forse, sottovalutò la forte determinazione che si celava dietro il sorriso amabile di sua figlia.
Tuttavia, successivamente, l’adozione di un figlio, mitigò in parte l’angoscia che questa “vocazione” aveva prodotto.
Madre Angelica entrò in Noviziato a 18 anni, i presupposti che avevano determinato l’ingresso nella vita religiosa, e l’ incontro che ebbe con Madre Immacolata, lavorando al suo fianco, evidenziarono in lei una maturità ed una serietà che la misero subito in luce come persona integra, trasparente e decisa a riuscire nella vita che aveva intrapresa secondo i modelli e gli stilo di vita di Santa Teresina di Lisieux, e di Madre Teresa di Calcutta.
Mentre si laureava in Pedagogia sognava spesso di seguire le orme missionarie di questa Santa dei nostri giorni, intanto divenne Superiora dell’Istituto Sacro Cuore, carica che mantenne fino a quando la Congregazione decise di aprirsi alle missioni estere.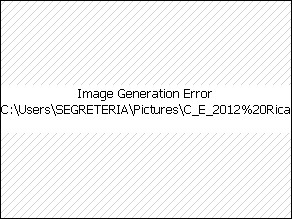 Fu la Prima a Partire 21 anni fa dopo aver conseguito la Laurea che aveva preso a pieni voti.
Fu la Prima a Partire 21 anni fa dopo aver conseguito la Laurea che aveva preso a pieni voti.
Lontana, nelle Filippine, in terra straniera, con una modesta conoscenza dell’inglese, dedicò tutta sè stessa per il bene della Congregazione e dei poveri.
Otto anni dopo, la ritroviamo in India per fondare un’altra missione, adoperandosi anche lì per gli altri, per i poveri.
Madre Angelica, in terra di missione ha cercato, secondo le direttive evangeliche, di insegnare a procurarsi da vivere più che dare il cibo.
Infatti, ha mantenuto e pagato le rette scolastiche a centinaia di ragazzi, sperando che un futuro diverso, poteva migliorare la vita dei giovani.
L’anno 2001 è stata eletta Madre Generale della nostra Congregazione, con l’esperienza missionaria e la mentalità aperta al mondo intero, la nostra famiglia religiosa cresce e si perfeziona nel carisma del Fondatore, il Beato Bartolo Longo, sotto il benevolo sguardo della Madre celeste.
Responsabile della Comunità di Casa Madre
Madre Natalia Todisco
Comunità di Casa Madre
Attualmente le Suore appartenenti alla comunità sono:
Sr.M.Ada Villani (Italiana) -
Attività nella Comunità di Casa Madre
x
La “voce” di chi ci conosce
Ecco la “VOCE” di chi ci conosce, di chi ci osserva e ci ammira, di chi loda l’attività, la preparazione, la profonda umanità e l’amore delle nostre Suore nella Casa Generalizia.
Ascoltiamola e confrontiamoci …
News da Casa Madre
Turni Esercizi Spirituali “Anno Domini 2010”
Casa Madre (12/17 Aprile -
La nostra Casa di Fidenza (Parma)
Regione -
Questa regione, abitata fin dall'antichità, ottenne una vera e propria organizzazione politica verso la fine del VI secolo, con l'espansione etrusca sulle rive del Po.
Importantissima per i suoi porti (Spina, Adria, Ravenna e Rimini), la regione vide fiorire molti centri urbani commerciali lungo la linea della Via Emilia, come Cesena, Modena, Parma, Piacenza e, sulle colline dell'alto corso del Reno, Misa (oggi Marzabotto).
All'inizio del IV sec. a.C., l'invasione celtica minò la prosperità della regione, e nel III sec. a.C., i Romani la acquisirono e la ordinarono in provincia insieme alla Liguria. In questo nuovo ordinamento, la regione ebbe un incredibile sviluppo; divenuta punto centrale dell'Italia di allora, fu anche teatro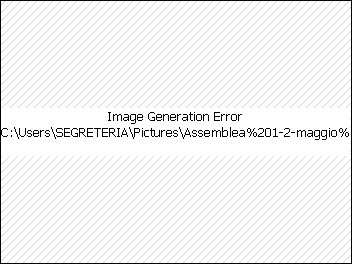 di grandi scontri militari: il passaggio del Rubicone da parte di Cesare, la guerra di Modena, la stipulazione del secondo triumvirato. Augusto ne fece la sua VIII regione, col nome appunto di Emilia, con i suoi importanti centri urbani come Forum Livii (Forlì), Forum Cornelii (Imola), Faventia (Faenza), bonomia (Bologna), Mutina (Modena), Regium (Reggio), Parma, etc... Nel V sec. d.C., Onorio trasportò la capitale a Ravenna (402), e la parte orientale dell'Emilia, che prese poi il nome di Romania (Romagna), divenne il centro politico dell'Impero d'Occidente, ormai giunto al suo declino. Ravenna fu anche capitale dei Goti, sede dell'esarcato Bizantino. Con l'invasione longobarda (568), la regione fu divisa in due; da una parte Modena, Parma, Piacenza e Reggio, ducati longobardi, e dall'altra, da Ravenna a Bologna, città bizantine. Con i re carolingi (754-
di grandi scontri militari: il passaggio del Rubicone da parte di Cesare, la guerra di Modena, la stipulazione del secondo triumvirato. Augusto ne fece la sua VIII regione, col nome appunto di Emilia, con i suoi importanti centri urbani come Forum Livii (Forlì), Forum Cornelii (Imola), Faventia (Faenza), bonomia (Bologna), Mutina (Modena), Regium (Reggio), Parma, etc... Nel V sec. d.C., Onorio trasportò la capitale a Ravenna (402), e la parte orientale dell'Emilia, che prese poi il nome di Romania (Romagna), divenne il centro politico dell'Impero d'Occidente, ormai giunto al suo declino. Ravenna fu anche capitale dei Goti, sede dell'esarcato Bizantino. Con l'invasione longobarda (568), la regione fu divisa in due; da una parte Modena, Parma, Piacenza e Reggio, ducati longobardi, e dall'altra, da Ravenna a Bologna, città bizantine. Con i re carolingi (754-
Il congresso di Vienna restaurò gli equilibri di potere e il dominio temporale della Chiesa, e la partecipazione degli emiliani ai moti risorgimentali fu estremamente intensa, attraverso congiure e operazioni militari. Fallito il tentativo di unirsi al Piemonte nel 1848, la fusione tra Emilia-
Città
x
Fondazione di Casa di Fidenza
Le nostre "Suore Domenicane di Pompei" presenti a Fidenza da più di quarant’anni.
Le Suore domenicane di Pompei sono conosciute come le Suore del “Vianello”, nome scaturito 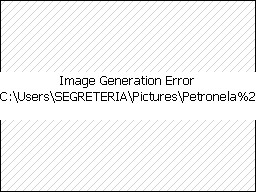 dall’attività educativa che svolgono nella Scuola dell’Infanzia e nella Scuola Secondaria di I° Grado “Mons. Vianello”.
dall’attività educativa che svolgono nella Scuola dell’Infanzia e nella Scuola Secondaria di I° Grado “Mons. Vianello”.
Le prime tre Suore giunsero a Fidenza il 16 settembre 1967 con la missione di educatrici dell’infanzia. Erano un dono di Mons. Gino Davighi, Amministratore delle Opere del Santuario di Pompei, alla sua città di Fidenza, egli sognava di offrire alla città distrutta dalla guerra un complesso educativo per i bambini e i ragazzi poveri. Scelse come sede dell’Opera la zona di Fidenza allora più povera, la zona periferica chiamata Corea.
Il sogno di Mons. Davighi si realizzò e affidò l’Opera alle Suore Domenicane di Pompei, esperte nell’attività educativa, le quali costruirono con grandi sacrifici la Scuola Materna, cui si aggiunse nell’84 la Scuola Media.
In poco più di qurant’anni, bambini e ragazzi educati alla Vianello si contano a migliaia e le Suore godono in tutta la città di stima, simpatia, affetto e riconoscenza per il loro lavoro educativo.
Attualmente la comunità religiosa è composta da 5 suore e da due novizie indonesiane.
Tutte le suore collaborano pastoralmente con la Parrocchia e partecipano a tutte le attività religiose e culturali del territorio.
Responsabile della Comunità di Fidenza
Madre Ermelinda Cuomo
Comunità della Casa di Fidenza
Attualmente le Suore appartenenti alla comunità sono:
Sr. M. Aurora Zorino (Italiana) -
-
x
News da Fidenza
Invito
La Superiora e la Comunità delle Suore "Figlie del S. Rosario di Pompei" (Via Pincolini,3 -
della loro presenza educativa a Fidenza e ti invitano: 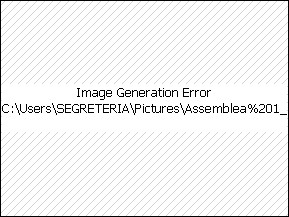
Martedì 29 Aprile 2008 -
● Commemorazione dei 40 anni di presenza delle Suore a Fidenza (Mons. Aldo Aimi)
● Proiezione di fotografie dei 40 anni di attività a Fidenza
Giovedì 8 Maggio 2008 -
● Santa Messa di ringraziamento presieduta dal Vescovo di Fidenza Mons. Carlo Mazza
● Momento conviviale nel parco dell'Istituto
"Per l'educazione dei ragazzi io seguo la voce del cuore ... Il mio maestro è Cristo!" (Bartolo Longo)
La nostra Infermeria di Casa Madre (Pompei)
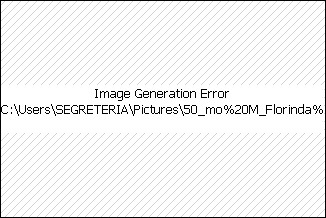 Responsabile della Comunità di Casa Madre
Responsabile della Comunità di Casa Madre
Madre Raffaelina Vitiello
Comunità di Casa Madre
Attualmente le Suore appartenenti alla comunità sono:
Sr. Maria Ausiliatrice Somma (Italiana) -
Attualmente le Suore inferme sono:
Sr. M. Eugenia Grasso (Italiana) -
Attività nella Comunità dell'Infermeria
x
News dall'Infermeria
x
La nostra Casa di Macerata Campania (Caserta)
Regione -
La Campania è una regione dell'Italia meridionale. Conta 5.701.931 residenti (censimento 2001 ed ha la più alta densità di popolazione tra le regioni italiane, ma è seconda dopo la Lombardia per numero totale di abitanti. Il suo capoluogo è Napoli. Confina a ovest, sud-
Città -
Macerata Campania è un paese della provincia di Caserta.
Logisticamente è situato nel triangolo Caserta -
Macerata Campania, oltre al comune capoluogo, comprende le frazioni di Caturano e Casalba.  Un altro luogo che ha fatto parte del territorio di Macerata è stato Cuzzoli, villaggio misteriosamente scomparso a metà del XVIII secolo.
Un altro luogo che ha fatto parte del territorio di Macerata è stato Cuzzoli, villaggio misteriosamente scomparso a metà del XVIII secolo.
La sua superficie si estende su 7,63 Km2 ed il suo numero dei presenti sfiora i 10000 abitanti. Battiglia di Pastellesse4 -
La sua storia è di difficile lettura per la scarsità delle fonti, si confonde infatti con quella della antica Capua, corrispondente all'attuale Santa Maria Capua Vetere, essendo stato casale di quest'ultima per lunghissimi secoli. Di qui la storia di una popolazione etrusca prima, osco-
Storia, spessissimo, di saccheggi, di distruzioni, scempi, in buona parte riconducibile a quella sua topografia, in prossimità della Regina Viarum (via Appia) e lambita dalla via Atellana.
Anche per questo, il prof. Pasquale Capuano insiste sulla radice etimologica del verbo macero, da cui deriverebbe il nome Macerata, nel significato non tanto riferibile alla coltivazione della canapa (la denominazione Macerata è stata da noi reperita in epoca molto anteriore all'epoca di S. Stefano Minicillo, epoca in cui non vi era alcuna coltivazione di canapa), quanto al sofferto senso di rovina, di demolizione a quel verbo conferito da Orazio, Cicerone, Livio, Varrone.
Sin dal secolo XI si attesta la presenza di Macerata nella Terra dei Lanei (Terra dei Lagni), uno dei distretti che componeva il territorio di Capua.
Secondo varie fonti si può ritenere che il nucleo cittadino sia sorto due secoli prima, non prima dell'anno 841, anno in cui Capua romana fu distrutta dai Saraceni.
Denominata dal 1862 Macerata di Marcianise, si chiamerà Macerata Campania dal 1946 a seguito della soppressione del comune di Casalba, il quale ha avuto una vita al quanto breve (dal 1 gennaio 1929 al 30 giugno 1946) e comprendeva l'odierna Macerata Campania e l'odierna Portico di Caserta.
Di sicuro fascino è la chiesa dedicata a San Martino Vescovo.
In mancanza di documenti certi si deve ritenere che la chiesa possa essere sorta prima dell'anno 688, anno del rinvenimento del corpo di S. Rufo, in loco Macerata Campania, secoQui nacque S. Stefano Minicillondo come afferma lo storico G. Iannelli, comunque prima del 935, anno di nascita del santo maceratese Stefano Minicillo, che proprio nella chiesa del suo villaggio apprese le prime nozioni della fede che l'avrebbe portato agli onori.
Tra le figure d’ abati che hanno retto la chiesa di San Martino Vescovo, nel corso dei secoli, un posto di rilievo spetta al capuano Francesco d'Isa, parroco di Macerata Campania per alcuni decenni durante il XVII secolo, il quale la restaurò dalle fondamenta.
Nel corso degli anni la chiesa ha subito continui cambiamenti, fino ad arrivare a quella di oggi.
La festa più importante e amata dai maceratesi è quella dedicata a Sant'Antuono, meglio noto come Sant'Antonio Abate, che ricorre ogni anno il 17 gennaio.
Nei giorni che precedono e susseguono questa data si organizza la sfilata delle "battuglie di pastellesse", le cui origini si perdono nel tempo.
Gruppi di uomini su carri addobbati suonano a percussione strumenti agricoli, creando dei ritmi travolgenti, dai significati lontani e profondi, che trasmettono la forza delle radici contadine, della vita nei suoi significati più forti.
L'amore, il sesso, il rapporto con la terra -
Fondazione della Casa di Macerata Campania
Nuova Casa delle Suore Domenicane di Pompei a Macerata Campania (Ce)
L’Arcivescovo di Capua, Mons. Bruno Schettino, Lunedì 5 maggio 2008, ha benedetto a Macerata Campania, in provincia di Caserta, la nuova casa delle Suore Domenicane di Pompei.
Alla celebrazione, animata dalle Novizie della Congregazione nel cortile dell’Istituto, e seguita da un momento di festa, erano presenti, oltre a numerosissimi fedeli, guidati dal parroco don Gianfranco Boccia, la Superiora Generale, Madre Angelica Bruno ed il Sindaco Dott. Luigi Munno.
La casa fu donata dal signor Tommaso Nacca, cittadino di Macerata Campania, alcuni decenni fa perché fosse destinata ad accogliere le religiose impegnate nella cura dei fanciulli più poveri della cittadina.
L’Istituto è stato intitolato al Beato Raimondo da Capua.
Frate Domenicano e Maestro Generale dell’Ordine dei Predicatori, nato nel 1330 circa a Capua, elevato agli onori degli altari da Papa Leone XIII nel 1899, fu direttore spirituale e confessore di Santa Caterina da Siena, Terziaria Domenicana, Dottore della Chiesa e Patrona d’Italia.
Mancava nell’Archidiocesi di Capua, che ha dato i natali a così illustre personaggio, una struttura a lui dedicata ed è grazie all’interessamento del parroco, alla benevolenza dell’Arcivescovo e della Superiora Generale della Congregazione, che si è potuto concretizzare con un segno così speciale il ricordo di un grande uomo di spirito che ha illuminato la storia della Chiesa.
Macerata Campania
L’apertura della comunità di Macerata che risale a fine anno 2006 ha procurato non pochi interrogativi da parte delle Suore. Perché Macerata Campania? Perché aprire in questo momento dove ogni casa sente il bisogno di avere più elementi per coprire tante mansioni scoperte? Perché “sprecare” energia, tempo in questo paese sconosciuto? Sono interrogativi che a prima vista sono giusti, ben pesati e che aspettano delle risposte.
In Parrocchia
Pensiamo e ragioniamo un poco insieme: se noi ci atteggiamo a persone che pensano solo al lavoro da fare, ad un impegno da svolgere, allora tutte queste domande hanno ragione d’essere perché è vero che tante suore coprono due, tre uffici per far andare al meglio ogni cosa.
Ma se guardiamo oltre, se ci pensassimo un poco in più, e se scavassimo in profIn Parrocchia ogni qualvolta vi è una occasione di incontro le Suore sono presenti.ondità, il verbo andare ha una connotazione evangelica: “Andate, predicate…” non solo con parole ma con la vita. Ogni cristiano, ogni consacrato è chiamato ad andare, ad uscire, prima dal proprio guscio e dai propri parametri mentali, poi fuori per poter incontrare gli altri, per crescere, per maturare, non necessariamente varcare i confini nazionali.
San Domenico a proposito del suo “rischiare” circa il “mandare” a due i giovani frati del suo tempo, diceva: “Il grano che si ammucchia, ammuffisce, mentre quello seminato, cresce, si moltiplica”.
Dove Cristo ci chiama, là andiamo. Lo Spirito santo soffia come vuole e quando vuole. Sicuramente, le Madri hanno sentito quel “mormorìo” per aver avuto l’audacia e il coraggio di dire sì all’inviato. Poi  ogni posto è una valle di Maria, ogni dove è un terreno del Signore. Tutto appartiene a cristo. Siamo gli strumenti suoi per arrivare ai fratelli, quindi, possiamo dire con Madre Teresa: “Signore, hai bisogno delle mani, ecco le mie. Hai bisogno dei miei occhi… dei miei piedi… del mio sorriso… eccomi, Signore.”
ogni posto è una valle di Maria, ogni dove è un terreno del Signore. Tutto appartiene a cristo. Siamo gli strumenti suoi per arrivare ai fratelli, quindi, possiamo dire con Madre Teresa: “Signore, hai bisogno delle mani, ecco le mie. Hai bisogno dei miei occhi… dei miei piedi… del mio sorriso… eccomi, Signore.”
Come tutte le nostre comunità, anche noi contribuiamo con quel poco che sappiamo fare per portare qui a Macerata il carisma del nostro Fondatore. Innanzitutto, curiamo e coltiviamo il nostro essere consacrate attraverso la preghiera assidua, la meditazione, la lectio divina, la vita in comune, la gioia di appartenere a cristo.
Da qui scaturisce il nostro operare.
Le nostre attività primarie sono: il catechismo, l’animazione liturgica,, la cura della Chiesa, portare la comunione ai malati. Poi offriamo diversi corsi: il doposcuola, il corso di chitarra, il ricamo, di inglese. Abbiamo diversi gruppi: i ragazzi, l’azione cattolica-
La settimana è scandita da tutte queste attività. Molte volte la giornata finisce a tarda sera per gli incontri che si possono fare a quell’orario. Non sembra vero ma gli impegni sono tanti. Gli orari della comunità devono adeguarsi continuamente. Perciò si presuppone un certo equilibrio, maturità e elasticità.
Con l’aiuto di Dio e la mano guida della Madonna, portiamo avanti questa missione con fiducia, libertà di cuore e gioia sapendo che Gesù è con noi e che dietro alle nostre spalle, c’è tutta la Congregazione che ci sostiene con preghiere ed affetto come noi per essa.
Durante la benedizione della nostra comunità di Macerata Campania il 5 maggio 2008, non tutte le nostre consorelle hanno potuto partecipare e perciò ho pensato di far pubblicare le foto per far conoscere loro sia la struttura, sia le attività che la comunità svolge in questa Parrocchia di dodicimila abitanti.
La casa dista cento metri dalla parrocchia ed è molto frequentata da persone di ogni età, classe sociale e razza.
È qui che si fa il catechismo, corso biblico, corso di chitarra, corso di ricamo, corso di inglese, riunioni, feste, ritiri, prova di canti per la liturgia, ecc.
Ogni gruppo trova il proprio posto, lo spazio necessario per poter svolgere la propria attività.
Le Suore sono impegniate in tutti i campi in collaborazione con tanti laici che veramente prendono a cuore il proprio impegno. Naturalmente questo grazie al nostro parroco che con passione,, dedizione ed abnegazione va incontro a tutte le necessità di questo piccolo gregge. Egli si “consuma” per la chiesa, sua sposa.
ed abnegazione va incontro a tutte le necessità di questo piccolo gregge. Egli si “consuma” per la chiesa, sua sposa.
Entriamo ora nella casa dove troviamo subito la cucina. Al fianco c’è la sala da pranzo che funge anche come un piccolo salotto e dove si passa per accedere alla minuscola cappella.
Dalla cucina si sale nella clausura dove troviamo un salottino-
Responsabile della Comunità di Macerata Campania
Madre Monica B.Tibog (Filippina)
Comunità di Macerata Campania
Attualmente le Suore appartenenti alla comunità sono:
Sr.M.Bernaditta Kuriyappilly (Indiana) -
A Macerata Campania le Suore sono tra la gente una presenza fattiva e discreta, di conforto e a sostegno delle loro necessità fisiche, spirituali e familiari. Danno il proprio apporto nell’animazione domenicale della Liturgia e sono gli “angeli custodi” nella formazione dei ragazzi della città. Certamente la Regina del Rosario sorride compiacente per il singolare evento, vissuto dalle “Sue” Figlie, e il Beato Bartolo Longo gioisce per l’impegno di testimonianza evangelica intrapresa.
News da Macerata Campania
x
La nostra casa di Maiori (Salerno)
Regione -
La Campania è una regione dell'Italia meridionale. Conta 5.701.931 residenti (censimento 2001 ed ha la più alta densità di popolazione tra le regioni italiane, ma è seconda dopo la Lombardia per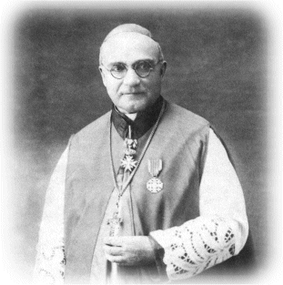 numero totale di abitanti. Il suo capoluogo è Napoli. Confina a ovest, sud-
numero totale di abitanti. Il suo capoluogo è Napoli. Confina a ovest, sud-
Città -
Maiori è un comune di 5.745 abitanti della provincia di Salerno, situato sul Golfo di Salerno a metà strada tra Amalfi e Salerno.
L'Unesco ha dichiarato dal 1996 Maiori, assieme alla Costiera amalfitana, Patrimonio dell'Umanità.
Le origini della città risalgono al periodo degli etruschi. Dal secondo dopoguerra Maiori ha registrato una notevole espansione urbanistica e vanta uno dei migliori tenori di vita della Campania.
Profilo Storico
Lo storico locaVista dall'alto di Maiori e di parte della sua spiaggiale F. Cerasuoli ipotizza che Maiori potrebbe essere stata l'antica città estrusca di Cossa, traducibile in Boxa o Possa, e latinizzata successivamente in Posula, primo centro della città poi divenuto un suo villaggio, l'attuale contrada di S. Pietro in Posula dove tra l'altro era un tempio dedicato al dio etrusco Vertumno distrutto dagli abitanti della città nel IV d.C. con l'avvento del Cristianesimo.
Infine da citare l'ipotesi (A. M. Fresa), non in contrasto con quella del Cerasuoli, che Maiori fosse stato il rifugio dei superstiti dell'antica e prestigiosa città etrusca di Marcinna (molto probabilmente l'attuale Vietri sul Mare), distrutta da un cataclisma alluvionale o da un saccheggio, e che la tradizione tramandata per generazioni della loro indiscutibile perizia nautica sia divenuto, dieci secoli dopo, uno dei presupposti fondamentali per la fondazione della prima Repubblica Marinara d'Italia.
Maiori è quindi ritenuta, per consolidata tradizione storiografica, di antichissime origini risalenti agli Etruschi proprio per la desinenza "inna" di chiara derivazione Osca dell'antico nome Reghinna.
Durante i secoli IX e X, allorquando la Repubblica Amalfitana visse il periodo di più grande splendore Maiori fu sede di numerosi arsenali e dell'Ammiragliato, nonché della Dogana e del Fondaco del sale.
Negli arsenali repubblicani di Maiori sarebbe stato dato per la prima volta il nome di Tramontana al vento freddo spirante dal Nord, dalla valle del limitrofo comune di Tramonti. Per secoli questo nome fu dipinto sulla Rosa dei Venti dagli amalfitani a cui è data la paternità della bussola. Gli arsenali di Maiori continuarono la loro attività anche dopo la caduta della Repubblica amalfitana e costruirono navi anche per il reame di Napoli.
Maiori ha goduto nel corso dei secoli di numerosi attestati e privilegi da parte di Re e Pontefici dell'epoca tra cui vanno menzionati: il titolo di <<Città Regia>>, del quale venne insignita da Re Filippo IV di Spagna nel 1662 e il titolo di "Insigne Collegiata", tuttora riconosciuto, con cui venne insignita dal Pontefice Giulio II nel 1505 l'allora Basilica, sede di Rettoria, di S. Maria a Mare.
Infine è doveroso citare due rovinose alluvioni di questo secolo: la prima del 24 ottobre 1910 che distrusse il lato nord-
Dopo quest'ultima catastrofe la ricostruzione della città, realizzata in assenza di un piano regolatore generale e lasciando spazio ad uno sfruttamento a volte intensivo del territorio, fa assumere a Maiori l'aspetto odierno.
Dopo la seconda guerra mondiale, nel periodo del neo-
Fondazione di Casa di Maiori
Le origini del Monastero
Egli è indubitato, che lo spirito religioso degli antichi abitatori di Maiori era comune a tutte le classi de’ cittadini, e tutte ne davan prove con opere apparenti; fondando ivi tante antiche chiese, edicole, monisteri, ospedali ed altre insigni opere di pietà cristiana.
Quivi i ricchi si spogliavano chi per edificare templi sacri e chi per impinguare la lor insigne Collegiata, i Canonici ed i Curati, di prebende e di beneficj competenti; ed i non ricchi, avendo a cuore la salvezza delle anime loro, lasciavano alle chiese copiosi legati di messe “pro redemptione animarum suarum”.
Siffatto religioso zelo ed entusiasmo, ispirò nell’animo del Dottor fisico Luca Staibano, il pio divisamento di dar mano alla fondazione di un ritiro muliebre di religiose francescane, sotto il titolo della “Pietà”.
Ma venutone trattenuto nell’esecuzuione a causa d’infermità sopraggiuntagli, lasciò nel suo testamento (rogato al 27 settembre 1515) affidato al Comune di Maiori l’affettuazione di tale suo pio desiderio, e così disponendo; “Item, io predetto messer Luca Staibano lasso tutto et integro edificio di case con giardino, sito et posto in la Terra di Majuro, et proprie in contrata S. Joannis de Campulo subtus et supra cum apothecis, iuxta bona quod Antonelli de Ponte, viam vicinalem, iuxta viam publicam, et alios confines; Universitati Terrae Maiori etc.
Ita quod Universitatis ipsa teneatur suis sumptibus et expensis ordinare, costruire, facere Monasterium de dicto edificio de Donne de l’ordine di S. Francesco de Observantia ecc.” (Camera, M.Memorie storico-
L’origine della casa risale al 1515, più precisamente al 27 settembre di quell’anno, quando cioè Luca Stajbano scrisse nelle volonUna veduta del Monastero in un'antica Cartolina.tà testamentarie di voler lasciare tutto, casa e giardino in terra di Maiori a favore del progetto di fondare un Monastero di monache clarisse francescane, “dopo la morte di Carmosina sua sorella, in termini di anni due, et quando in detto termine la Università non lo facesse, che sia dell’Erede”.
Più in particolare, “Il dottor medico Luca Staibano, con mistico testamento, consegnato al notajo Giovan- giardini, sita ivi di fronte alla chiesa di San Giovanni in Campolo; a condizione che fra due anni, a contare dal decesso della di lui sorella Carmosina, cui degli anzidetti fondi riservò l’usufrutto, a sue spese, la legataria vi fondasse un monastero di donne nobili, dell’ordine di San Francesco “Observàntino”; in cui avrebbero diritto di professare senza dote, le discendenti da Gerbino Staibano, e di essere preferite al badessato”.
giardini, sita ivi di fronte alla chiesa di San Giovanni in Campolo; a condizione che fra due anni, a contare dal decesso della di lui sorella Carmosina, cui degli anzidetti fondi riservò l’usufrutto, a sue spese, la legataria vi fondasse un monastero di donne nobili, dell’ordine di San Francesco “Observàntino”; in cui avrebbero diritto di professare senza dote, le discendenti da Gerbino Staibano, e di essere preferite al badessato”.
L’anno successivo, il 1° giugno, il sindaco ser Vincenzo Mardina”stipulò coll’erede del testatore, e cogli altri allora in vita nipoti di Gerbino, la esecuzione del legato: ed appena trapassata la usufruttuaria, la Università diè mano all’opera, e la completò nel 1520”.
Ma il Camera scrive: “Più tardi, al cominciar del mese di ottobre 1519, fu dato mano alla fabbrica, con disegno, e direzione del capo maestro muratore Onorato De Marino di Cava, la quale fu poi del tutto compiuta nell’anno 1530.
Ma un secolo dopo il locale ebbe a patire grave danno per un incendio casualmente ivi avvenuto nell’anno 1670 – In tale accidente, andarono consumati dalle fiamme un gran quantitativo di vasi sacri di argento, con altre ricche suppellettili appartenenti all’insigne Collegiata, che precedentemente, a causa che quella prevostale chiesa stavansi allora restaurando.
Come si può chiaramente notare vi è una discordanza di date in merito all’inizio e fine dei lavori di costruzione del monastero nei due autori: Camera e Cerasuoli. Il primo afferma che l’opera fu costruita dai primi di ottobre del 1519 all’anno 1530; mentre F. Cerasuoli ritiene che fu completata nel 1520 ed iniziata dopo la morte di Carmosina, della quale non riporta la data del decesso.
Il Cerasuoli annota, per chiarire un frainteso che andava diffondendosi forse all’epoca passata, che a Luca Staibano non si deve la costruzione del monastero perché il buon medico dispose che i beni da lui lasciati fossero destinati alla costruzione dello stesso e di ciò veniva incaricata la Università. Infatti ciò lo dimostra il titolo di fondazione che segue tratto integralmente dal testo di Cerasuoli e riportato con la lettera “Q” nella sezione “documenti”. (Autore: Mario Rosario Avellino)
Titoli di fondazione del Monastero delle Clarisse
Da cui consta, che ne fu fondatrice la Università
In Dei nomine, Amen – Die XXVII mensis Septembris,quartae Indictionis 1515. Majori – Testamentun clausum eximij et excellentis domini Luce Staybani de Majoro, quod valere voluit etc. – Et quia caput et principium cujuslibet testamenti ac dispositionis est eredi institutio, propterea etc. (Tra i molti legati)
Item lo predetto messer Luca Staybano lassa tutto integro lo hospitio di case e Jardini sito e posto in la Terra di majori, et proprio in contrada S. Joannis de Campulo suptus et supra cum Apotecis, juxta bona Nicolai Cimmini, juxta bona heredum quomdam Antonelli de Ponte, juxta viam vicinalem, juxta viam publicam, et alios confines, Universitati terre Majori, me Notario etc. ut insuper Universitas ipsa teneatur suis sumptibus, et expensis, ordinare, construere, et facere Monasterium de dicto edificio, de Donne de lo ordine di S. Francesco observantino, dopo la morte di Carmosina sua sorella, in termini di anni due, et quando in detto termine la Università non lo facesse, che sia dell’Erede.
Verum che durante la vita de detta Carmosina sia usufruttuaria de detti Case, Jardini, et Apoteghe, et non ne possa essere ammossa.
Cum declaratione, che essendo alcuna persona de Casa Staybano, lo quale fosse de famiglia, possa entrare in detto Monasterio a farese Monaca, senza pagare cos’alcuna, et vacando lo loco de lo abbatessato, et essendoce donna Monaca in detto Monasterio de Casa Staybano, se debba creare Abbatessa detta donna, senza contrarietà de le Monache, et Università, ita che eligendosi altra Abbatessa, non censeatur Abbatessa sub Maledictione Eterna.
“Dagli originali rogiti di not. Gio Luise Cinnamo di Majori, protoc. 1515 – 1516. Fol. 10 e 150, che da noi si conserva; dei quali rogiti un estratto trovasi depositato nel protoc. Del rid. Not. Franc. Ant. Venosi, dell’anno 1746, fol. 301”.
“Eodem die primo mensis Junii millesimo quingentesimo decimo sexto quarte Indictionis qui antecedens est Majori ejusdem ibidem. In nostri presentia personal iter costituti Nobiles Vincentius de Mandina, Sindicus, Andreas Russi, Cosmus de Ponte, et Joannes Franciscus Oliva, Electi ad infrascripta omnia per Universitatem et nomine Terre predicte etc. sponte asseruerunt coram nobis, et magnifico U.J.D. Domino Alexandro Staybano sui fratis consanguinei, et domino Raimundo Staybano, A.M-
Proinde dicti nobiles Sindicus et Electi acceptando dictum legatum, promiserunt et obligaverunt construere et edificari facere dictum Monasterium, et in infinitum ac in perpetuum admittere in illo feminas de familia Staybano descendentes tam a predicto domino Alexandro, et aliis supra expressis, quam a quibuscumque aliis descendentibus a quondam Gerbino Staybano eorum progenitore, et ideo obligaverunt se ipsos, et Universitatem predictam, et bona ipsius, corumque erede et successores ad poenam dupli etc. constitutione precarij etc. renunciaverunt etc. et juraverunt etc. – Presentibus – Joanne de Ponte Judice ad contractus – Petro Antonio Apicella – Petro Andriano Pisano – marcho Infornusio – Chlemente Roppolo – Sinnobile Infornusio – Marzullo Apicella.
Dunque il dottore Staibano fu il precursore dell’idea ed anche il primo e principale, fautore dell’opera.
Fu così eretto il monastero sotto il titolo “Santa Maria della pietà”. Le Suore adottarono la regola francescana di S. Chiara eletta a “patrona, insieme all’evangelista S. Luca, in memoria del benefattore, ad una ed agli altri dicatene la primitiva chiesetta”.
Fu denominato “Monasterium S. Lucae seu Pietatis ordini S. Francisci Observantiae”. Cioè i Superiori responsabili di questo Monastero erano i Padri dell’Osservanza. Tant’è che era soggetto a visite del Padre Provinciale, il quale andava periodicamente a verificare che si osservasse la regola adottata.
Fu osservata la più stretta clausura.
Talvolta il Monastero viene semplicemente citato come di “S. Luce alias La Pietà”.
Intanto al convento furono ammesse alla vita religiosa coriste-
L’aumento delle Suore indusse all’ampliamento della chiesetta che fu, altresì, abbellita ed arricchita di “marmi affreschi e tele, di splendidi arredi, paramenti e suppellettili”.
Dal punto di vista economico il monastero si reggeva, tra l’altro, con i proventi delle botteghe rimaste fuori dal chiostro, oltre che con le doti delle fanciulle che avevano scelto la vita religiosa.
Stando al racconto dello storico Cerasuoli, il convento ebbe vita florida con vocazioni di provenienza da famiglie nobili per circa tre secoli, finchè alla vita monastica dovettero ammettere anche fanciulle del ceto medio, per mancanza di vocazioni e ciò per evitare una chiusura della casa.
Si giunge così al 1865 data di pubblicazione del volume di Filippo Cerasuoli in cui l’autore annota che il convento “così modicamente rimesso, sussiste odiernamente”.
In questo periodo, con la soppressione dei patrimoni degli Enti Ecclesiastici, tutti i beni degli stessi passarono allo Stato (Legge-
Più tardi, l’immobile fu concesso in enfiteusi al Comune di Maiori che si obbligava a corrispondere un censo di £. 1000 annue.
A sua volta, il Comune, si impegnò a versare £. 900 e di far pagare alle religiose la rimanente parte di £. 100.
Avvenne così che il “convento si estinse nel secolo scorso a seguito delle leggi eversive”, non solo, ma anche per mancanza di vocazioni.
Vale la pena, a questo punto riportare una sintesi della storia del Monastero della Pietà che stralciamo da un atto conservato nell’archivio del Municipio di Maiori (Casella 13 Anno 1875 – Numero 3), avente per oggetto: “Monastero della Pietà. Titoli di transazione e cessione”, redatto davanti al Notaio Filippo Cerasuoli di Maiori.
REGNO D’ITALIA
VITTORIO EMANUELE SECONDO
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÁ DELLA NAZIONE
RE D’ITALIA
A TUTTI I PRESENTI E FUTURI SALUTE
NUMERO PRIMO DEL REPERTORIO
REGNO D’ITALIA
NEL GIORNO PRIMO DEL MESE DI GENNAIO
DELL’ANNO MILLEOTTOCENTOSETTANTACINQUE
REGNANTE
VITTORIO EMANUELE SECONDO
PER GRAZIA DI DIO, E PER VOLONTÁ DELLA NAZIONE
RE D’ITALIA
Dinanzi a noi Filippo Cerasuoli del fu Andrea, Notajo residente in questo Comune di Majori, assistito dagli infrascritti testimoni, si sono spontaneamente costituiti.
Il signor Francesco Ricciardi del fu Signor Nicola, Ricevitore del Demanio e Tasse dell’Ufficio di Amalfi, ove domicilia, rappresentante la Direzione Generale del Demanio, ed insieme anche L’Amministrazione del Fondo del Culto.
E il Signor Francesco Conforti del fu Signor Giuseppe, Sindaco rappresentante il Municipio di questo preindicato Comune di Majori, possidente ivi domiciliato.
A rispettiva richiesta dei quali, entrambi ben noti agli assistenti testimoni ed a noi, abbiamo rogato l'infrascritto contratto.
Il Sindaco Signor Conforti ha opportunatamente premesso la seguente narrativa.
Mercè di testamento chiuso, che ora dicesi segreto, in data ventisette di Settembre mille cinquecento quindici, aperto, pubblicato, e presso il Notajo Giovan-
Consistente in casamento sottano e soprano, con giardini e botteghe, dal testatore stesso descritta in questi precisi termini “lassa tutto integro lo hospitio di case con giardini raptus e supra cum apotecis”.
Imponendo alla legataria Università, dovere a sue spese costruire, e formare dei fondi legati un Monastero di donne dell’ordine Osservanti di san Francesco, nel corso di due anni susseguenti la morte di Carmosina, sorella di esso testatore, usufruttuaria dei fondi medesimi: a condizione, che sempre quando vi si farebbero monache della di lui famiglia Staibano, nulla dovrebbero pagare; e che in ogni vacanza del Badessato, se vi esistesse monaca della stessa famiglia, dovrebbe crearsi Badessa, senza potervisi opporre la Università.
Con istrumento del primo di Giugno mille cinquecento sedici, pel medesimo Notar Cinnamo, la Università venne riconosciuta legataria degli eredi del testatore Luca Staibano, e da tutti gli allora esistenti interessati della di costui famiglia; ed in nome di essa Università, il Sindaco e gli Eletti accettarono il legato, e giusta il medesimo promisero, e si obbligarono edificare il divisato Monastero; ed in perpetuo ammettervi le donne discendenti della prefata famiglia Staibano.
Defunta Carmosina, fra i sussecutivi due anni la Università convertì in forma claustrale il casamento, vi edificò la chiesa ed il parlatorio, comprese nella clausura i giardini e ne compose l’ordinario Monastero; per di cui rendita rimase le botteghe coi loro accessori, come parte esterna, non efficiente la clausura stessa: ma per rendere questa d’altronde indipendente, dovette comprare ed incorporarvi i confinanti beni di Nicola Cimini e degli eredi di Antonello De Ponte.
Così ne formò un isolato quadrilatere, chiuso da alte mura, qual è tuttora; confinato nel lato di oriente dalla grande strada Reginna, d’onde ha l’accesso nel lato settentrione, del vicolo Pasè; nel lato di occidente dall’altro vicolo Monastero; e nel lato meridionale dalla strada campo.
Nei quali confini circoscritto, parte interna ed esterna formanti un sol corpo; gli edifizii trovansi notati sotto l’articolo quattrocento trentasei, nel progetto generale dei Fabbricati, colla rendita imponibile di due dugento ottantacinque; ed i giardini, nel Catasto dei Terreni, sotto l’articolo mille dugento cinquanta, Sezione E, numero trecento ventisette, colla imponibile dei ducati venti: gli uni, e gli altri intestati all’Amministrazione del Fondo del Culto.
E di questo intero isolato, di cui fondò ed inaugurò il Monastero col titolo Santa Maria della Pietà, la Università concesse soltanto l’uso e godimento alle religiose, le quali tanto sto l’occuparono, e vi costituirono la loro comunità; ritenendone dessa la Università il dominio ed il patronato, che ha sempre conservato, giusta l’intendimento del testatore Luca, sancito dai di costui eredi, ed altri interessarti della famiglia Staibano; in forza del quale dominio e patronato, adempi sempre alla condizione impostale, di ammettere nel Monastero, senza dote, le donne della prefata famiglia; e di far creare Badessa, in ogni vacanza, una esistente monaca della stessa famiglia.
Qui il Signor Sindaco, è con esso insieme il Signor Ricevitore rappresentante il Demanio ed il Fondo pel Culto, cadauno per la parte che riguarda, han soggiunto i seguenti fatti.
Soppresso il Monastero dalle leggi del sette Luglio milleottocentosessantasei; la Direzione Compartimentale del Demanio e Tasse in Potenza, con manifesto del dieci Luglio milleottocentosessantotto, fece pubblicare gli incanti, pei dì sedici e diciassette Agosto, per la vendita in due lotti dei fondi contenuti nel sud descritto isolato, meno la parte che abitavano, ed abitano tuttora le religiose, per effetto del Decreto luogotenenziale del diciassette Febbraio milleottocentosessantuno.
La vendita non ebbe effetto, dopo un’annosa alternanza di richieste del Municipio di Maiori, finalmente, l’intera struttura del Monastero della Pietà passa in enfiteusi al Comune. (Autore: Mario Rosario Avellino)
Alcune notizie sul Monastero
La regola fu quella francescana di Santa Chiara, che fu eletta come patrona e titolare del Monastero assieme a San Luca Evangelista in onore del benefattore.
La prima abbadessa del Monastero fu la Ven. Madre Suor Anna Mariconda.
Tra le sante visite ricordiamo:
16 agosto 1599: Arcivescovo Rossini Giulio con il Vicario Prevosto della Collegiata, Giannotto Ferrigno.
Abbadessa: Sr. Vittoria de Ponte
24 giugno 1632: Arcivescovo Giacomo Teodolo (o Teodoro)
19 gennaio 1658: Mons. Stefano Quaranta
25 maggio 1661: Mons. Stefano Quaranta
All’epoca vi erano quindici religiose; Abbadessa Sr. Anna Confalone; vicaria Vittoria Confalone e altre due sorelle della stessa famiglia, Camilla e Vittoria.
6 agosto 1698: Mons. Simplicio Caravita (O.S.B.)
772: Visita Mons. Antonio Puoti
1786: Visita Mons. Antonio Puoti
Nel giugno del 1700 vi fu una richiesta di ampliamento all’Arcivescovo e richiesta d’accogliere anche “donzelle forestiere”.
Nel 1723 in Monastero vi erano 24 religiose ed una sola educanda, quest’ultima versava al convento 20 ducati annui, mentre “per la monacazione di donna cittadina si pagavano ducati trecento e per la forestiera ducati quattrocento.
Nello stesso anno fanno domanda di monacarsi tre sorelle Mezzacapo.
(Imperato Giuseppe. Vita religiosa della costa di Amalfi. Monasteri, conventi e fraternite. Palladio Editrice, Salerno,1981, pag.321, vol. I).
Nel 1806 vi erano 19 monache, di cui nove coriste, una novizia, una educanda ed 8 converse.
Nell’anno 1820 vennero eseguiti lavori di restauro interno ed esterno.
In data 12 settembre 1886 fu emanata la circolare del Ministro guardasigilli che disponeva lo sgombero di tutte le persone entro 10 gg. (Autore: Mario Rosario Avellino)
“Del primo Monastero della Pietà nella Terra di Maiori, Diocesi di Amalfi”
Il p.mo e più antico monastero s’è questo sotto il titolo di Santa M.a della Pietà, eretto e fondato dentro le mura e fra l’habitationi della suddetta terra di Maiori e riconosce per suo p.mo e principal fundator il devotiss. mo huomo, pietosissimo medico e pietoss.mo dottor il sig.re Luca Staibano dell’istessa Terra, il quale fra gl’altri pij che fè nel suo uiltimo testamento, il maggior e più signalato fu questo che s’edificasse un monastero, come realmente fu subito fatto ed alzato a suo costo e spesa quanto alla maggior parte, s’è doppo col tempo successivam.te dilatato, ampliato ed abbellito, come si vede; con la chiesa, il cui frontespitio risguarda il Settentrione, com’anco la porta della clausura; la sua sagrestia a man sinistra dell’attore maggior con belli parati di seta per tutta la chiesa, con un parato di broccato d’oro ma la pianeta e panno d’altare di ricami belliss.mi e di gran spesa. Per mezzo la clausura passa un fiumicello d’acqua ed esce per dietro la sagrestia, ove si parano per celebrare, detta di sopra, con un ornamento per l’altare di candelieri d’argento e fiori di poter stare al paragone con gli altri nella città di vanto.
Nel dormitorio vi sono da quaranta celle con una belliss.ma e grandiss.ma loggia alla vista del mare.
Vi sono hoggi vent’otto Sorelle, le quali vivono con singular pietà sotto la regola e modo di vivere del terz’Ordine del P. S. Fran.co.
Quando fusse fundato e con l’autorità di chi ha dato e concesso all’Ordine a governare e reggere si desidera sapere, però non se n’ha sin hora alcuna notitia, né il P. Gonzaga ne fa altra mentione, fa bensì particular memoria della venerabile Madre Suor Anna Mariconna, (leggi Mariconda N.d.T.) p.ma abbadessa di questo sacro collegio, religiosa di nobiliss.mi costumi e gentiliss.me maniere.
Fa dell’istessa, com’illustre in virtù e meriti, anche mentione il P. Vuadingo, ma per quello che spetta alla fundatione del Luogo, l’asserisce fundato l’anno del Sig.re 1449, l’anno terzo diNicolò V, sommo pontefice, dandogli per fundator un dottor di Legge chiamato Vinciguerra Lanario, il quale lasciò in testamento che s’edificasse un monastero con le sue facoltà, però, quanto al fondatore e modo della fondatione egl’istesso ne dubita per la ragione ch’apporta haver lui letto nell’istromento vaticano che Paolo Lanario, fratello di Vinciguerra sminuì assai le facoltà lasciate da fratello convertendoli (leggi convertendole N.d.T.) in altri usi, per il che non potevano dopo esser bastevoli a fundarsi ed alzarsi con esse sole tal monastero.
Nel coro delle monache che stà situato sopra la porta della chiesa v’è il suo organetto bellamente accomodato. (Il folio 246 non reca scritto alcuno, N.d.T.) (“Da una sintesi redatta da Bonaventura Tauleri d’Atina pubblicata in: Cuomo, Candido Gabriele.
Fondazione di tutti i Conventi raccolte da P. Bonaventura Tauleri d’Atina O.F.M. nell’anno 1639 trasritte dal P. Gabriele Candido Cuomo O.F.M. pag. 169, f. 244”). (Autore: Mario Rosario Avellino)
La soppressione degli Ordini Religiosi
Senza voler entrare nel merito circa la opportunità e la validità dei provvedimenti di Legge che portarono alla Sr. Maria Agnese Tecca, terza Madre Priora con il Cardinale Augusto Silj.tanto rinomata: “Soppressione degli Ordini Religiosi” è, forse, necessario soffermarsi brevemente sull’argomento, tanto più che interessa particolarmente la presente storia.
Ci limiteremo a tracciare le linee principali di questo percorso, lasciando ad altri più approfondita disamina critica.
L’operazione soppressione avvenne in due tempi storici diversi ed in condizioni di ideologie e regimi politici differenti.
Essa fu determinata dai bisogni di carattere economico dello Stato, nonché dalla dimensione che avevano assunto – in termini di ricchezza – le proprietà dei religiosi.
A questi due fondamentali motivi si aggiunsero, altresì, incomprensioni tra i vari Ordini: infatti le soppressioni avrebbero determinato ripercussioni sull’assetto di Diocesi e Parrocchie.
Ma si legge che tra le cause che concorsero ad applicare il dispositivo di Legge vanno annoverate anche – a ragione o a torto – situazioni di contrasto dovute a carenza di stima verso i religiosi.
Dalla secolarizzazione, tra l’altro, derivò una certa mancanza di fiducia verso tutto ciò che era religioso.
Il limitato problema del rapporto tra Stato e Chiesa si ampliò in quello più vasto e generale che metteva in relazione religione e società. Infine, non va trascurata la crescente presenza di componenti sociali ideologicamente ostili verso la Chiesa.
Naturalmente le soppressioni ingenerarono una serie di difficoltà sia per la popolazione, sia per lo stesso Stato.
Dalla diminuzione del numero delle strutture disponibili ne derivò un diffuso disagio che si ripercuoteva sull’aspetto educativo-
Ma, per non dilungarci, così come promesso, ritorniamo a Maiori, paese interessato alla soppressione anche di altri conventi e, in particolare, del “Monasterium S. Lucae seu Pietatis Ordini S. Francisci Observatiae”.
Diremo che i provvedimenti di soppressione emanati nello stesso secolo diciannovesimo furono due: rispettivamente nell’anno 1806 il primo e, il secondo, sessant’anni dopo.
A seguito del Real Decreto del 14 agosto del 1806 il governo napoleonico disponeva che dovevano essere chiusi “tutti i monasteri che non hanno il numero legale di dodici Religiose professe, il 4 maggio 1810, a nome di Sua Maestà e per ordine del Ministro del Culto, l’Intendente della Provincia di Pricipato Citra, il Cav. Salvatore Mandrini, ordina la compilazione dello Stato Dimostrativo dei monasteri delle Monache dal quale risultino i nomi delle Religiose che li compongono e i Beni dei medesimi monasteri”. (Cuomo, C. G. Fondazioni di tutti i Conventi… op. cit. pag. 182, vol. 1-
E lo Stato Dimostrativo relativo al Monastero della Pietà fu firmato da Frà Silvestro Miccù o.f.m., che fu Arcivescovo di Amalfi dal 29 ottobre del 1804 al 28 gennaio 1830.
La chiusura di quei monasteri, il cui numero di religiosi era inferiore al predetto limite di dodici, comportava un accorpamento di quei religiosi in altri ordini e case.
E il Monastero della Pietà non subì questo provvedimento perché all’epoca aveva i requisiti per non essere soppresso.
Tuttavia la Legge prevedeva che, ove mai vi fosse stata la necessità di avere i locali per pubblica utilità, venivano requisite anche quelle case nelle quali vi era un numero, cosiddetto legale, di religiose.
Naturalmente la decisione governativa diede luogo a molteplici complicazioni connesse all’adattamento ambientale delle religiose aggregate ad altre case e, forse per questo, un Decreto Legge emanato successivamente prevedeva anche una eventuale pensione alle Monache che avrebbero dovuto lasciare il proprio monastero perché soppresso.
Non mancarono vertenze e suppliche, petizioni e richieste per evitare la chiusura delle case; tuttavia vi fu un ulteriore Decreto che risparmiava dal provvedimento i monasteri (anche con un numero di religiosi inferiori a dodici), dai quali dipendevano Conservatori, Case di Educazione e di Correzione.
E così “i beni dei monasteri risparmiati dalla soppressione furono amministrati da una Commissione Amministrativa nominata dal Governo”.
A seguito di questo dispositivo di Legge: “Il primo settembre 1812, Raffaele Paolillo, Sindaco del Comune di Maiori, presenta all’Intendente i nomi di Francesco Aurisicchio e Angelantonio Amato, eletti dal Decurionato il 20 agosto del detto anno come componenti la Commissione Amministrativa del Monastero della Pietà delle Monache Francescane dello stesso Comune.
I due succitati cognomi vengono alla luce di frequente in questa storia; essi furono scelti perché la Legge prevedeva che avrebbero dovuto far parte della Commissione due cittadini scelti tra i benestanti del Comune. Il Presidente della Commissione sarebbe stato un ecclesiastico presentato dal Vescovo e per Maiori fu indicato il Parroco del Comune Preposto della Collegiata, il Canonico Gaetano Greco.
In definitiva, il Monastero di S. Maria della Pietà, delle Monache del Terz’Ordine Francescano, rimase aperto durante il decennio di occupazione Militare Francese. Ricordiamo, in particolare, che dall’otto febbraio del 1806 al 23 maggio del 1808, il governo fu retto da Giuseppe Bonaparte e dal predetto anno, e fino al 19 maggio del 1815, fu retto da Gioacchino Murat, quindi ritornarono i Borbone. Dal punto di vista numerico, dallo Stato Dimostrativo dei Monasteri delle Monache, compilato in data 27 settembre 1817, si evince che nel Monastero della Pietà di Maiori vi erano 7 Coriste, 7 Converse, 2 Novizie e 2 Educande. L’anno successivo, in data 18 ottobre vi erano 16 Coriste e 5 Converse. Ma a questo primo provvedimento di soppressione, seguì una seconda Legge “emanata dal governo liberale – massonico del giovane Regno d’Italia”. Infatti con la Legge – Decreto del 7 luglio 1866 venivano abolite “tutte le Corporazioni Religiose esistenti nel Regno d’Italia. Questa seconda soppressione ebbe press’a poco le stesse cause, gli stessi moventi che determinarono la prima, quella napoleonica. Il bisogno cioè da parte del Governo di locali da adibire a Case Comunali, a Scuole, Caserme, ad Ospedali, a Carceri etc.; la necessità di denaro per salvare, come si disse, con i beni ecclesiastici l’erario dello Stato esausto, la decisa volontà infine di spazzar via una forza ostile a qualunque pericolosa innovazione.
La legge in questione scatenò non poche polemiche e discussioni parlamentari con interventi a difesa dei religiosi, ma molte con accuse contro questi ultimi.
Il testo della Legge era composto di 38 articoli e portava la firma di Eugenio di Savoia – Borgatti – Scialoja, ad essa seguivano le disposizioni per l’esecuzione della Legge.
Aggiungiamo che, a seguito della Legge del 13 febbraio 1807, al Monastero della Pietà di Maiori, vennero aggregate altre suore provenienti dal Monastero S. Cataldo delle benedettine di Scala.
“Le benedettine del monastero di S. Cataldo furono dunque aggregate al Monastero del SS. Redentore, eccetto tre che, -
Ed ancora stralciamo dai testi di Cuomo: “D. Chiuso: le Monache furono aggregate al monastero del SS. Redentore della medesima città, due religiose optarono, ma senza risultato, per il Monastero delle Domenicane di Nocera, il locale fu venduto a P. Gambardella di Atrani.
In particolare si tratta di “due sorelle germane ed una cugina, Religiose professe di S. Cataldo, delle nobili famiglie Sparano di Majori e di Tramonti, luoghi della diocesi di Amalfi, mi manifestarono con attestati di Medici il desiderio e la necessità che avevano di respirare l’aria nativa e di essere soccorse dalle vicine loro famiglie, e di volere perciò essere collocate nel Monastero della Pietà del Comune di Maiori. Con queste parole si esprime Mons. Miccù in una sua lettera inviata all’Intendente per intercedere a favore delle predette Monache per una irregolarità nella tenuta dei registri amministrativi relativi al Monastero. (Autore: Mario Rosario Avellino)
Poco più che ventenne, la Congregazione delle Suore di Bartolo Longo ebbe l’occasione di varcare i confini pompeiani per raggiungere la vicina cittadina di Maiori.
Il fondatore Bartolo Longo aspirava al progetto che da Pompei sarebbero partite le Suore per svolgere la loro azione missionario-
Infatti egli scriveva: “Perché (…) da questa valle benedetta che è destinata ad avere benefiche irradiazioni in tutto l’Orbe, le Figlie del Rosario di Pompei non potrebbero passare ad altre città e paesi d’Italia e Fuori? …”
(Il Rosario e la Nuova Pompei. Periodico fondato da Bartolo Longo. Pontificio Santuario di Pompei. Valle di Pompei, 7 marzo 1884 – Anno 1917, pag. 203 [R.N.P.].Una rarissima foto di Sr M. Colomba Conforti una delle ultime due Suore clarisse che si dovettero ritirare in famiglia a seguito delle Leggi di Soppressione degli Ordini Religiosi. La foto, che è un particolare di una foto di gruppo, fu scattata sul terrazzo sul porticato davanti alla porta dell'attuale infermeria della Casa; l'epoca è il 1915. Ma, certamente, l’aspetto più significativo di questa nuova missione risiede nel fatto che le Suore Domenicane di Pompei vantavano già i titoli per avere incarichi socio-
Intanto all’epoca in cui si riferisce la nascita della Casa di Maiori, le Suore avevano avuto tre esperienze oltre Pompei con le fondazioni di: Belvedere Marittimo (24.11.1918); «Rifugio» in S. Rocco di CapodimonteL'ultima Suora clarissa, Suor Maria Teresa, al secolo Vienna Prato, in un particolare di una foto del 1915. – Napoli. (1919); Istituto per l’educazione morale e intellettuale – Bari, (11.6.1921); «Pro infanzia derelitta» -
Dunque, il 18.6.1023. subito dopo l’apertura dell’Istituto nella provincia calabrese, fu istituito l’Asilo infantile e la Scuola di lavoro a Maiori. Il merito dell’Iniziativa va a Mons. Ercolano Marini, Arcivescovo di Amalfi.
Egli prese a cuore la situazione dell’educazione dei fanciulli e delle fanciulle.
E per questa finalità emise il seguente decreto (Archivio «Suore Domenicane Figlie del S. Rosario di Pompei». Pompei); Fondazione dell’Asilo Infantile e della Scuola di lavoro a Maiori.Sua Ecc.za Mons. Ercolano Marini, Arcivescovo di Amalfi dal 2 giugno del 1915 al 5 ottobre del 1945.
Decreto di erezione di Mons. Ercolano Marini
Venuto ad Amalfi, appena conobbi i bisogni della Costiera, mi si affacciò alla mente il pensiero di fondare due istituti: per fanciulli in Amalfi e per fanciulle a Maiori.
L’impresa sulle prime mi parve impossibile; però per disposizione divina, cominciò ad attuarsi quando il 31 luglio 1919 potei aprire in Amalfi un Orfanotrofio Maschile, ed ora si va completando perché, per la bontà del Cardinale Silj, che presiede alle opere Valpompeiane, ho potuto ottenere dalla Rev. ma Superiora delle Suore Terziarie Domenicane, Figlie del SS. Rosario di Valle di Pompei, che alcune delle sue Suore vengano a Maiori per aprirvi un Asilo Infantile e una scuola di lavoro per le fanciulle. Perciò, dopo aver provveduto ai locali, con assegnare all’uopo la parte ancora abitabile dell’ex Monastero della Pietà in cui sono venute meno le Suore dell’Ordine di S. Francesco, e al suo mantenimento per mezzo di un Comitato dei più distinti di Maiori, nel nome Augusto della SS. Trinità e a Sua gloria istituisco a fondo l’Asilo Infantile e il Laboratorio Femminile a Maiori affidandone la cura alle Suore Domenicane di Valle di Pompei, con la speranza che la SS. Vergine, Patrona della Città, invocata con la pia pratica del S. Rosario, faccia fiorire e sviluppare dette Opere in modo che si realizzino i primitivi miei desideri.
Amalfi, 18 giugno 1923 -
Dal «Notiziario dell’Istituto S. Maria» si legge che: “Il contratto per l’apertura di questa casa fu stipulato tra la Il Cardinale Augusto Silj.Marchesina Giuliana Benzoni, delegata Ass. ne Nazionale interessi del Mezzogiorno, in unione al Patronato Scolastico di Maiori e la Rev.ma Madre Suor M. Colomba Mazza, superiora delle Suore Domenicane «Figlie del SS. Rosario di Valle di Pompei», con l’approvazione verbale di S. Eccellenza Rev.ma Mons. Ercolano Marini, ordinario della Diocesi e Sua Eminenza il Cardinale Augusto Silj il giorno 19 giugno 1923”
(Archivio «Suore Domenicane Figlie del S. Rosario di Pompei». Pompei.
Infatti a quest’ultimo, “Capo della Delegazione Pontificia che doveva regolare e governare il Santuario e le Opere di Valle di Pompei in nome del Papa”
(Scotto Di Pagliara, Domenico. Bartolo Longo e il Santuario di Pompei. Scuola Tip. Pei Figli dei La Priora Suor Maria Colomba Mazza.Carcerati fondata da Bartolo Longo. III Edizione. Pompei, 1943 – XXI, pag. 260), veniva sottoposto all’approvazione, il verbale della riunione di Consiglio convocato per scegliere le Suore che avrebbero raggiunto la nuova casa.
Questo il testo per l’esito della decisione:
“Pontificio Orfanotrofio Femminile Della SS. Vergine di Pompei
Valle di Pompei”
Oggi, giorno 27 giugno 1923, alle ore 4 pomeridiane la M. R. M. Priora Sr Mª Colomba Mazza di S.ta Cecilia ha congregato le Madri del Consiglio in N. di quattro ed alla presenza del Rev.mo Mons.re Canonico D. Vincenzo Celli Protonotario Apostolico e Vicario di S. E. il Cardinale Augusto Silj ha loro detto che essendosi convenuto di accettare la casa di Maiori, e di mandare colà una Maestra Diplomata, una Superiora ed una Conversa ed anche una Probanda, che aiuti, bisognava decidersi e combinare. È stato discorso e si è convenuto dietro la proposta della R. M. re Priora di mandare come Superiora Sr. Maria Pia Montella, Sr Maria Serafina Natella come Maestra Diplomata e per Conversa Sr Amata Mazzone.
In fede di che ecc. ecc. La Segretaria del Capitolo
Sr Maria Agnese Gambigliani Z.”
Il presente verbale reca la firma del Card. Augusto Silj e la data di approvazione del 30 giugno 1923. Intanto, veniva stipulata una convenzione tra la Contessina Giuliana Benzoni, in rappresentanza al Patronato Scolastico di Maiori e la Priora Generale delle Suore Pompeiane, Sr Maria Colomba Mazza.
Nell’atto venivano definite, sia pure in maniera sommaria, le rispettive competenze ed i doveri da osservare da ambo le parti per l’apertura di un Asilo e di un Laboratorio a favore delle fanciulle di Maiori.
In particolare questi i sette punti della convenzione:
1° La Superiora Sr M. Colomba di S. Cecilia fornisce tre Suore di cui una munita di diploma normale per l’insegnamento all’Asilo Infantile, ed altre due per la Direzione del Laboratorio ed il fabbisogno della Casa.
2° La stessa Superiora si riserva ampie facoltà di cambiare le dette Suore quando lo credMons. Ercolano Marinierà opportuno – ciò con piena libertà senza bisogno di approvazione o di intelligenza con altri.
3° Le Suore porteranno seco la biancheria personale da letto, da tavola e da cucina.
4° Il Patronato Scolastico corrisponderà alle Suore l’assegno mensile posticipato di £. Centocinquanta per ognuna, onde provvedere al vitto ed altre spese personali. E ciò per l’intero anno solare.
5° Il Corredo della Casa e della Scuola rimane a carico del Patronato dell’Asilo il quale dovrà fornire gratuitamente alle Suore l’abitazione, l’illuminazione, l’acqua ed il fuoco per la cucina.
6° Così pure lo stesso Patronato provvederà d’accordo con l’Autorità ecclesiastica a mantenere il Cappellano che dovrà celebrare quotidianamente la S. Messa nella Chiesa annessa all’Asilo.
7° Tale convenzione dura dal giorno dell’arrivo delle Suore a Maiori fino al 31 luglio 1925. A questa epoca le parti saranno libere di rinnovarla e di modificarla però con un preavviso di due mesi.
Era il 16 luglio del 1923 le Suore, in numero di quattro, presero possesso della Casa, ed il primo settembre di quell’anno, già fu aperto il Laboratorio femminile, mentre l’Asilo infantile portava la data di apertura del 19 giugno, il giorno successivo al Decreto del Vescovo Marini.Vediamo chi erano le quattro Suore fondatrici che, “accompagnate dalla Rev. ma Priora di Pompei e dalla Madre Economa, dopo aver ricevuto la benedizione con la corona del Rosario del nostro Beato fondatore Bartolo Longo, si inseriscono nell’ala del Monastero che il Comitato aveva sommariamente resa abitabile” (In cammino… con Maria. Periodico della Congregazione delle Suore Domenicane «Figlie del S. Rosario di Pompei». Pompei, 1985 – N. IX – Dic. ’95, pag. 16) [I.C.C.M.].
Come Superiora della casa fu nominata Sr M. Pia Montella, al secolo Raimonda. Nata a Torre del Greco (NA) il 1° dicembre del 1896, aveva preso l’abito il 30 aprile del 1919, professato il 4 agosto del 1920, ed emesso i Voti Perpetui il 15 agosto del 1926.
È superfluo aggiungere commenti per il lavoro che fece per il bene della casa e dell’Istituzione a vantaggio delle alunne che frequentavano l’Istituto, riscuotendo l’approvazione e la riconoscenza della città. Di ciò è prova degna di benemerenza del conferimento della cittadinanza onoraria che le fu conferita il 13 gennaio del 1945 dalla Giunta Municipale del Comune di Maiori.
Questa la motivazione dell’onorificenza:
“Dato atto che questa Superiora delle Suore Domenicane, Sr Maria Pia Montella, è stata dal Capitolo testé tenutosi in Valle di Pompei, designata per suoi meriti eccezionali e nominata Economa Generale di Valle di Pompei e Direttrice della Scuola esterna dell’Opera;
Visto che per effetto di tale alta distinzione la pia Madre lascerà tra breve la cittadina di Maiori, ove Ella, per oltre un ventennio, ha profuso le sue rare qualità cristiane in opere benefiche, che, come l’Asilo Infantile ed il fiorente Educandato, da Lei istituiti, rappresentano vanto e decoro per la Città ed invitano, con la saggia e perfetta organizzazione di provvidenza e beneficio di bambini, di poveri (Refezione dell’Asilo e Mensa popolare), a seguire l’esempio ed a potenziare maggiormente la beneficenza pubblica;
Che è nei voti dei cittadini tutti e di questa Civica Amministrazione in ispecie di attestare alla Reverendissima Madre la imperitura riconoscenza della Città di Maiori; La Giunta Municipale ad unanimità
D E L I B E R A
Di conferire alla rev. Ma Madre Superiora delle Suore Domenicane, Suor Maria Pia Montella, la cittadinanza Sr. M. Pia Montella e la delibera di conferimento della cittadinanza onoraria.onoraria di Maiori”
L’Atto porta la firma del Sindaco di allora, Avv. Salvatore Confalone, un nome che ricorrerà spesso nel corso di questa storia, per l’interessamento che dimostrò verso le Suore di Pompei presenti nella città di Maiori.
Aggiungiamo, ad onor del vero, che l’Amministrazione Civica Maiorese, nelle varie epoche, ha sempre dato segni di particolare interessamento ed attenzione all’azione educativa ed assistenziale dell’Istituto religioso, approvandone l’operato.
Accompagnava la Superiora Sr. Maria Serafina Natella, al secolo Maria. Era nata a Salerno il 9 febbraio 1898 ed aveva fatto il suo ingresso al Noviziato il 31 ottobre del 1920; prese l’abito il 6 agosto del ’21 e professò il 15 agosto dell’anno successivo, nello stesso giorno di sei anni dopo emise i voti perpetui.
Sr. Maria Serafina è stata una personalità particolarmente ricordata da quanti l’hanno conosciuta per le sue doti di umanità e per come seppe portare pace, gioia e sorriso nei luoghi di pena. Ella è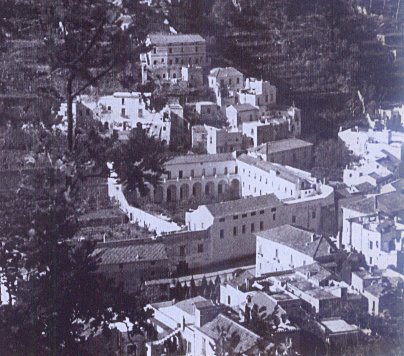 ricordata come la «Suora delle carceri» per averle conosciute tutte quando accompagnava le bambine dell’Istituto «S. Cuore» in visita ai loro genitori. Un lavoro durato venticinque anni, svolto con spirito missionario fattivo in perfetta sintonia con il carisma del fondatore Bartolo Longo. Il futuro Beato, infatti, con la fondazione dell’Istituto «S. Cuore», andava ad esaudire “l’ultimo voto del suo cuore”, anche perché aveva sperimentato che l’incontro delle bambine con i genitori reclusi, molto spesso, si era tradotto in prodigiosa conversione del padre o della madre ad opera della figlia. Sr. Maria Serafina restò a Maiori per diversi anni. Morì il 28 aprile del 1964. Un’altra Suora, che faceva parte della Comunità nascente, sicuramente degna di grande attenzione era Anna Pecoraro, in religione Sr. Maria Amata Pecoraro.
ricordata come la «Suora delle carceri» per averle conosciute tutte quando accompagnava le bambine dell’Istituto «S. Cuore» in visita ai loro genitori. Un lavoro durato venticinque anni, svolto con spirito missionario fattivo in perfetta sintonia con il carisma del fondatore Bartolo Longo. Il futuro Beato, infatti, con la fondazione dell’Istituto «S. Cuore», andava ad esaudire “l’ultimo voto del suo cuore”, anche perché aveva sperimentato che l’incontro delle bambine con i genitori reclusi, molto spesso, si era tradotto in prodigiosa conversione del padre o della madre ad opera della figlia. Sr. Maria Serafina restò a Maiori per diversi anni. Morì il 28 aprile del 1964. Un’altra Suora, che faceva parte della Comunità nascente, sicuramente degna di grande attenzione era Anna Pecoraro, in religione Sr. Maria Amata Pecoraro.
Fra le prime sei Suore fu la terza a prendere l’abito il 14 maggio del 1898, in occasione della prima cerimonia di vestizione dopo la nascita della Congregazione delle «Figlie del S. Rosario di Pompei» voluta dall’avv. Bartolo Longo.
Sr. Amata, che conobbe bene il Beato fu, insieme a Sr. Cecilia, la prima sorella conversa della famiglia delle Suore pompeiane; prese l’abito lasciando il suo posto di cuciniera che aveva nell’Orfanotrofio.
La sua vita fu legata al Fondatore per quanto collaborò nell’Opera pompeiana.
Annina, ovvero Sr. Amata, morì nel giorno di Pasqua, il 5 aprile del 1900.
Come si legge nel verbale del Consiglio che deliberò l’invio delle Suore nella nuova casa di Maiori, si stabilì di mandare a Maiori anche una Probanda, era Rosalia Rossi, che prese l’abito l’anno successivo, il 4 ottobre del 1924.
Era nata ad Ascoli Satriano (FG) il 23 maggio del 1902 e prese il nome da religiosa di Maria Reginalda. Professò il 22 novembre del 1925 ed emise i voti perpetui l’8 dicembre del 1931.
Era molto benvoluta dal Fondatore di Pompei per l’opera che svolgeva “tra le sue beniamine”, le orfane accolte nelle Opere pompeiane.
Tra le tante attività da lei svolte, ricordiamo quella che maggiormente ha impegnato la sua vita: per ben 35 anni la vediamo al lavoro nell’ufficio di spedizione del periodico fondato da Bartolo Longo: «Il Rosario e la Nuova Pompei».
Il 29 ottobre del 1996 Sr. Maria Reginalda, all’età di 95 anni, morì a Pompei
L’acquisizione del Monastero
Erano trascorsi appena due anni dall’arrivo delle Suore a Maiori che, come si ricorderà, giunsero il 16 luglio del 1923, e già si parlava di acquisizione della casa. Infatti in un verbale dell’11 agosto del 1925, leggiamo:
“Oggi alle ore 5 e ¾ pom.ne la Rev. Da Madre Priora Suor M. Colomba Mazza di S. Cecilia, ha radunato il Consiglio delle Madri in N° di quattro e alla presenza del nostro amatissimo Superiore, l’Ecc.mo Cardinale Augusti Silj, per determinare la questione della Casa di Maiori (prov. Salerno) cioè dell’ex Monastero delle Clarisse detto della Pietà.
Si è ripetuto quel che già si sapeva e cioè che, detto Monastero per lungo tempo disabitato, è ridotto in uno stato deplorevole, ed alcuni muri esterni sono profondamente lesionati.
Ora, una parte di esso è stata riedificata dal Comune e adibita ad Asilo d’Infanzia, laboratorio, destinando alcune stanze per abitazione delle nostre Suore che gestiscono queste scuole.
L’attività che esse svolgono a beneficio del paese, le ha cattivato l’affetto e la stima di tutto, e specie del Comune stesso, che si è offerto di donare alla nostra Comunità tutto il Monastero, compresa la Chiesa, e un piccolo giardino, non meno la parte intera riedificata; con l’obbligo però, che la Comunità gli rimborsi la somma di £. 17.000, spese già per una grave riparazione. Inoltre fa notare che si dovrebbe soddisfare ad un canone di £. 1.000 che pesa sul fabbricato stesso, ma che si potrebbe scontare tutto insieme così versare una sola volta £. La foto mostra lo stato di abbandono e di degrado strutturale in cui versava il convento all'inizio del secolo.20.000 (ventimila). Dice ancora (dietro la relazione di Suor Maria Pia Montella Superiora di Maiori) che detta somma, sborsata da noi di £. 20.000, il Municipio si obbliga dare alle Suore, per venti anni un sussidio di £. 1.000 – La proposta è stata accettata dalle Madri come pure dal Cardinale, con la condizione però, che diano pure una parte del giardino grande esterno, anche gratuitamente, e magari comprarlo qualora veramente non potessero cederlo.
A Suor M. Pia Montella, presente a questo Consiglio, dall’Em.mo nostro Superiore e dalle Madri Capitolari, è stato affidato di portare avanti le pratiche presso il Comune di Maiori, per la gloria di Dio e per il bene della nostra Comunità.
Si spera bene per la protezione della nostra celeste Mamma Maria SS.ma, non facendoci mancare l’aiuto dell’Ecc.mo Arcivescovo di Amalfi Mons. Ercolano Marini, e del confessore delle Suore di Maiori Rev.mo P. Alfonso Romano O.F., i quali hanno grande ascendenza sugli animi dei componenti il Comitato e il Comune.
Si disse inoltre, che, comprata la casa (Monastero) l’Asilo e il Laboratorio, sarebbero restati sotto la dipeSr.Maria Agnese Tecca, terza Madre Priora delle Suore Domenicane Figlie del SS. Rosario di Pompei.ndenza del Comitato per maggiore vantaggio delle Suore stesse.
In fede di che ecc. ecc.
La Segretaria del Consiglio Suor M. Margherita Idà del S. Cuore di G. Domenicana Figlia del SS. Rosario Valle di Pompei.
«Si approva il presente verbale
Valle di Pompei 13 agosto 1925 -
(Archivio delle Suore Domenicane “Figlie del S. Rosario di Pompei”).
In effetti, i termini della cessione del Convento vengono riassunti in un primo momento, Una veduta lato monte della Casa di Maiori.in una missiva inviata alla Priora Sr. Maria Colomba Mazza dal Sindaco D’Amato in data 17 gennaio 1926 e del seguente tenore:
“Facendo seguito a mia ultima del 9 corr. Mese n° 55, Le significo che quest’Amministrazione sarebbe disposta a vendere a Codeste Suore Terziarie Domenicane – salvo approvazione dell’Autorità tutoria -
La vendita dovrebbe essere subordinata alle suguenti condizioni:
I – Pagamento del prezzo di £. 17.000 ed affranco al Comune del canone annuo dovuto in £. 1.000 al Fondo Culto.
II -
III – Facoltà al Comune di riscatto, in caso che tale destinazione non si avverasse o venisse a mancare durante il termine di tre anni.
IV -
V -
Prego ora la S.V. di volermi far conoscere al più presto le determinazioni di Codesto Capitolo, dato che il Comune, che ben più vantaggiosa utilizzazione economica potrebbe ricavare dall’immobile in parola, ha da tempo soprasseduto dal curare di attuarla, unicamente per aderire allo scopo altamente sociale cui tende la proposta istituzione dell’educandato.
Con osservanza -
Prese così l’avvio della pratica di acquisizione del Monastero della Pietà da parte della Congregazione. L’iter burocratico non si presentò semplice, nonostante la disponibilità da parte dell’Amministrazione Comunale di Maiori di portare avanti l’iniziativa.
Intanto, la struttura, già quasi fatiscente in più punti, dava segni di evidente e prossimo cedimento e non si disponeva di fondi sufficienti per far fronte alle ingenti spese di manutenzione o, addirittura, di ricostruzione.
Nello stesso periodo, inoltre, vi era stato un avvenimento di grande rilievo: la morte di Bartolo Longo, il fondatore della Nuova Pompei, che avvenne proprio il 5 ottobre del 1926. Anno in cui erano particolarmente più intensi i rapporti tra la cittadina vesuviana e Maiori.
Fu solo a seguito di una delibera del 25 luglio dell’anno 1932 che il 1° agosto del 1932 fu stipulato l’atto notarile Un'immagine delle condizioni di deterioramento del lato ovest della casa all'inizio del secolo.tra il Commissario Prefettizio del Comune di Maiori, il Sig. D’Amato Carlo, e la “Signorina Chiara Tecca fu Nicola possidente, nata a Capistrano e domiciliata in Pompei, qui residente, nella qualità di Presidente dell’Intellettuale femminile con sede in Pompei”. (Archivio «Suore Domenicane Figlie del S. Rosario di Pompei». Pompei).
La summenzionata Signorina era l’allora Sr. Maria Agnese Tecca, che fu eletta Priora Generale delle “Figlie del Rosario di Pompei” nel V Capitolo del 1° agosto 1932.
Come riportato nelle altre storie, quello stesso anno, il 27 dicembre, fu tramutata la definizione di “Priora” in “Madre Generale”, istituendosi così i Capitoli elettivi con scadenza ogni sei anni. In quella elezione a Madre Tecca si alternò Madre Colomba Mazza.
L’intento dell’allora Amministrazione Comunale fu, senza dubbio, quello di mantenere in vita l’Istituzione. Peraltro, come già detto, per il degrado strutturale, erano necessari interventi di manutenzione con conseguente aggravio di spese di bilancio comunale.
Il Consiglio dell’Amministrazione della “Società Anonima Istituto per la Educazione Morale ed Intellettuale Femminile” si riunì in data 31 luglio del 1932 nella sede di Pompei, per ratificare il passaggio della proprietà, con un atto che tenne conto di adeguamenti relativi ad integrazioni e condizioni che mutarono nel corso del tempo. Alla riunione erano presenti le consigliere: Tecca Chiara, in religione Sr. Maria Agnese; Rosa Mazza, Sr. Maria Colomba Mazza; Vincenzina Visconti, Sr. Maria Assunta; Antonietta De Sanctis, Sr. Maria Concetta, le quali approvarono l’operato della Presidente Idà Agnese, ovvero Sr. Maria Margherita, “attribuendo, altresì, un voto di riconoscenza all’autorità Amministrativa di Maiori”. (Archivio «Suore Domenicane Figlie del S. Rosario di Pompei». Pompei). (Autore: Mario Rosario Avellino).
Il 18 giugno del 1923 l’Arcivescovo di Amalfi, Mons. Ercolano Marini, stabiliva che la casa religiosa delle Monache Clarisse di San Francesco venisse affidata alle Suore Domenicane di Pompei.
Era sua intenzione fondare un Istituto per accogliere fanciulle del posto: istituire una Scuola materna e una Scuola di ricamo e cucito.
Ciò si desume dal decreto di erezione della casa. Egli si rivolse al cardinale Augusto Silj che allora era responsabile a Pompei.
Pochi giorni dopo, il 27 giugno, la Rev.ma Madre Priora, Madre Colomba Mazza, riunisce il Consiglio e presente Mons. Celli, definisce l’accettazione della nuova fondazione.
Si legge la Convenzione proposta dalla Contessina Giuliana Benzoni, mandata dal comitato locale, vengono fUn'antica foto (1939) di un gruppo di ragazze accolte dalle Suore. A sinistra Sr. M. Pia Montella, al centro vediamo Sr. M. Serafina Natellaissati gli obblighi reciproci da osservarsi e si delibera, secondo quanto viene richiesto da un articolo della Convenzione stessa, di inviarvi tre Suore. Sono: Sr. Maria Pia Montella, Superiora e maestra di lavoro; Sr. Maria Serafina Natella, insegnante; Sr. Amata Mazzone; Rosalia Rossi, postulante, divenuta Sr. Maria Reginalda.
Il 16 luglio del 1923 il silenzio dell’antico convento, ormai solitario, viene interrotto e vi si inizia una nuova vita di preghiera e di operosità. Le nostre Suore fondatrici, accompagnate dalla Rev. ma Priora di Pompei e dalla Madre economa, dopo aver ricevuto la benedizione con la corona del Rosario dal nostro Beato Fondatore Bartolo Longo, si inseriscono nell’ala del monastero che il Comitato aveva sommariamente resa abitabile. Prima attività esplicata l’apertura dell’asilo e di un laboratorio.
Dopo qualche anno, nel 1926, si realizzò l’apertura del corso elementare che in cinque anni fu completo. Vennero ripristinate opere assistenziali e di beneficenza come la Confraternita di S, Vincenzo de’ Paoli e ne fu affidata la direzione alle Suore.
La casa divenne, in seguito, anche sede dell’Azione Cattolica.
La piccola chiesa semipubblica, prima deserta, divenne centro di pietà e di fede; così che ben presto si vide migliorare lo stato spirituale e religioso della popolazione con grande gioia dell’Arcivescovo, il quale, ebbe sempre parole di incoraggiamento e di plauso per l’opera esplicata dalle Suore.
In seguito il Comune di Maiori pensò di donare tutto il fabbricato alle Suore con l’impegno di ristrutturarlo a proprie spese.
Il 1° agosto del 1932 fu steLa prima comunità al completo. Partendo da sinistra:Rosalia Rossi, divenuta Sr. M. Reginalda con in braccio il mio futuro professore d'italiano, il Prof. Sarno, Sr. M. Serafina Natella, Sr. M. Pia Montella e Sr. Amata Mazzonesa la donazione legale (una copia dell’atto si conserva nell’archivio della casa). La casa consta di tre ali e un piccolo giardino agrumeto. Furono eseguiti in vari momenti lavori di restauro per tutta la casa.
Fu istituito un educandato femminile, dove venivano accolte ragazze, il cui numero variava dalle prime quattro a un massimo di trenta unità.
Per meglio incrementare l’ Istituto si stabilì di iniziare un corso di Scuola media che durò pochi anni. Il numero degli alunni andò sempre crescendo e l’Istituto si affermò per prestigio su tutta la zona. (Autore: Mario Rosario Avellino)
La Casa di Maiori oggi
I vari locali, con l’andar del tempo e per meglio soddisfare alle esigenze igieniche e pedagogiche dei tempi moderni, hanno subito diverse trasformazioni.
Ultimamente sono state create camere singole con servizi igienici per le Suore che vi abitano, nonché per gli ospiti di passaggio.
Da alcuni anni, la casa è diventata la sede del Capitolo Generale e si tengono ogni anno corsi di Esercizio Spirituali a livello Congregazionale.
Inoltre, sono stati creati, sfruttando ogni angolo nascosto della casa, sale e mini appartamenti abbastanza confortevoli per agevolare la permanenza delle ospiti in questi luoghi.
Durante i mesi estivi la nostra casa ospita le Suore che necessitano di cure elioterapiche avendo a disposizione un agrumeto sul mare.
È in corso però un progetto per la costruzione di una piscina..
Nell’Istituto il giardino – agrumeto di un tempo – è stato trasformato in un mini parco giochi per gli alunni della Scuola Materna ed Elementare.
La scuola ospita oggi, due sezioni di Scuola Dell’ Infanzia e il corso completo di Scuola Primaria con una popolazione di circa 150 alunni.Oltre alle discipline regolari di studio sono aggiunte attività integrative.
Da oltre una quindicina d’anni, la casa accoglie l’Istituto di Scienze Religiose dell’Arcidiocesi di Amalfi – Cava dei Tirreni, voluta dall’Arcivescovo Beniamino De Palma.
Le Superiore della Casa di Maiori
Ben dodici Suore si sono alternate alla guida dell’Istituto “Santa Maria” di Masiori (Sa), è doveroso qui citarle, riportando (cliccando sulla rispettiva immagine), una breve scheda con le notizie generali relative alla loro vita. Nei vari carteggi relativi a queste Suore evince sempre un loro particolare attaccamento alla Casa e al Paese. Tutte hanno lavorato con entusiasmo e piacere per il bene delle fanciulle nell'espletamento dell'opera di educazione e la formazione. In particolare va ricordata la prima Superiora, Suor Maria Pia Montella, per la quale si fece richiesta di rinnovare l’incarico di Superiora anche oltre i termini previsti dalla normativa vigente, con dispensa a norma del Can. 505.
1ª Madre Pia Montella (1923-
2ª Madre Cecilia Pignatelli (1944-
3ª Madre Agostina Allaria (1950-
4ª Madre Roberta Marchesano (1965-
5ª Madre Chiara Marinelli (1974-
6ª Madre Florinda Capasso (1976-
7ª Madre Rosanna Piccolo (1985-
8ª Madre Nazarena Libonati (1995-
9ª Madre Pasqualina Battaglia (1998-
10ª Madre Rosa Battigaglia (1999-
11ª Madre Giustina Stavola (2000-
12ª Madre Colomba Russo (Dal 12 settembre 2001)
Convento di Santa Maria della Pietà e la Chiesa delle clarisse
La casa del Convento di S. Maria della Pietà ebbe inizio in data 27 settembre 1515.
In questa data il dottor Luca Staibano inserisce nel suo testamento il trasferimento di un casamento con giardino al Comune di Maiori che determinava che venisse fondato un monastero di monache clarisse.
Circa quattro anni più tardi furono iniziati i lavori che terminarono attorno al 1530.
Venne quindi fondato il Monasterium S. Luca seu Pitatis Ordini S. Francisci Obsrvantiae della Pietà. Donzelle nobili potettero entrare nel convento e nel 1661 il numero di esse era già salito a quindici.
Tra di esse si possono trovare i nomi delle famiglie più note: de Ponte, Aurisicchio, Confalone.
Nella piccola chiesa, ricca di opere artistiche, appartenente al convento sono, tra l'altro, presenti opere di Girolamo Cenatiempo e Nicola Vaccaro.
A causa della soppressione dei patrimoni ecclesiastici nel 1866 il complesso passò allo Stato e poi al Comune di Maiori.
In data 1 settembre 1932 il complesso passò alle Suore di Pompei.
La Chiesa
La chiesetta già sin dall’inizio fu ampliata ed abbellita di marmi, affreschi e tele raffiguranti scene evangeliche, vite e miracoli di Santi Francescani. In seguito, con l’arrivo delle nostre Suore furono aggiunti affreschi con i grandi santi Domenicani.
Sull’altare maggiore troneggia la Madonna di Costantinopoli comunemente chiamata, ma in origine era detta “S. Maria della Pietà”, il cui autore è San Luca, infatti porta decorata la inconfondibile stella. Dal 1980 la chiesa è rimasta chiusa perché danneggiata nella sua struttura dal violento terremoto. Da quel giorno spaventoso, sono passati 28 anni.
Ora, sono stati eseguiti lavori di consolidamento, è stato rifatto il tetto, il pavimento, restaurati e ripuliti il trono, decorato in oro zecchino, e le tele. La chiesa appare un vero gioiello, restituito a noi in tutto il suo splendore. Da molti è considerata la chiesa più bella della Costiera Amalfitana.
Responsabile della Comunità di Maiori
Madre Colomba Russo
Comunità di Maiori
Attualmente le Suore appartenenti alla comunità sono:
Sr. M. Adelaide Galasso (Italiana) -
Come già all’ inizio della fondazione, anno 1923 -
Un Santo Peruviano a Maiori
“Martino della carità” l’immagine dell’umiltà e dell’amore di Dio in un quadro raffigurante San Martino de Porres.
Nel giorno della commemorazione liturgica di San Martino De Porres, la sera del 3 novembre durante la Celebrazione Eucaristica delle ore 18,00, presso la Collegiata di Maiori, è stato donato alle Suore Domenicane di Pompei un quadro raffigurante il santo peruviano, anch’egli domenicano e considerato il primo santo di colore della chiesa cattolica. Patrono dei barbieri e dei parrucchieri e, in Perù, della giustizia sociale.
San Martino nacque a Lima il 9 dicembre del 1579. Era figlio di un nobile spagnolo e di una ex schiava di origine africana, ma il padre non si curò mai di lui: solo la madre cercò di impartirgli un minimo di educazione.
Da giovane, per guadagnare un po’ di soldi, Martino lavorò come garzone presso un barbiere, dal quale apprese anche alcune nozioni di chiLa Comunità di Maiori riceve dal Sig. Mauro Palertta il quadro di San Martino.rurgia che gli permisero, in seguito, di diventare un bravo infermiere.
Devoto dell’Eucarestia e desideroso di consacrare la sua esistenza a Dio, entrò a far parte dell’Ordine Domenicano.
Dedicò la vita ai poveri che aiutava, curava e per i quali aveva sempre una parola di speranza.
Morì a Lima nel 1639. L’esistenza umile e semplice di San Martino de Porres, costellata da molteplici miracoli, caratterizzata da doni di grazia e santità, da virtù come la bilocazione, la profezia, la carità cristiana e le scienze infuse, è stata raccontata anche agli alunni della Scuola dell’Infanzia e Primaria di Maiori dell’Istituto delle Suore Domenicane di Pompei.
La mattina del quattro novembre, dinanzi al quadro del santo collocato presso l’altare, all’interno della Chiesa delle suore, i discenti hanno ascoltato le parole del signor Mauro Paletta, promotore della devozione verso il santo. Egli ha raccontato agli alunni alcuni aneddoti relativi alla vita, ai miracoli e al pensiero di San Martino.
È stato spiegato il significato dei molteplici simboli che nel quadro circondano la fi gura del santo, come la colomba, emblema della pace, la presenza del cane, del gatto e del topo che egli chiamava frateGli alunni della Scuola Primaria delle Suore Domenicane intorno al quadro.lli o del giglio simbolo di purezza.
Tutti siamo stati invitati a riflettere sulla figura del giovane mulatto di Lima, che ha scelto di seguire l’esempio di Gesù, di amare i poveri incondizionatamente, proprio come avrebbe fatto il Figlio di Dio, di vivere umilmente scegliendo sempre il bene, la verità, il giusto, nutrendosi sempre e soltanto dell’amore di Nostro Signore.
Dopo un momento di preghiera, gli alunni silenziosi e pensierosi sono ritornati nelle classi, al loro lavoro, arricchiti di una nuova conoscenza e testimoni del cammino di fede ed umiltà di un Santo chiamato “Martino della carità”. (Autore: Olga Pero)
La nostra casa di Minori (Salerno)
Regione -
La Campania è una regione dell'Italia meridionale. Conta 5.701.931 residenti (censimento 2001 ed ha la più alta densità di popolazione tra le regioni italiane, ma è seconda dopo la Lombardia per numero totale di abitanti. Il suo capoluogo è Napoli. Confina a ovest, sud-
Con la crisi della società romana, la villa di Minori, venne gradualmente abbandonata e sommersa dal materiale alluvionale portato a valle dalle piene del fiume Reginna.
La cronaca Reginna Minori Trionfante, redatta nella prima metà del Settecento dallo storico Pompeo Troiano, (principale fonte storica e documentaria per la città di Minori), riporta tra le altre cose, un dato molto interessante relativo allo sviluppo urbano della città nei primi secoli del medioevo. Il primo nucleo abitato si sarebbe, infatti, sviluppato nella località collinare di Forcella.
Un dato condiviso dalle recenti acquisizioni storiografiche, secondo le quale la fondazione delle più antiche città della costa d’Amalfi sia stata preceduta dalla formazione di piccoli agglomerati urbani sorti nelle zone collinari dei Monti Lattari; un territorio facilmente difendibile dalle incursioni degli eserciti barbari del V secolo d.C.
Solo successivamente, con la il cessare di tale minaccia si registrò un graduale spostamento dei centri urbani verso la costa.
Per la città di Minori tale fenomeno fu sicuramente favorito dall’invenzione delle reliquie della Vergine e Martire siciliana Trofimena, che la tradizione locale riconduce al 640 d.C.
La costruzione di una prima chiesa eretta in suo onore facilitò un graduale spostamento del centro urbano verso il litorale e nei pressi dell’edificio ecclesiastico.
L’antica Reginna Minor conobbe quindi un primo e graduale sviluppo urbanistico in età medievale.
L’origine della città va ricercata nei secoli compresi fra il V e il VI, nel periodo in cui le aree interne della Campania furono devastate prima dalle invasione dei popoli di origine germanica e successivamente dalle distruzioni della guerra gotica.
Diverse, inoltre, sono state le ipotesi sull’origine del toponimo Reginna, tra queste la più accreditata è quella di Pompeo Troiano, che traduce il toponimo greco in frattura o valle, con un chiaro riferimento alla conformazione orografica della città.
L’aggettivo Minor fu introdotto per differenziarla dalla vicina e più estesa Maiori. A partire dal XIII secolo, tuttavia, l’appellativo Reginna cadde in disuso, per il fenomeno delle formazioni neolatine, per le quali l’aggettivo tende a sostituire e a cancellare l’uso del sostantivo, con la naturale conseguenza che i due centri costieri furono da allora identificati semplicemente come Minori e Maiori.
Il privilegio di conservare il corpo di S. Trofimena, Martire di Cristo e prima protettrice del Ducato Amalfitano, rappresentò l’elemento principale che determinò l’elevazione a diocesi nel 987.
Da questo momento in poi la città conobbe un notevole sviluppo urbano.
Nel 1094 iniziarono i lavori di ampliamento della prima chiesa eretta sul sepolcro della Martire, il risultato fu la cattedrale medievale, il cui spazio oggi è occupato per buona parte dall’attuale transetto della maestosa basilica settecentesca e dalla Cappella dell’Arciconfraternita del SS. Sacramento, alle cui spalle è possibile ammirare ancora due absidi.
Il modello topografico di Minori coincideva con quello degli altri centri della Costa: un centro urbano più densamente popolato intorno al quale si svilupparono alcuni piccoli villaggi rurali.
L’elemento architettonico che contraddistinse questi nuclei extramoenia sotto il profilo abitativo e produttivo fu il casale.
Edificio colonico costituito da vani abitabili e dotato di cantine, stalle, corte centrale e possedimenti terrieri.
Come le altre città della costa di origine medievale, il territorio della città di Minori era divisa in tre aree: quella marittima, quella agricola e quella urbana. L’area marittima si estendeva lungo il litorale e coincideva in gran parte con l’arenile.
Era caratterizzata da una serie di strutture, come gli scaria, installati per permettere l’attracco delle imbarcazioni.
Nella stessa area, non lontano dalla chiesa di S. Giovanni a Mare esisteva un piccolo arsenale, come ricordato dalla documentazione superstite. Sulla spiaggia di Minori, infine, erano presenti fin dall’alto medioevo diverse botteghe, di proprietà della chiesa e delle famiglie più importanti del Ducato, attive nella pratica della mercatura.
L’area agricola occupava le zone interne e collinari, qui l’attività agricola fin dal medioevo ha determinato una graduale trasformazione del territorio, caratterizzato da stupendi terrazzamenti a gradoni e da muri a secco, comunemente chiamate mecerine. Uno dei villaggi più antichi di Minori è sicuramente Villamena, il cui paesaggio non è mutato molto rispetto al medioevo.
a gradoni e da muri a secco, comunemente chiamate mecerine. Uno dei villaggi più antichi di Minori è sicuramente Villamena, il cui paesaggio non è mutato molto rispetto al medioevo.
Sulle pendici collinari ad ovest, al confine col territorio di Ravello sorge la località Auriola, mentre sul versante opposto la località Sangineto, in una posizione più elevata rispetto al centro urbano, era caratterizzata da casali attivi nella produzione agricola e nell’allevamento del bestiame. Nella zona interna sorge l’antico villaggio di Forcella, un tempo densamente abitato, come dimostra la documentazione medievale e il ricordo della presenza di antichi edifici di culto, primo fra tutti la chiesa di S. Sebastiano, la chiesa di S. Nicola a Forcella, che nel corso del Seicento fu adibito a convento e che ancora oggi sovrasta il centro urbano.
Sulle pendici del colle ad est sorgeva la località Minoli, caratterizzata dalla chiesa dell’Annunziata, di cui resta il magnifico campanile di stile arabo-
Il centro urbano era caratterizzato dalla presenza della Platea Publica, che fino alla fine dell’età moderna ospitava sia la residenza vescovile, sia le residenze delle famiglie nobili. Nelle vicinanze della piazza sorgevano tutta una serie di botteghe per la vendita al dettaglio dei prodotti tipici  della zona. L’elemento architettonico tipico era quindi la domus, una struttura di almeno tre piani, spesso circondata da orti e giardini. Ancora oggi è possibile ammirare questo tipo di costruzione molto imponente, caratterizzata dalla presenza di botteghe al pian terreno.
della zona. L’elemento architettonico tipico era quindi la domus, una struttura di almeno tre piani, spesso circondata da orti e giardini. Ancora oggi è possibile ammirare questo tipo di costruzione molto imponente, caratterizzata dalla presenza di botteghe al pian terreno.
Col trascorrere dei secoli l’assetto urbanistico della città ha subito notevoli variazioni, conserva, tuttavia, ancora l’originale aspetto di centro costiero nel quale si fondono in perfetta armonia storia, arte, attività agricola e marinara, religione, folklore e tradizioni popolari.
I suoi edifici, le sue chiese, i suoi mulini, antiche cartiere, giardini di limoni e orti evocano glorie passate e bellezze mai tramontate.
Spetta all’uomo e al cittadino della Costa d’Amalfi preservare e tutelare questo paesaggio unico nel suo genere. (Pagina a cura del Centro di Storia e Cultura “Pompeo Troiano”)
Fondazione di Casa di Minori
x
Responsabile della Comunità di Minori
Madre Elisabetta Todisco
Comunità di Minori
Attualmente le Suore appartenenti alla comunità sono:
Sr.M.Cristina Mukkath (Indiana) -
Attività nella Comunità di Minori
x
News da Minori
Minori: un luogo di vacanza e di lavoro
Paesino al centro della Costiera Amalfitana a 4 Km. Da Amalfi e 6 da Ravello
Minori, l’antica “Rheginna Minor” è oggi un delizioso paesino di circa 3500 abitanti che offre sole, mare, verdi colline coltivate a limoni degradanti verso il mare e scorci panoramici incantevoli.
Minori si avvale oltre che di bellezze naturali, anche di un passato storico ricco di eventi.
A testimonianza Interno della Basilica Santa Trofimena di Minori (SA)di ciò conserva una villa romana che fu dimora preferita dei patrizi romani.
Fu arsenale della Repubblica Amalfitana e Sede Vescovile dal 987 al 1818.
Antichissimo è il culto per S. Trofimena Vergine e Martire.
Una Santa siciliana il cui corpo è custodito a Minori dal 640.
La Santa, oriunda di Patti in provincia di Messina, venne martirizzata sotto il tirannico dominio di Diocleziano e Basilica di Santa Trofimena a Minori (SA)Massimiliano nell’ann0 314 in Sicilia.
A lei è intitolata la Scuola materna sostenuta dalla nostra Congregazione presente a Minori fin dall’inizio del secolo che ha operato nella cittadina formando generazioni di cittadini tuttora legati affettivamente alle loro istitutrici.
L’asilo è situato in uno dei quartieri più caratteristici e belli di Minori “il Petrito”, un agglomerato di case addossate l’una all’altra ed un tempo custode di tre antichissime chiese.
La casa è ampia e spaziosa ed ha subito ultimamente un considerevole intervento di ristrutturazione.
Essa è al tempo stesso festoso ed accogliente luogo di prima formazione per i bimbi della più tenera età e silenzioso rifugio per chi vuole sostare in preghiera per un assorto momento di raccoglimento dinanzi all’immagine della Beata Vergine di Pompei. (Autore: Teresa Mansi Cobalto)
Il nostro Noviziato -
Regione -
La Campania è una regione dell'Italia meridionale. Conta 5.701.931 residenti (censimento 2001 ed ha la più alta densità di popolazione tra le regioni italiane, ma è seconda dopo la Lombardia per numero totale di abitanti. Il suo capoluogo è Napoli. Confina a ovest, sud-
Città Cenni storici su Pompei
Pompei sorge su un pianoro (circa 30 m s.l.m.) formato da una colata di lava vesuviana, a controllo della valle del fiume Sarno, alla cui foce sorgeva un attivo porto.
Incerte sono le notizie sulle origini della città.
Le testimonianze più antiche si datano tra la fine del VII e la prima metà del VI sec. a.C., quando si realizza la prima cinta muraria in tufo detto 'pappamonte', che delimitava un'area di 63,5 ha.
Una civiltà 'mista', nella quale erano fusi elementi indigeni, etruschi e greci, portò allo sviluppo della città.
Verso la fine del V sec. a. C., le tribù dei Sanniti, scesi dai monti dell'Irpinia e del Sannio, dilagarono nella pianura dell'attuale Campania (che significa 'pianura fertile'), conquistando e inserendo le città vesuviane e costiere in una lega con capitale Nuceria.
In epoca sannitica Pompei riceve un forte impulso all'urbanizzazione: pure risale al V sec. a. C. la costruzione di una nuova fortificazione in calcare del Sarno, che doveva seguire un percorso analogo alla precedente.
Verso la fine del IV sec. a. C., in seguito ad una nuova pressione di popolazioni sannitiche, Roma si affaccia nell'Italia meridionale: sistemi di alleanze e vittoriose campagne militari la renderanno (343 -
Pompei entrò quindi come socia (alleata) nell'organizzazione politica della res publica romana, cui però nel 90 -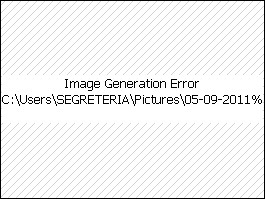 dignità socio-
dignità socio-
Dopo la deduzione della colonia Pompei fu arricchita di edifici privati e pubblici, e ulteriormente abbellita soprattutto nell'età degli imperatori Ottaviano Augusto (27 a. C.-
Nel 62 d. C. un violento terremoto colpì l'intera area vesuviana.
A Pompei la ricostruzione ebbe subito inizio, ma,per l'entità dei danni, e per lo sciame sismico che seguì, essa prese molto tempo: diciassette anni dopo, quando il 24 agosto del 79 d. C. l'improvvisa eruzione del Vesuvio la seppellì di ceneri e lapilli, Pompei si presentava come un cantiere ancora aperto.
La sua riscoperta si verificò nel XVI secolo, ma solo nel 1748 cominciò l'esplorazione, col re di Napoli Carlo III di Borbone, e continuò sistematicamente nell'Ottocento, fino agli interventi più recenti di scavo, restauro e valorizzazione della città antica e del suo eccezionale patrimonio di architetture, sculture, pitture, mosaici.
L'area archeologica di Pompei si estende per circa sessantasei ha dei quali circa quarantacinque sono stati scavati.
Le denominazioni delle case, quando non ne è noto il proprietario, sono state coniate dagli scavatori in base a particolari ritrovamenti o altre circostanze.
Il Noviziato
Dal cuore pieno di fede e di amore del Beato Bartolo Longo, nostro Fondatore alla fine del secolo XIX e all’inizio del XX, fiorisce la molteplicità delle istituzioni che caratterizzano Pompei, luogo benedetto dal Signore e dalla Madonna.
Ed è per alimentare, sostenere e vivificare queste Istituzioni che Bartolo Longo volle una “Casa Religiosa tutta propria del Santuario e opportuna alle varie opere di beneficenza sorte sotto il manto della Vergine di Pompei” (Supplica dei coniugi Longo al Card. Mazzella 4,8. 1897).
Ovunque le nostre Suore lavorano esse agiscono secondo il Carisma del Fondatore e continuano l’opera di redenzione da lui iniziata a favore dei fanciulli emarginati, poveri e bisognosi.
A sostegno di questa meravigliosa opera di promozione umana si pone la devozione alla Regina del 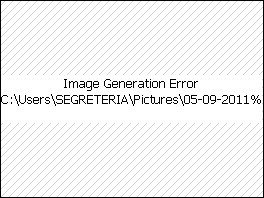 Rosario di Pompei e la propagazione del Santo Rosario.
Rosario di Pompei e la propagazione del Santo Rosario.
Ecco la nostra identità!
Ma la suora non si improvvisa: essa ha una storia: quella della propria vocazione.
Questa nasce dall’alto, è dono gratuito di Dio, che esige risposta generosa e convinta da parte di chi è chiamata.
Le iniziative di Gesù sono sempre originali; si tratta solo di avere il coraggio di vivere totalmente e liberamente la propria avventura bella ed entusiasmante della “sequela Christi”.
La culla, dunque, dove una giovane si prepara alla vita religiosa per essere domani una suora autentica e credibile, è il Noviziato, luogo dove si “temperano gli spiriti”, ci si apre alla grazia di Dio, che chiama alla sua sequela con amore di predilezione.
In una parola: ci si prepara ai futuri compiti attraverso un tirocinio fatto di studio della Parola di Dio, di esercizio delle virtù e, soprattutto, di preghiera intensa per meglio verificare la propria vocazione.
Oggi le nostre Novizie hanno una nuova dimora, bella, accogliente e dotata di un nuovo arredamento.
Responsabile del Noviziato
Madre Teodora La Montagna
Comunità del Noviziato
Attualmente le Suore appartenenti alla comunità sono:
Sr. Maria Carolina Celeste Magno (Indonesiana) -
Attività nel Noviziato
x
News dal Noviziato
x
La nostra casa di Padula (Salerno)
Regione -
La Campania è una regione dell'Italia meridionale. Conta 5.701.931 residenti (censimento 2001 ed ha la più alta densità di popolazione tra le regioni italiane, ma è seconda dopo la Lombardia per numero totale di abitanti. Il suo capoluogo è Napoli. Confina a ovest, sud-
Città di Padula
Padula si erge su un colle a 700 metri di altezza tra i picchi della serra longa (1053 m) e i monti della Maddalena al limite sud-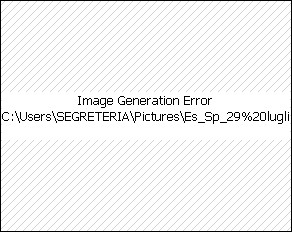 Alburni e dal massiccio del Cervati (1892 m) ed è attraversato dal fiume Tanagro in tutta la sua lunghezza per confluire nel Sele, all'estremità nord-
Alburni e dal massiccio del Cervati (1892 m) ed è attraversato dal fiume Tanagro in tutta la sua lunghezza per confluire nel Sele, all'estremità nord-
L'abitato si affianca al colle su cui anticamente sorgeva la città romana di Consilinum: Il posto dell'attuale paese viene occupato dagli abitanti di Consilinum, quando la loro città viene distrutta dalla furia devastatrice dei Saraceni.
Quindi la nascita dell'attuale abitato risale al IX-
Nel 1296 Tommaso Sanseverino entra in possesso del feudo di Padula tenuto fin ad allora dalle famiglie dei Fasanella e dei Sacchetto e con ordine di Carlo II d'Angiò erige il Castello e ne fortifica il borgo. La sua attenzione fu attratta poi dal posto in cui sorgeva la Grancia di San Lorenzo dell'Abate di Montevergine.
Nel 1305 ottenne, per permuta con l'Abate Guglielmo, tutti i beni della Grancia e li donò ai Certosini di San Brunone.
Con l'atto stipulato il 28 gennaio 1306 incominciava a sorgere il primo nucleo della Certosa che nei secoli raggiungerà splendori meravigliosi e sarà soprattutto tra le più importanti e grandi d'Europa, che ancora oggi in parte si possono ammirare.
Il borgo intanto si consolida ancora: viene edificato il primo nucleo del Castello ( oggi in piedi solo un pezzo della torre) con una possente cinta muraria ed annessa una cappella palatina ( Chiesa di San Clemente).
Nei secoli successivi Padula vive comunque all'ombra della grande Certosa, anche se lo sviluppo del borgo viene favorito dal nascere del Convento di Sant'Agostino dentro le mura e di quello di San Francesco a valle e di numerose chiese e palazzi.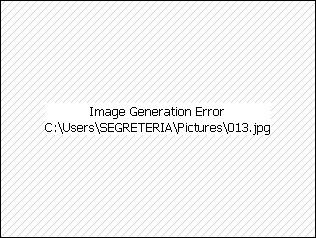 Nel Settecento la fioritura artistica si deve alle grandi capacità di abili scalpellini del posto e alla presenza di cave di pietra.
Nel Settecento la fioritura artistica si deve alle grandi capacità di abili scalpellini del posto e alla presenza di cave di pietra.
Nel corso del XIX, le vicende alterne del paese si dividono tra storie di patriottismo, peste nera e tremendi terremoti come quello del sedici dicenbre del 1857 che vede a Padula più di 50 morti e provoca danni immensi a numerose abitazioni e chiese tra cui la Chiesetta di Santa Croce ( già danneggiata, cade poi successivamente nell 'ottobre 1867 per una forte tempestata provocando 11 morti.).
Tra fine ottocento e inizio novecento si contano all'incirca 4800 partenze verso gli Stati Uniti che provocano il primo grande abbandono di Padula.Grotte di Pertosa
Superficie territoriale: 66,63 Kmq
Altitudine: 699m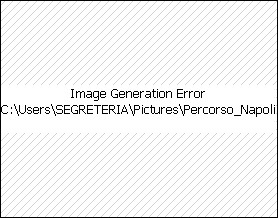
Provincia: Salerno
Popolazione residente: 5835
Densità demografica: 88 Ab./Kmq
Come Arrivare in auto
Il centro abitato si trova a 6 Km dall'uscita Autostradale Padula -
In treno la stazione ferroviaria più vicina e quella di Sapri mentre la stazione di Battipaglia e collegata dal 1987 con servizio sostitutivo su ruota.
Fondazione di Casa di Padula
Responsabile della Comunità di Padula
Madre Laura Ciafardo
Comunità di Padula
Attualmente le Suore appartenenti alla comunità sono:
Sr. Maria Angela Di Donna -
Attività nella Comunità di Padula
x
News da Padula
Un dolce sorriso e il cammino della vita diventa più facile Viviamo attimi di intensa serenità al mattino quando varchiamo l’ingresso dell’Istituto delle Suore Domenicane per accompagnare i nostri figli al loro impegno scolastico quotidiano.
La cappella ogni mattina, in gioiosa festa, ci ricorda che il cammino della vita è bello insieme a nostro Signore e le Suore ci accolgono con dolci sorrisi aprendoci la loro casa per sorreggerci con amore nell’arduo impegno di mamma e papà cristiani.
Il mio bambino, Oscar Francesco Pio, di tre anni e mezzo, frequenta la sezione di Suor Maria Virginia, e, accompagnato per mano da lei, impara a capire le cose del mondo ma, soprattutto, impara ad essere un futuro uomo che vive nel rispetto degli altri e per le cose del mondo stesso.
Suor Maria Virginia è attenta, operosa e si prodiga, affinché tutti i suoi bambini ogni giorno, abbiano qualcosa in più da lei.
Traspare questo dal mio bambino che mi strabilia con la sua crescita.
Anche in occasione del Natale appena trascorso abbiamo avuto modo di vivere momenti di grande gioia e serenità.
I ragazzi sono stati preparati degnamente da Suor Maria Virginia all’avvento della più bella festa.
Hanno condiviso il momento bellissimo dell’arrivo di Babbo Natale carico di doni, nell’atmosfera serena di un’aula festosa, addobbata con un meraviglioso albero di Natale in cui facevano da sottofondo le più belle melodie natalizie.
serena di un’aula festosa, addobbata con un meraviglioso albero di Natale in cui facevano da sottofondo le più belle melodie natalizie.
Signore Gesù, SS. Vergine di Pompei, vi prego, assistete amorevolmente queste “Figlie” affinchè possiamo godere e gioire sempre della loro presenza in mezzo a noi. (Autore: Francesca Fron)
Padula: una scuola per domani
Gioco e gioia ma anche armonia tra i più piccoli alunni dell’Istituto. Didattica di un metodo che fa riscontrare i suoi frutti produttivi a lunga scadenza.
L’obiettivo li ha colti quasi di sorpresa in momenti così gioiosi.
Sono così felici di potersi divertire sulle giostre, sulle altalene e sugli scivoli.
È il momento di relax tanto atteso. Potersi divertire con i compagni fuori dalle pareti scolastiche e rinsaldare i vincoli di amicizia con chi trascorre con loro il periodo più delicato della loro crescita fisica e spirituale. L’insegnante è con loro vigile ed attenta, madre e maestra affettuosa e premurosa che li guida e li educa alla vita che li attende.
È questo il compito della Suora educatrice – insegnante che esplica la sua attività secondo le attese della Chiesa, della famiglia e della società.
Una puntatina a Padula ci ha fatto capire quali siano i valori dell’insegnamento fin dalla più tenera età, l’importanza di far coagulare i più piccoli, attraverso il gioco.
Vengono, così, a crearsi i presupposti di crescita all’insegna di una gioia che fa nascere tra i compagni, oggi piccoli, domani uomini, il senso dell’amicizia, quindi del rispetto reciproco
La nostra Casa di Paola (Cosenza)
Regione -
Le prime tracce della presenza dell'uomo in Calabria risalgono al Paleolitico come ne testimoniano i ritrovamenti nelle grotte di Scalea e il graffito del "Bos primigenius" a Papasidero, un figura di toro incisa nella roccia 12.000 anni fa.
Durante l'era dei metalli giunsero nuove popolazioni, uno degli insediamenti più importanti risalente a quel periodo è il complesso di Torre Galli nei pressi di Vibo Valentia.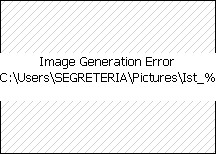
Mitologia e periodo italico
Il primo nome della Calabria sarebbe stato "Aschenazia", dal suo primo leggendario abitatore Aschenez, ritenuto Coste limpide e turchesi tipiche della Calabriapronipote di Noè.
Egli sarebbe approdato sulla costa dove oggi sorge Reggio Calabria che, a memoria della leggenda, ha intitolato a lui una strada, via Aschenez appunto.
Secondo il mito greco, circa 850 anni prima della guerra di Troia, vi sarebbero giunti Enotrio e Paucezio, di stirpe enotria e pelasgica, originari della Siria che, trovando il suolo molto fertile, chiamarono la regione "Ausonia" in ricordo dell'"Ausonide", fertile zona della Siria.
Secondo la leggenda Enotrio avrebbe regnato per 71 anni e alla sua morte gli sarebbe succeduto il figlio Italo ("uomo forte e savio" secondo quanto narra Dionigi di Alicarnasso), dal quale l'Ausonia avrebbe preso il nuovo nome di "Italia", come riportano Tucidide ("quella regione fu chiamata Italia da Italo, re arcade") e Virgilio (Eneide, III).
Nel periodo italico la Calabria fu abitata, oltre che da Itali, Ausoni ed Enotri, principalmente dai Bruzi (o Bretti), popolo di origine indoeuropea di linguaggio osco e temperamento bellicoso.
Periodo greco
Di fondamentale importanza è lo sbarco dei Greci sulle coste calabresi, i quali strapparono le terre ai Bruzi (costretti a rifugiarsi nell'entroterra e nella parte settentrionale della Calabria), e si mescolarono con gli altri popoli autoctoni, dando vita ad una cultura meticcia, estremamente florida nei secoli successivi.
I Greci fondarono fiorenti colonie, così magnificenti da guadagnarsi l'appellativo di Magna Grecia (Grande Grecia), così importanti da superare, in alcuni casi, la stessa madrepatria.
Tra il VI ed il V secolo a.C. infatti fiorivano su tutta la costa numerose ed importanti città della Magna Grecia, come Rhegion, Kroton, Locri Epizefiri, Sybaris, e numerose sub-
Dopo la conquista da parte dei Romani, nel III secolo a.C., i territori assunsero la denominazione di "Brutium" ma, a parte alcune città alleate, dunque non sottomesse all'utorità di Roma, gran parte della regione non fu in grado di ritrovare la prosperità di un tempo.
Le poleis magnogreche erano quindi destinate a perdere il proprio potere in favore di un'alleanza (in alcuni casi) o di una colonizzazione romana.
Unica roccaforte della lingua e cultura greca rimaneva Reggio (tra l'altro sede del Corrector, governatore della Regio III Lucania et Bruttii), che attraverso la Via Popilia collegava il suo porto con Roma; città abitate dai Bruttii erano le colonie di Vibo Valentia, Locri, Crotone, Sibari e Cosenza all'interno del territorio.
Medioevo
Con la caduta dell'Impero, la Calabria fu devastata dalle guerre gotiche, tra questi e i bizantini, i quali ebbero la meglio sui longobardi. I Bizantini così aggregarono la regione del Bruzio con le terre possedute nel Salento, formando il Ducato di Calabria.
Successivamente il dominio bizantino in Italia meridionale fu diviso in: Thema di Langobardia, con capitale Bari, e Thema di Calabria, con capitale Reggio.
Quest'ultimo territorio aveva dunque ereditato il nome "Calabria", precedentemente usato per designare la penisola salentina.
Durante l'alto medioevo gli abitanti furono spinti verso l'interno della regione sia dalle pestilenze che dalle incursioni piratesche, una vera minaccia per gli insediamenti costieri, continuata fino alla fine del XVIII secolo.
Numerose furono infatti le fortificazioni collinari e montuose nell'entroterra calabrese, costituita da villaggi arroccati in posizione sufficientemente arretrata e inaccessibile da poter avvistare in tempo le navi nemiche e sbarrare prontamente le vie d'accesso ai centri abitati.
Nel IX e X secolo la Calabria, fu terra di confine tra i Bizantini e gli Arabi insediatisi in Sicilia, che si contesero a lungo la penisola, soggetta a razzie e schermaglie, spopolata e demoralizzata, ma con gli importanti monasteri greci, vere e proprie roccaforti della cultura.
Le corti normanne
Alla lunga contesa arabo-
Il governo così organizzato fu messo in atto dai locali magnati greci.
Il dominio viene esteso alle Puglie e da questo momento ha termine ogni pertinenza bizantina.
Roberto conferma in Reggio la capitale del Ducato di Puglia e di Calabria e sede del giustizierato di Calabria, nominandosi egli steddo Duca;
Ruggero è invece Conte di Calabria, vassallo del fratello Roberto, con sede a Mileto.
Nel 1098, Papa Urbano II investì Ruggero del ruolo di nunzio apostolico e gli Altavilla con la loro dinastia divennero precursori del Regno di Napoli o Regno delle due Sicilie che dominò la Calabria fino all'unità d'Italia.
Lo stesso Regno di Napoli subì diverse dominazioni: le dinastie degli Asburgo, di Spagna e d'Austria, la dinastia francese dei Borbone, e per un breve periodo il generale di Napoleone, Gioacchino Murat, che fu giustiziato nella cittadina di Pizzo.
Ultimi secoli
L'Aspromonte, regione montana nel sud della Calabria, in provincia di Reggio, fu scenario di una famosa battaglia del Risorgimento, in cui Giuseppe Garibaldi rimase ferito.
È tutt'ora possibile ammirare l'albero cavo in cui secondo la tradizione Garibaldi si sedette per essere curato, nei pressi della località sciistica di Gambarie, vicino a Reggio Calabria.
Città
x
Fondazione della Casa di Paola
L’Istituto di Paola
Come un personaggio biancovestito l’Istituto Magistrale di Paola, proteso verso l’eterno, incurante del mondo, è come una sentinella vigilante, conservando un passato ed ancora oggi è speranza sul cammino dei giovani.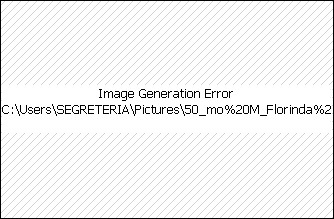 Da più di settant’ anni, Paola, la cittadina calabra posta in faccia ai chiarori del mare e sotto l’ usbergo del suo più illustre figlio, ospita l’ Istituto Magistrale, diretto dalle Suore del Santo Rosario di Pompei.
Da più di settant’ anni, Paola, la cittadina calabra posta in faccia ai chiarori del mare e sotto l’ usbergo del suo più illustre figlio, ospita l’ Istituto Magistrale, diretto dalle Suore del Santo Rosario di Pompei.
L’edificio, che sorge quasi al centro dell’abitato, è diventato come il nucleo principale della cultura umanistica e della formazione spirituale, nella zona, per migliaia di alunne.
Ho avuto l’impressione, la prima volta che visitai l’Istituto, era un mattino della tarda primavera di tanti anni fa, di trovarmi davanti ad un grande alveare, verso cui convergono, da ogni strada, le alunne come sciami d’api.
Quella scena si ripete ancora oggi, anzi più di ieri, per il gran numero di ragazze che frequentano l’ Istituto, dando la sensazione che non si è ancora esaurita la carica affettiva di cui sono dotate quelle madri biancovestite, che, come angeli, tutelano il sapere e i costumi delle giovani studentesse.
La presenza delle Suore Domenicane in Paola è valida più di un sole in un grande meriggio estivo.
Infatti, l’alta funzione che esse svolgono a favore della gioventù, getta il germe della scienza e consolida quei principi cristiani, per i quali Francesco di Paola e Caterina da Siena, i Santi protettori dell’ Istituto Magistrale, hanno lavorato per una vita intera.
Tutte protese verso Dio e verso i fratelli, le Suore Domenicane, in giornate laboriose spendono, a favore della gioventù affidata alle loro cure, tutti quei talenti che esse hanno ricevuto dal Signore, e con il dono della vita e con quello della vocazione.
L’Istituto Magistrale, dopo mezzo secolo, restaurato nella facciata, è come un vigile ieratico, posto ai margini della strada della vita, per indicare il retto cammino a quanti, nell’epoca presente, desiderano avere un orientamento sicuro.
Il cuore dell’ Istituto batte davanti alla sacra immagine della Madonna del Santo Rosario di Pompei, che troneggia sopra un altare, davanti al quale, al mattino, si ode come un ronzio, che si fa sempre più insistente e più ritmato, tanto da diventare preghiera corale: sono le alunne che iniziano il lavoro del giorno salutando la Madre, mentre gli alberi del piazzale filtrano la musica del vento.
Il colore bianco fa da padrone nel vasto complesso architettonico, quasi come un desiderio della Beata Vergine accolto dalle Suore e dalle alunne, che perpetuano nel vestito la beatitudine evangelica della purità.
Quando ci si trova nei vasti corridoi con il via vai di Suore e di studentesse, si ha l’ impressione di trovarsi in una assolata giornata di luglio, quando il sole picchia sulle pietre, e gli occhi fan fatica a reggere l’abbaglio dei riflessi bianchi.
Chi per primo ha avuto la felice idea di far sorgere in Paola, diventata polo di attrazione per la devozione straordinaria al Santo eremita Francesco, L’Istituto delle Suore Domenicane, ha certamente assecondato, con pensiero lungimirante, i desideri di tutti i genitori che scelgono il pio Istituto per la formazione dei loro figli.
Chi scrive è spettatore dell’attività socio-
L’amore allo studio, le lezioni scolastiche impartite con serietà e costanza, il senso cristiano del dovere, che prepara un radioso domani alle alunne, i principi di sana educazione e di rispetto vicendevole, sono il programma dell’Istituto.
Le garanti di tutto questo sono sempre loro, le bianche Suore, la cui presenza è una fiducia, il cui sorriso è un saluto, la cui gentilezza è una rarità, la cui guida è una sicurezza.
Nell’ora presente, quando certi valori sono emarginati e sembra calare la notte sul mondo, numerosi fuochi ardono ancora, alimentati dal cuore consacrato di anime generose, pronte al servizio: le Suore e tra queste le Domenicane dell’ Istituto paolano. (F. Frangella)
Responsabile della Comunità di Paola
Madre Giuditta Santo
Comunità di Paola
Attualmente le Suore appartenenti alla comunità sono:
Sr.M.Agnese Pullamplavil (Indiana) -
x
La Cappella dell’Istituto di Paola
Il restauro della Cappella dell’Istituto delle Suore Domenicane è degno di menzione, spinti da un bisogno di encomio per quanti, Superiori di Pompei e di Paola, hanno voluto dare un volto nuovo alla Cappella dell’Istituto.
Ad un anno dalla inaugurazione del sacro luogo, il 4 dicembre del 1994, incastonata come una gemma nel diadema dell’intero edificio, esso riverbera le voci lontane di tante religiose che qui hanno meditato e di tante studentesse che qui hanno pregato.
Ora che la Cappella ha mutato vestito, quando dai monti sovrastanti spunta un nuovo giorno e un’esplosione di luce accende le campagne e si adagia sui tetti di Paola come una promessa di pace, il verde e l’azzurro, arabescati sulle vetrate come scie di angeli in volo, sembrano colori piovuti dal cielo.
Il restauro della Cappella si è reso necessario per esigenze architettoniche ed artistiche dei tempi moderni, che, al barocco, sostituiscono le linee semplici e luminose, in armonia con il linguaggio di quella gioventù che costruisce ogni giorno in questo luogo il suo domani.
Chi entra nella Cappella, rinnovata, ha l’impressione che il colore riposante delle pareti invogli il visitatore a spingere lo sguardo verso l’altare, dove l’immagine della Beata Vergine del Rosario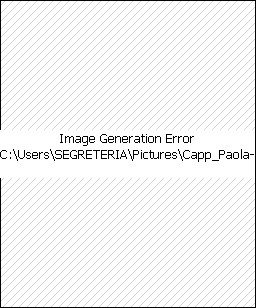 sembra proteggere il ciborio sottostante e sorridere ai devoti che ivi sostano per porgere un saluto alla Madre celeste e chiedere a Lei un aiuto.
sembra proteggere il ciborio sottostante e sorridere ai devoti che ivi sostano per porgere un saluto alla Madre celeste e chiedere a Lei un aiuto.
Le Suore Domenicane hanno il merito di tenere aperta la loro Cappella come un grande libro colorato dove ogni studentessa può leggere la propria storia, fatta di operosità nello studio e di bontà nel loro quotidiano.
Par di percepire ancora, sostando in preghiera nella Cappella, le parole consacratorie con le quali il Vescovo di Pompei preparò l’altare del sacrificio in quel mattino di dicembre in cui la casa delle religiose sembrava tutto un Vangelo e tutto il mondo un cielo su quell’altare. La Cappella, vestita a festa, è là; essa invita alle soste meditative, mentre i quadri della Via Crucis, interamente rinnovata, sembrano tanti devoti pellegrini in cammino verso Dio, e la preghiera dei visitatori par un linguaggio arcano che si accompagna all’incenso dell’altare. (Autore: Franco Frangella)
News da Paola
L’Istituto di Paola (La voce del Filosofo F. Frangella)
Da più di settant’anni, Paola, la cittadina calabra posta in faccia ai chiarori del mare e sotto l’usbergo del suo più illustre figlio, ospita l’Istituto Magistrale, diretto dalle Suore del S. Rosario di Pompei.
L’edificio, che sorge quasi al centro dell’abitato, è diventato come il nucleo principale della cultura umanistica e della formazione spirituale, nella zona, per migliaia di alunne.
Ho avuto l’impressione, la prima volta che visitai l’Istituto, era un mattino della tarda primavera di tanti anni fa, di trovarmi davanti ad un grande alveare, verso cui convergono, da ogni strada, le alunne come sciami d’api.
Quella scena si ripete ancora oggi, anzi più di ieri, per il gran numero di ragazze che frequentano l’Istituto, dando la sensazione che non si è ancora esaurita la carica affettiva di cui sono dotate quelle madri biancovestite, che, come angeli, tutelano il sapere e i costumi delle giovani studentesse.
La presenza delle Suore Domenicane in Paola è valida più di un sole in un grande meriggio estivo.
Infatti, l’alta funzione che esse svolgono a favore della gioventù, getta il germe della scienza e consolida quei principi cristiani, per i quali Francesco di Paola e Caterina da Siena, i Santi protettori dell’Istituto Magistrale, hanno lavorato per una vita intera.
Tutte protese verso Dio e verso i fratelli, le Suore Domenicane, in giornate laboriose spendono, a favore della gioventù affidata alle loro cure, tutti quei talenti che esse hanno ricevuto dal Signore, e con il dono della vita e con quello della vocazione.
L’Istituto Magistrale, dopo mezzo secolo, restaurato nella facciata, è come un vigile ieratico, posto ai margini della strada della vita, per indicare il retto cammino a quanti, nell’epoca presente, desiderano avere un orientamento sicuro.
Il cuore dell’Istituto batte davanti alla sacra immagine della Madonna del Santo Rosario di Pompei, che troneggia sopra un altare, davanti al quale, al mattino, si ode come un ronzio, che si fa sempre più insistente e più ritmato, tanto da diventare preghiera corale: sono le alunne che iniziano il lavoro del giorno salutando la Madre, mentre gli alberi del piazzale filtrano la musica del vento.
Il colore bianco fa da padrone nel vasto complesso architettonico, quasi come un desiderio della Beata Vergine accolto dalle Suore e dalle alunne, che perpetuano nel vestito la beatitudine evangelica della purità.
Quando ci si trova nei vasti corridoi con il via vai di Suore e di studentesse, si ha l’impressione di trovarsi in una assolata giornata di luglio, quando il sole picchia sulle pietre, e gli occhi fan fatica a reggere l’abbaglio dei riflessi bianchi.
Chi per primo ha avuto la felice idea di far sorgere in Paola, diventata polo di attrazione per la devozione straordinaria al Santo eremita Francesco, L’Istituto delle Suore Domenicane, ha certamente assecondato, con pensiero lungimirante, i desideri di tutti i genitori che scelgono il pio Istituto per la formazione dei loro figli.
Chi scrive è spettatore dell’attività socio-
L’amore allo studio, le lezioni scolastiche impartite con serietà e costanza, il senso cristiano del dovere, che prepara un radioso domani alle alunne, i principi di sana educazione e di rispetto vicendevole, sono il programma dell’Istituto.
Le garanti di tutto questo sono sempre loro, le bianche Suore, la cui presenza è una fiducia, il cui sorriso è un saluto, la cui gentilezza è una rarità, la cui guida è una sicurezza.
Nell’ora presente, quando certi valori sono emarginati e sembra calare la notte sul mondo, numerosi fuochi ardono ancora, alimentati dal cuore consacrato di anime generose, pronte al servizio: le Suore e tra queste le Domenicane dell’Istituto paolano.
La nostra Casa di Parrelle -
Regione -
La Campania è una regione dell'Italia meridionale. Conta 5.701.931 residenti (censimento 2001 ed ha la più alta densità di popolazione tra le regioni italiane, ma è seconda dopo la Lombardia per numero totale di abitanti. Il suo capoluogo è Napoli. Confina a ovest, sud-
Città
x
Fondazione di Casa di Parrelle
Da oltre 50 anni le Suore nella Comunità di Parrelle
Per il Parroco della frazione di Parrelle è un dono grande avere come collaboratrici nell’attività pastorale le Suore “Figlie del S. Rosario di Pompei”.
La loro azione educatrice o di servizio alla Chiesa, tocca giornalmente il sacrificio nascosto, forse non sempre valutato dalle persone per le quali lo compiono; esse camminano gioiose e instancabili per essere ogni giorno testimoni della bontà e dell’amore di Cristo e propagatrici del S. Rosario.
per essere ogni giorno testimoni della bontà e dell’amore di Cristo e propagatrici del S. Rosario.
Lo afferma chi con esse collaborano, con viva soddisfazione, dopo cinquanta anni di attività da esse svolta nella Parrocchia di S. Maria Assunta.
Andarono nella Parrocchia il 15 dicembre 1956 per disposizione dell’Amministratore Apostolico del tempo Mons. Giovanni Foschini.
Il mandato era di prestare il loro aiuto al Parroco nella catechesi, nella istruzione dei bambini dell’asilo, nella direzione dell’Associazione Femminile di Azione Cattolica e del servizio liturgico.
Nell’arco di cinquant’ anni la loro presenza è stata assai fattiva e preziosa. Le prime comunioni dei bambini sono state accuratamente preparate; hanno saputo entusiasmare ed interessare tutti, ma soprattutto hanno cercato di infondere nell’animo di tutti la luce di Dio che dà valore alla vita.
La prima Superiora “Fondatrice” di questa attività è stata Sr. Maria Dorotea, il cui ricordo rimane sempre più vivo e desiderabile. La superiora attualmente in carica, tanto geniale nel suo lavoro, è Madre Agnese. 
Da ricordare con tanta stima e venerazione Sr. M. Ippolita, Sr. M. Clelia, Sr. M. Gemma, Sr. M. Gioconda, Sr. M. Annunziata: tutte hanno lasciato una scia luminosa di bene pastorale.
Responsabile della Comunità di Parrelle
Madre Anselma German (Filippina)
Comunità di Parrelle
Attualmente le Suore appartenenti alla comunità sono:
Sr. M. Domenica (Italiana) -
x
News da Parrelle
x
Regione -
Il Latium, territorio originariamente abitato dai Latini, con l'ampliarsi delle conquiste romane, incluse anche i paesi degli Ernici, degli Equi, degli Aurunci e dei Volsci, così che i suoi confini vennero estesi fino ai Marsi, ai Sanniti e alla Campania. Questo nuovo e più ampio territorio prese il nome di Latium novum in contrasto con il Latium vetus, che indicava il Lazio nella sua primitiva estensione. Nell'ordinamento amministrativo dell'Italia, ad opera di Augusto, il Lazio, costituì insieme con la Campania la I regione, divenendo di fatto estensione di Roma. Questa regione tornò ad avere una storia autonoma solo dopo la guerra gotica (535- il generale Cadorna entrò in territorio pontificio (12 settembre), occupando Roma il 20 settembre.
il generale Cadorna entrò in territorio pontificio (12 settembre), occupando Roma il 20 settembre.
Città -
Fondazione della Casa di Roma
La Casa di Roma svolge l’importante ruolo di “Casa d’accoglienza” sia per i Superiori e i Sacerdoti della Prelatura di Pompei sia per le nostre Suore che, per motivi vari, si recano nella capitale per brevi soggiorni.
Chi si reca a Roma è sicuro di trovare un’ospitalità fatta di calore umano e di fraterna disponibilità per tutto quanto occorre. Nessun segno di noia o di stanchezza, ma volti gioviali e sorridenti che ti danno carica per soggiorni piacevoli.
Vi esprimiamo, dunque, carissime sorelle romane, un grazie sentito ed affettuoso per il vostro delicato lavoro.
Responsabile della Comunità di Roma
Madre
Comunità di Roma
Attualmente le Suore appartenenti alla comunità sono:
Sr. Maria Dorotea Sedong (Indonesiana) -
Attività nella Comunità di Roma
x
News da Roma
x
La nostra Casa di Santa Maria Capua Vetere (Caserta)
Regione -
La Campania è una regione dell'Italia meridionale. Conta 5.701.931 residenti (censimento 2001 ed ha la più alta densità di popolazione tra le regioni italiane, ma è seconda dopo la Lombardia per numero totale di abitanti. Il suo capoluogo è Napoli. Confina a ovest, sud-
Città
x
Fondazione della Casa di Santa Maria Capua Vetere
“Rileggendo” nei ricordi della mente di una testimone…
Melina TeMadre Carmela Caianellorlizzi così testimonia: ben volentieri mi accingo a parlare delle Suore Domenicane del Santo Rosario di Pompei in Santa Maria Capua Vetere, conosciute nel lontano 1958.
Ricordi di guerra e di disordine mi vengono alla mente poiché il luogo dove oggi sorge la bellissima casa delle Suore Domenicane, un tempo ci ospitava per proteggerci dai bombardamenti nei suoi ricoveri.
I donatori: il Canonico Don Giovanni Aveta e le sorelle Anna e Adelina, rimasti soli e bisognosi di assistenza in uno stabile immenso, pensarono di chiedere aiuto alle suore.
La Madonna che ci voleva dimostrare la sua protezione e il suo amore fece casualmente incontrare Suor Maria Serafina con Mons. Giovanni Aveta in un luogo di pena, il “Carcere di Santa Maria” dove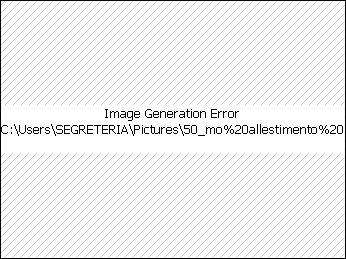 la Suora accompagnava le bambine, ricoverate negli Orfanotrofi di PompeSr. Maria Serafina Natellai, a visitare i genitori detenuti.
la Suora accompagnava le bambine, ricoverate negli Orfanotrofi di PompeSr. Maria Serafina Natellai, a visitare i genitori detenuti.
Ma chi era Suor Maria Serafina? potremmo chiamarla la Suora delle carceri.
Le visitò tutte, dall’Italia settentrionale alla Sicilia, accompagnando le bambine dell’Istituto “Sacro Cuore” in visita ai loro genitori.
Non era la sua una visita fredda, di abitudine, ma andava per compiere una missione, in ossequio al comando di Gesù “visitare i carcerati” per confortarli, renderli più miti, per avvicinarli a Dio e alla famiglia e per aiutarli a rientrare nella Società con spirito nuovo. Gli ostinati cedevano al suo richiamo come figliuoli dinanzi alla Madre.
Questo pellegrinaggio carcerario di Suor Maria Serafina è durato 25 anni, e lo compiva due volte all’anno.
Anche dopo un serio intervento chirurgico Suor Maria Serafina, per tre mesi, affrontò la fatica del viaggio compensata dalla gioia di rivedere quei “buoni figliuoli” che ansiosi ne attendevano l’arrivo.
Volò al cielo il 28 settembre 1964; entrava in a11 settembre 1958 Ore:16,30gonia al suono delle campane per la funzione serale, spirava dopo la benedizione al canto del Magnificat, quando, come assicurò il Padre Leone Radente (Redentorista) a Bartolo Longo, scendono schiere d’ angioli dal trono della Madonna a confortare i vivi e a confortare i moribondi.
Fu una morte dolce, un volo placido di colomba. “Dio mi vuole”, disse fioca, e reclinò il capo. Un’incidenza preziosa c’è nella sua morte. Moriva all’antivigilia della festa di Santa Caterina da Siena, la Sorella Maggiore dell’Ordine Domenicano, alla quale Suor Maria Serafina era tanto legata.
Lo sottolineò Sua Ecc. Mons. Aurelio Signora nei funerali, celebrati il giorno appresso. Fu Santa Caterina messaggera di pace, e Suor Maria Serafina ne seguì le orme e lo spirito portando la pace, gioia, sorriso e grazia nei luoghi di tristezza e di pena.15 maggio 1960
“Suor Maria Serafina – disse Sua Eccellenza alle novizie – ha passato a voi la fiaccola della verità”; l’ha passata a tutta la famiglia del Santuario e splende questa fiaccola nel suo esempio e nella sua carità. Ancora una stella della nostra famiglia rosariale s’aggiunge a far lume al trono di Maria.
In detto luogo a Mons. Giovanni Aveta venne l’idea di donare alla Congregazione della Madonna del Rosario la propria casa.Mons. con la sorella Adele Aveta
Il 6 settembre 1958, alle ore 16,30 arrivarono le prime quattro Suore: Madre Carmela, Sr. Maria Santina, Sr. Maria Melania e Sr. Maria Dolores che portarono nella nostra Parrocchia una ventata spirituale mai conosciuta prima, veri angeli apportatori di serenità, amore e gioia.
Le Suore con la loro capacità entrarono subito nel cuore della nostra gente, operando prima con l’istituzione di un laboratorio, con l’Asilo e poi con un primo ciclo di Scuola Elementare seguito in breve tempo da un secondo, fino ad ottenere nel 1987 la Parifica.
Le attività scolastiche con la ristrutturazione dell’edificio sono andate sempre migliorando, adegMons. con la sorella Anna Aveta in Pinnauandosi alle ultime norme igienico-
Vorrei ora poter dire ed esaltare tutto quello che le Suore hanno dato e danno per la Comunità Parrocchiale, esse sono attive per le Celebrazioni Liturgiche dando il loro apporto sia per il canto che per animazioni varie. Sono delle valide Catechiste e collaborano alla diffusione della Parola e del Pane come Ministri Straordinari dell’Eucaristia; fanno parte del Consiglio Pastorale ed aprono la loro casa a tutte le esigenze parrocchiali; disponibilità di aule per la catechesi, conversione del cortile in Chiesa sia durante la ristrutturazione della Chiesa Parrocchiale, sia per le Celebrazioni comunitarie di massa.
Tutto ciò che oggi ci offre l’ Istituto e le suore che continuano l’opera, non è stato facile, ma alle prime suore è costato grossi sacrifici poiché la casa donata era coabitata e non era del tutto idonea agli scopi prefissi, addirittura le prime suore hanno sofferto per la mancanza del necessario; l’unico conforto poteva essere Gesù Sacramentato, ma poiché la chiesetta era pericolante, hanno dovuto aspettare che venisse ristrutturata.
Finalmente il 1 gennaio 1959 poterono, alla presenza di amici e molte persone del luogo, fare una gioiosa celebrazione e far passare il messaggio che la Madonna desiderava: la divulgazione della devozione alla cara Mamma di Pompei.
Non è mancato in tutto questo la spinta, il conforto e l’interessamento di Mons. Gino D’Avighi, Amministratore del Santuario di Pompei, che ne ha voluto fortemente la realizzazione.
Responsabile della Comunità di Santa Maria Capua Vetere
Madre Florinda Capasso
Comunità di Santa Maria Capua Vetere
Attualmente le Suore appartenenti alla comunità sono:
Sr. Maria Aurelia Grasso (Italiana) -
Attività nella Comunità di Santa Maria Capua Vetere
La nostra Comunità di “S. Maria C. V.” è composta da nove Suore.
C’ impegniamo maggiormente nella missione svolgendo il nostro lavoro con amore e fedeltà.
Le nostre mansioni sono diverse: scuola, apostolato parrocchiale, studio.
La nostra Comunità religiosa si trova ad esercitare proprio quella forma di apostolato per la quale è nata la Congregazione: l’accoglienza dei più poveri, l’educazione religiosa e l’istruzione dei giovani, attraverso il servizio della Catechesi e della Scuola che rappresenta lo strumento principale di promozione umana e di evangelizzazione.
Il Sabato ci vede impegnate nella Catechesi a tutte le fasce presenti sul territorio e, la Domenica, nel servizio d’animazione liturgica nella parrocchia di S. Pietro Apostolo a S. Maria C. V. 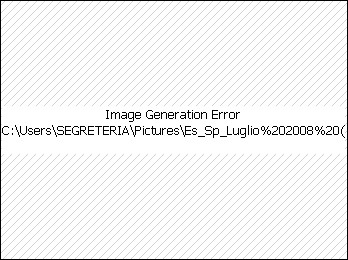 Nel mese di maggio propaghiamo e recitiamo il Santo Rosario nelle dieci zone in cui è divisa la parrocchia, mentre durante il mese di ottobre divulghiamo lo stesso Rosario nella parrocchia stessa. Ogni terzo giovedì del mese facciamo comunità con i fedeli della parrocchia per adorare Gesù Eucaristia.
Nel mese di maggio propaghiamo e recitiamo il Santo Rosario nelle dieci zone in cui è divisa la parrocchia, mentre durante il mese di ottobre divulghiamo lo stesso Rosario nella parrocchia stessa. Ogni terzo giovedì del mese facciamo comunità con i fedeli della parrocchia per adorare Gesù Eucaristia.
Questo vuole essere una grande preghiera di lode a di ringraziamento, soprattutto, per il dono dSimpaticamente insiemeell’Incarnazione del Figlio di Dio e della redenzione da Lui operata.
Inoltre, partecipiamo ogni quindici giorni, con tutti gli operatori pastorali, alla formazione permanente che ci aiuta a svolgere con competenza il lavoro parrocchiale.
C’impegniamo ad essere “specchio di vita” per gli altri, cominciando da chi ci sta accanto e condividendo la stessa mensa, gli stessi ideali, le proprie gioie e dolori, in un contesto di serena stima e di cordiale accoglienza.
Nelle nostre attività, anche per questo anno, chiediamo la benedizione di Maria, nostra Madre, l’intercessione del nostro grande fondatore Beato Bartolo Longo perché il tutto possa aver efficace compimento.
La “voce” di chi ci conosce
Ecco la “VOCE” di chi ci conosce, di chi ci osserva e ci ammira, di chi loda l’attività, la preparazione, la profonda umanità e l’amore delle nostre Suore nella Casa di Santa Maria Capua Vetere.
Ascoltiamola e confrontiamoci …
Le Superiore della Casa di Santa Maria Capua Vetere
Ben otto Suore si sono alternate alla guida dell’Istituto “Antonio Aveta” di Santa Maria Capua Vetere (Ce), è doveroso qui citarle, riportando (cliccando sulla rispettiva foto), una breve scheda con le notizie generali relative alla loro vita.
Nei vari carteggi relativi a queste Suore evince sempre un loro particolare attaccamento alla Casa e al Paese. Tutte hanno lavorato con entusiasmo e piacere per il bene collettivo. In particolare va menzionata l’ottava Superiora, Madre Florinda Capasso, per la quale si fece richiesta di rinnovare l’incarico di Superiora anche oltre i termini previsti dalla normativa vigente, con dispensa a norma del Can. 505.
1ª Madre Carmela Caianiello (1958-
2ª Madre Matilde Caputo (1969-
3ª Madre Annunziata Granata (1971-
4ª Madre Fernanda Cota (1978)
5ª Madre Chiara Marinelli (1979-
6ª Madre Annunziata Granata (1984-
7ª Madre Natalia Todisco (1987-
8ª Madre Florinda Capasso (1990 e continua)
Sulle onde dei ricordi
Volete sapere com’era la nostra ex scuola? Beh, all’Istituto “Antonio Aveta” ci siamo sentite tanto unite con i nostri compagni.
Era quasi come se fossimo stati tutti fratelli e sorelle: ci capivamo solo guardandoci, non litigavamo quasi mai… certo, qualche lite c’era, ma ci scusavamo sempre gli uni con gli altri.
Ma a chi dobbiamo ciò?
Chi ci ha insegnato ad amare e non odiare, chi ci ha insegnato a fare pace o a chi chiedere scusa invece di litigare?
Le Suore vigili, ma allo stesso tempo comprensive nei nostri confronti, le maestre esigenti, ma allo stesso tempo dolci ed in grado di donarci un sorriso…
Tutto quello che abbiamo imparato sul senso della vita lo dobbiamo a loro!
Ma attenzione: le Suore non ci hanno insegnato solo a voler bene, bensì ci hanno donato preziosi insegnamenti!
Le ore di italiano, di matematica, di storia, di geografi a, di musica, di religione, di inglese… non sono mai state noiose!
Gli insegnamenti erano arricchiti da giochi in compagnia: ecco come il nostro cervello, da minuscola nocciolina che era, è diventato grande come un’arancia. 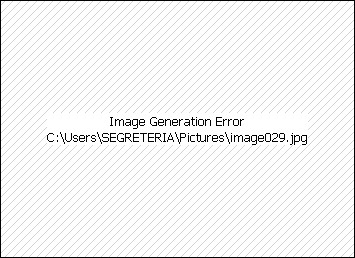 Via via, il nostro sapere si è allargato anno dopo anno sempre più.
Via via, il nostro sapere si è allargato anno dopo anno sempre più.
Ah, quanti ricordi abbiamo del nostro cortile in cui trascorrevamo le ricreazioni giocando tutti insieme!
Ogni mese aspettavamo il giorno dell’ ”Aveta Film Festival”, un momento in cui tutta la scuola si riuniva per fare una pausa lontano dallo studio.
Per non parlare dei saggi di fine anno, momenti indimenticabili, in cui ci divertivamo a mostrare le nostre abilità di ballerini.
Ci manca la scuola, le Suorine e la Madre Superiora compagna di emozioni, abbracci e baci e… Basta così, usciamo dalle onde dei ricordi perché i nostri occhi non riescono più a contenere le lacrime… tanto i ricordi rimarranno indelebili nel nostro cuore di ex alunne. (Autrici: Roberta Tamburrino e Marta Piccirillo)
Inaugurazione anno scolastico all’Istituto “Aveta”
7 Ottobre 2013: Inaugurazione apertura dell’ Anno Scolastico all’Istituto “A.Aveta” “Padre della luce, fa’ di alunni e docenti i discepoli di quella sapienza che ha come libro, cattedra e maestro il Cristo Tuo Figlio, assisti e proteggi tutti i membri della comunità educante, perché le nuove generazioni siano promosse nella scuola e nella vita; aiutaci a dare un valido contributo all’edificazione della civiltà dell’amore”.
È questo lo spirito che ha animato l’inaugurazione dell’Anno Scolastico 2013/2014che si è svolta presso la palestra del nostro Istituto, presieduta dalla nostra carissima Madre Superiora, Madre Florinda Capasso.
È stata scelta la data del 7 ottobre affinché la Beata Vergine del Rosario di Pompei ci accolga sotto il suo manto miracoloso, nel giorno e nel mese dedicato a Lei.
Guidati dalla sapiente Suor Maria Aurelia, gli alunni hanno animato il momento di preghiera con canti, preghiere ed invocazioni al Signore, hanno posto nelle sue mani il cammino che ci sta davanti ed hanno invocato la sua benedizione e protezione, affinché questo nuovo anno sia momento di crescita e di grazia.
Inoltre docenti, alunni e genitori hanno letto una preghiera di ringraziamento per la scuola e per tutti gli operatori affinché ognuno con rinnovato entusiasmo, riesca a trasmettere agli alunni la bellezza dell’amore del padre.
Alla fine è stata recitata la Supplica alla Beata Vergine di Pompei, grande testamento spirituale di Bartolo Longo, fondatore della nostra comunità e diffusore dei principi che animano l’operato delle nostre Suore: carità, accoglienza, volontà di educare i fanciulli nella fede e nell’amore.
Colmi di entusiasmo e di serenità ci siamo scambiati gli auguri di un “Buon Anno Scolastico” sulle note di un canto alla Regina del Rosario di Pompei. (Fonte: Buonanno Clotilde)
La festa dei 60 anni di Vita Religiosa della nostra Super/Superiora
Le Suore e le Maestre hanno organizzato una bella festa nella quale abbiamo cantato, abbiamo preparato anche un momento di preghiera durante la quale, io e i miei compagni, ci siamo commossi.
Ad un certo punto la Superiora ha raccontato i giorni belli della sua vita e ha anche parlato dei suoi genitori.
Era presente il Parroco, Don Rosario Ventriglia, che ha benedetto tutti noi bambini, le maestre, le suore e le medagline miracolose che poi abbiamo messo con orgoglio e gioia grande, medagline che hanno avuto per noi un valore affettivo inestimabile.
Una delle maestre ha letto un passo preso dalla Bibbia esortando noi bambini a ripetere delle monizioni inerenti alla stessa sua lettura. I bambini della scuola dell’Infanzia hanno portato un cesto di fiori alla Super e le hanno dedicato una recita, ma che bravi!!! (Autore: Gianluca Nuzzo)
Il Mitico Istituto “Aveta”
Andare a scuola, spesso è come stare in prigione… 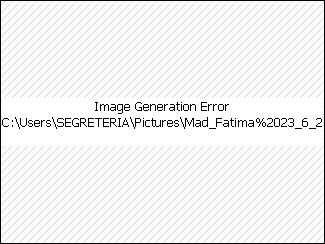
ma qui da noi c’è sempre il sole e mai grigiore!!!
La nostra scuola è molto carina
pur se da fuori sembra bruttina,
oltre il portone vedrai che gran cortile
e tante suorine con aria gentile!!!
Le aule grandi e spazi accoglienti,
in cui passiam tutti i nostri momenti,
a riscaldarle ci son le nostre voci,
il sole, i fiori nostri complici e soci.
Divisioni, moltiplicazioni, frazioni e addizioni…
qui non si rischia a rimaner testoni!
Io fui, tu fosti egli fu…
dai verbi non ne usciamo più!!!
La ginnastica, l’informatica, con la teacher l’inglese,
Maurizio, Sr Epie, Anna Paola, Sr Imelda simpatica e cortese.
Poi alla mensa con Sr. Luigina c’è sempre un profumino,
che aumenta il nostro languorino…
Pastasciutta, riso e gnocchi, verdurine sofficini…
polpettone, frutta e dolci per i grandi e i piccini.
Le suorine bianche sembran fate del paradiso,
vigilano, amano e non lasciano il sorriso.
La Superiora con i suoi dolci sguardi
non smette mai di controllarci
e Sr. Aurelia con sue battute,
lenisce sempre le nostre cadute.
La gioia lei ci insegna
e in segreteria per noi s’impegna.
Sr. Demita, Rosabe e Cecilia operano con i piccini
che con loro son sempre carini.
E che dirvi delle altre insegnanti?
il loro sapere è per tutti quanti.
Un giorno qui più non saremo…
e mai il loro volto dimenticheremo.
Cucite abbiam le righe, il nome della sarta?
Non c’è di che impazzir,
siam quelli della seconda, prima quinta, terza e quarta!!! (Gli alunni dell’ Istituto “Antonio Aveta”)
Musica e Canto: un valido supporto all’Attività Didattica Formativa
(Una delle stelle del Carisma Didattico – Educativo nella costellazione delle Suore Domenicane di Pompei) L’Istituto Paritario “Antonio Aveta” di S. Maria Capua Vetere ha avuto modo in questi anni di sperimentare oltre alle normali attività scolastiche (che poi tanto “normali” non sono in quanto sono comprensive della lingua straniera, della ginnastica nelle sue varie configurazioni e del calcetto) la presenza della Musica, voluta fortemente dalla Dirigente Scolastica, Rev.da Madre Florinda Capasso.
Musica che, nella sua accezione più socialmente utile, è rappresentata dal canto corale; grazie al quale i fanciulli si abituano ad essere parte integrante di un tutt’uno, dove il singolo e il gruppo si stringono in un vincolo di comunanza che educa al rispetto delle regole ritmiche e melodiche e che tanto potrà essere utile al fanciullo nel momento del suo ingresso nella società adulta, contribuirà alla sua formazione personale e caratteriale.
Il canto corale infatti è un’attività di gruppo dove non esiste il migliore o il peggiore, ma tutti si rendono indispensabilmente protagonisti (quale migliore attuazione della parabola evangelica del corpo e delle membra).
Alle attività di canto sono state miscelate in un cocktail esplosivo (naturalmente nel senso più piacevole del termine) le attività di recitazione per i fanciulli.
L’Insegnante di musica e canto M° Gerardo Cavallo, le Suore e le Docenti, sono riuscite a preparare spettacoli come “La piccola storia di Gesù”, “Vacanze di Natale”, “Festa dell’Amicizia” e diversi concerti per coro il tutto rappresentato nei Teatri della zona, con successi di pubblico e di critica che hanno superato le più rosee previsioni.
Inoltre il vero obiettivo, ovvero la possibilità data ai fanciulli di interpretare un nuovo modo di essere alunni studiando con divertimento, è sembrato pienamente raggiunto.
Sull’onda di questi entusiasmi (infatti sono adesso gli stessi alunni e gli stessi genitori a chiedere informazioni sugli spettacoli in allestimento) parallelamente al canto il Dirigente Scolastica ha pensato (tanto per non lasciare che il Maestro di Musica si annoi troppo!!!) di istruire una Orchestra scolastica di Diamoniche dove gli alunni possono soddisfare il loro desiderio di “fare musica” attivamente, mettendo in luce volontà e capacità tali da ripagare completamente gli sforzi dei loro educatori.
Carissime Consorelle,
Non vi nascondo che nel rivolgermi a voi provo un’emozione nuova, quasi ansia e paura di non riuscire ad esprimere con parole, la grande gioia che ho nel cuore.
50 anni...e...oltre… una data che racchiude una motivazione, una storia, la nostra. 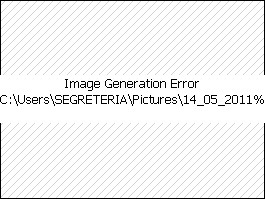 Era il lontano 1958 quando guidate dallo Spirito di Gesù e dall’Amore vigile della Beata Vergine del Rosario di Pompei, la nostra Comunità, iniziò la sua opera di evangelizzazione e di istruzione nella Città di Santa Maria Capua Vetere.
Era il lontano 1958 quando guidate dallo Spirito di Gesù e dall’Amore vigile della Beata Vergine del Rosario di Pompei, la nostra Comunità, iniziò la sua opera di evangelizzazione e di istruzione nella Città di Santa Maria Capua Vetere.
Con impegno, saggezza e amore abbiamo, pur con non poche difficoltà, percorso un lungo pezzo di strada ed eccoci oggi a volervene rendere partecipi.
L’Istituto “Antonio Aveta”, nel ricordo del suo benefattore e di quanti hanno contribuito a realizzare questo sogno… apre le sue porte svelandovi tutta la magia e quell’infinita tenerezza che solo i bambini sanno donare…
Madre Florinda
La Superiora e la Comunità delle Suore "Figlie del S. Rosario di Pompei" ricordano il 50° anniversario (L'Amore è inventivo all'infinito)
della loro presenza educativa a Santa Maria Capua Vetere e ti invitano:
"1958 ... 2008: 50 anni ... e ... oltre"!
( ... Continuate, continuate, senza l'interruzione neppure d'un minuto solo nell'opera del vostro amore e della vostra carità ..." (Dal testamento del Beato Bartolo Longo)
27 Maggio -
Ore 10,00 -
● Visita agli Stands allestiti nel cortile dell'Istituto.
Ore 10,00
● Celebrazione Eucaristica. Presiede Sua Ecc. R. Mons. Luigi Diligenza, Arcivescovo emerito di Capua.
Ore 11,00
● Apertura dei festeggiamenti con i bambini della Scuola dell'Infanzia.
28 Maggio -
Ore 10,00 -
● Visita agli Stands allestiti nel cortile dell'Istituto.
● Momento conviviale nel parco dell'Istituto
Ore 19,30
● Spettacolo presentato dagli alunni della Scuola Primaria
( ... non potevano mancare le educatrici in queste Opere di carità; non dovevano mancare quelle guide spirituali e affettuose che avrebbero dovuto accogliere i piccoli per attuare il progetto; "La Carità, nel senso più largo della parola, cioè l'amore, deve essere la base, il fondamento di ogni sistema pedagogico che voglia pervenire a sicuri e lodevoli risultati" (59, Bartolo Longo).
La Responsabile della Comunità: Madre Florinda
Sono protagoniste di una clamorosa rapina all’Arcidiocesi di Capua (CE), religiose e laiche… e sentite... poco di meno che… La Madre Superiora!!!
Chi l’avrebbe detto con quello sguardo materno e severo!!!
Sue complici le giovani Neo-
Interrogate dai carabinieri della Squadra Mobile dell’ Istituto “Antonio Aveta”, le “innocenti suorine” hanno confessato, tra lacrime e singhiozzi, di essere state costrette a rubare tale cifra all’Arcivescovo di Capua, dalle consorelle: Sr. Maria Aurelia, da tutti conosciuta come Segretaria e Docente di Religione dell’ Istituto stesso, da Sr. Maria Rosalia e da Sr. Maria Luigina.
I carabinieri hanno aperto un’ inchiesta e sottoposto a Sequestro l’edificio.
Ma… dopo una lunga ricerca, la clamorosa scoperta!!!
Durante il colpo erano stati estorti 130 “Padre Nostro”, 285 Ave Maria e 62 “Gloria al Padre”, un’ infinità di Giaculatorie e Requiem… che dovevano essere distribuite, equamente, tra i bambini della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria Paritari dell' Istituto “Antonio Aveta” e a quelli che, sparsi per il mondo, aspettano solo un po’ d’Amore.

