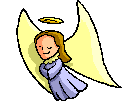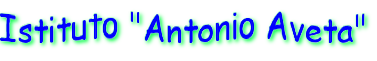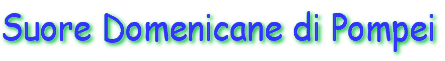Personaggi Biblici S
Con Gesù > Personaggi Biblici
Personaggi Biblici "S"

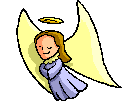
Salmon un personaggio biblico, antenato di Davide e di Gesù. Egli era figlio di Naasson, il capo della tribù di Giuda durante l'Esodo ed apparteneva alla generazione di israeliti che per primi entrarono nella Terra Promessa.
Nella Bibbia
Nell'Antico Testamento Salmon compare in due genealogie di Davide (Rut 4,20-2 e 1 Cronache 2,10-11) come il suo trisnonno paterno. Nella seconda genealogia viene utilizzato il nome "Salma".
Nel Nuovo Testamento Salmon compare nelle due genealogie di Gesù. In quella di Matteo il nome Salmon viene traslitterato in Greco come σαλμων (Matteo 1,4-5). Nella genealogia del vangelo di Luca, invece, il nome "Salma" è storpiato in "Sala" (Luca 3,32 Luca 3,32).
Agiografia
Al momento della partenza dall'Egitto Salmon non doveva essere ancora nato o doveva avere meno di vent'anni, per cui poté entrare nella Terra Promessa (Numeri 14,26-30). Secondo il vangelo di Matteo egli avrebbe sposato "Racab" (Matteo 1,4-5), ossia Raab, la locandiera di Gerico che protesse le spie israelite, inviate da Giosuè segretamente a Gerico prima dell'assedio, ed entrò a far parte del popolo ebraico. La professione di Racab è specificata in questi termini da Flavio Giuseppe, ma nel mondo antico le locande erano equiparate ai bordelli e infatti nella Bibbia Raab viene chiamata "prostituta". L'affermazione di Giuseppe Flavio chiarisce come mai le due spie alloggiassero presso di lei. Questo matrimonio può far supporre che Salmon fosse uno dei due esploratori ospitati e salvati da Raab Dal matrimonio di Salmon con Raab nacque Booz, che sposa Rut nel Libro di Rut.
La moglie di Salmon
Il matrimonio di Salmon con Racab pone fra gli antenati di Davide e di Gesù una prostituta, fatto poco gradito a ebrei e cristiani. Il nome greco Ῥαχάβ (= Racab o Rahab) è utilizzato anche da Giuseppe Flavio per indicare Raab, perciò è difficile sostenere che non si tratti della stessa persona solo sulla base di una differenza ortografica, che probabilmente segnala una semplice variazione della pronuncia ebraica in uso nel I secolo. Conseguenza di questo disagio è la rivalutazione del personaggio sia negli scritti neotestamentari sia in quelli ebraici.
Paolo cita Raab nella Epistola agli ebrei come esempio di fede (Ebrei 11,31). Giacomo, invece, cita Raab per le sue opere quali l'ospitalità incondizionata e l'essersi schierata dalla parte del piano di Dio (Giacomo 2,25). Anche gli scritti rabbinici ne fanno una figura positiva per virtù e bellezza e la considerano sposa di Giosuè, togliendola così dal novero degli antenati di Davide, forse in opposizione alla tradizione seguita da Matteo.
Il Santuario di Lot è un antico monumento bizantino dedicato a Lot, nipote di Abramo, che trovò rifugio sulle montagne con le sue figlie dopo la distruzione di Sodoma e Gomorra (Gen 19,30).
Storia
Quando i pellegrini cristiani si recarono sempre più spesso in Terra Santa nel III e IV secolo d.C., era importante per loro trovare luoghi adatti dove ricordare gli eventi biblici. Una grotta nelle montagne giordane sopra il Mar Morto è da allora venerata come "Grotta di Lot" e su di essa fu costruita una chiesa nel V-VI secolo. Sulla mappa di Madaba creata intorno all'anno 560, il "Luogo di San Lot" è contrassegnato da un'immagine della chiesa.
Ricerca di conservazione
Nel 1986, durante un'indagine di superficie, l'archeologo Burton MacDonald scoprì i resti di un monastero e lo chiamò inizialmente Deir 'Ain 'Abata (Monastero della Sorgente di Abata), dal nome della vicina sorgente. Ulteriori indagini preliminari hanno portato a pensare che potesse trattarsi del santuario di Lot a lungo cercato e conosciuto nella mappa di Madaba. Dal 1988 al 1996, Konstantinos D. Politis ha diretto gli scavi con i finanziamenti del British Museum. Il ritrovamento di iscrizioni nella basilica ha confermato che in questo sito era venerato Lot. Dal 1993, il Ministero giordano del Turismo e delle Antichità ha promosso il restauro e la salvaguardia del sito e il suo sviluppo turistico.
Descrizione
La piccola basilica a tre navate sorge su una stretta area scavata nella collina. Si sono conservate tre absidi e attraverso quella settentrionale si accede alla grotta. Il portale è decorato con rosette e croci; dietro di esso si apre uno stretto passaggio che conduce alla grotta. La navata centrale è separata da quelle laterali da quattro colonne per lato. Il presbiterio è rialzato con due gradini sui quali si trovano ancora le fondamenta del battistero. Tre gradini per le sedute sono murati nella curva dell'abside principale. Il nartece è franato lungo il pendio ma sono riconoscibili le sue dimensioni.
Nella chiesa sono stati ritrovati diversi mosaici che riportano le date del restauro della chiesa nel 572 - 573, firmato da Kosmas, del 606 e del 691. L'ultimo risale all'epoca omayyade, un'epoca in cui cristiani e musulmani vivevano in pace nella regione. Anche dopo l'abbandono del monastero, il culto di Lot è proseguito in questo sito fino all'epoca abbaside come testimoniano i reperti rinvenuti nella grotta.
La grotta è stata esplorata anche negli strati più profondi e sono state rinvenute ceramiche nabatee e della media e prima età del bronzo. I reperti indicano un antico luogo di culto la cui tradizione è stata ripresa dai cristiani.
A sud della basilica si trova una grande cisterna. Adiacente al lato nord si trova il refettorio con un grande forno, le stanze per i pellegrini e le celle dei monaci.
Sara o Sarah è una personalità biblica,
prima moglie di Abramo, e madre di Isacco.
Il nome ebraico Sarah indica
una donna di alto lignaggio ed è tradotto con principessa oppure nobildonna.
È venerata da tutte le Chiese Cristiane che ammettono il culto dei santi. È
inoltre soggetto di culto nelle altre religioni monoteiste, l'Islam e
l'Ebraismo.
Racconto
biblico
Sara è ricordata in Genesi, e nel Libro di Isaia 51:2.
Nel Libro della Genesi, Sara gioca un ruolo fondamentale nella
costruzione della discendenza eletta e del compimento della promessa di Dio,
dopo che Abramo esce da Carre e iniziano gli avvenimenti che
porteranno alla costituzione del popolo eletto (cfr. Genesi 13).
In base alla cronologia biblica Sara nasce all'incirca nel 2028 a.C. da
Tera, padre di Abramo. Sara è quindi sorellastra del marito, figlia dello
stesso padre, ma non della stessa madre (Gen. 20,12).
Sara ha circa dieci anni meno del marito Abramo (Gen. 17,17) col quale si
sposa mentre si trovavano nella città di Ur (Gen. 11,28-29).
Sara è una donna molto bella nonostante la sua età. Il timore del marito di
essere ucciso da qualcuno che desidera avere sua moglie lo spinge a imporle di
dichiarare a chiunque glielo chieda di essere la sorella di Abramo e non la
moglie. Di conseguenza Sara è una prima volta condotta dal Faraone, così Dio
piaga il Faraone il quale la lascia tornare dal marito prima di prenderla come
sua moglie (Gen. 12,11-20). Una seconda volta Sara è notata dal re Abimelec,
il quale pure manda a prenderla, credendola solo una sorella di Abramo; qui Dio
viene in sogno al re Abimelec e gli impone di lasciarla tornare dal marito
(Gen. 20).
Sara è sterile e quando ha ormai 75 anni circa, secondo la consuetudine
dell'epoca, dà in moglie la sua schiava Agar al marito perché
partorisca per lei un figlio, cui mette nome Ismaele, il quale sarebbe poi
divenuto il capostipite di una grande nazione (Gen. 16).
Il suo nome originale era Sarai, che probabilmente significa
"litigiosa". Quando ella ha 90 anni Dio le cambia il nome da Sarai in
Sara, che significa "Principessa, Signora" promettendole che avrebbe
concepito miracolosamente un figlio, al quale essa mise poi nome Isacco,
il cui nome significa risata, perché Sara rise ascoltando la promessa e, disse,
chi avrebbe udito di una novantenne che partorisce avrebbe pure riso (Gen.
17,15 e 21,5-6).
Sara muore nel 1901 a.C. circa, all'età di 127 anni, 37 anni circa dopo
aver partorito Isacco. È l'unica donna di cui l'Antico Testamento fornisce
l'età (Gen. 23,1-2).
Anche dopo la morte, Sara si lega a una promessa di Dio: quella di una
terra promessa: al capitolo 23 del libro della Genesi si legge:
Nel Nuovo
testamento
San Paolo nella lettera ai Galati 4,22-31 scrive che
Sara e Agar (la sua schiava) rappresentano due patti. Agar rappresenta il Patto
della Legge stipulato con Mosè sul monte Sinai e la città di Gerusalemme «che
genera figli per la schiavitù». Sara invece rappresenta la «Gerusalemme di
sopra» in base al nuovo Patto stipulato con Gesù, durante l'ultima cena e che
rende liberi i figli di Dio. Altri riferimenti sono in Romani 4,19 e
9,9.
La Prima lettera di Pietro elogia Sara come modello di donna
perché rimase obbediente e fedele al patriarca Abramo, operando il bene (1Pt
3).
Culto
Le Chiese cristiane la venerano come santa, ricordandola assieme al marito
Abramo il 9 ottobre e non singolarmente. La Chiesa cattolica la
ricorda anche il 24 dicembre quando viene celebrata una memoria
altrettanto generica per tutti gli antenati di Gesù. Invece la Chiesa copta la
festeggia con una data specifica, il 19 agosto. La figura di santa Sara è
venerata anche dall'Islam.
Nell’Islam
Sarah è soggetto di preghiera nel mondo islamico in quanto prima moglie di
Abramo, sebbene gli Ismaeliti propriamente discendano dalla servitrice egiziana
Hagar. Secondo il testo biblico, entrambi i figli furono una promessa e una
profezia di Dio: Ismaele concepito quando Abramo aveva 66 anni, e Isacco quando
Abramo aveva 99 anni. Isacco fu anche un profeta del Signore.
Il Corano non menziona Sara con il suo nome, ma riferisce l'annuncio della
nascita di Isacco (Sura 11 (Hud), ayat 69-72).
Sefora (o Sephora, Zippora) è la moglie di Mosè, una delle sette figlie di Ietro, menzionata nel libro dell'Esodo.
Storia – L’incontro
Quando Mosè, dopo aver ucciso un egiziano si rifugiò in Madian presso il sacerdote Ietro (o Reuel o Obab), egli gli diede in sposa una delle sue figlie. In seguito, dopo la morte di tutti coloro che avrebbero potuto attentare alla sua vita, Mosè fece ritorno in Egitto portando con sé la moglie e i figli, mentre secondo un'altra tradizione biblica partì invece da solo. Mosè poi rimandò sua moglie e i suoi figli dal padre; dopo l'uscita del popolo ebraico dall'Egitto questi fece visita a Mosè accompagnato da Sefora.
La citazione
La donna è citata dalla Scrittura solo in occasione della circoncisione di Gherson. Mosè, che era cresciuto in Egitto alla corte del faraone, non aveva subito questo rito prescritto dal Signore ad Abramo, che doveva essere legalmente praticato sul neonato a otto giorni dalla nascita. A questa colpa fu attribuita la malattia proveniente dal Signore che gli fece correre il pericolo di morire. Allora Sefora simulò la circoncisione di Mosè per salvarlo dall'ira divina; praticò il rito sul figlio neonato e con il prepuzio che aveva reciso toccò il pene (la Scrittura dice “i piedi”) del marito addormentato, dichiarando: "Tu sei per me uno sposo di sangue". Così fu allontanata la minaccia che incombeva su Mosè.
Avversità
A lungo Mosè fu però disapprovato per aver scelto una moglie straniera: Sefora era Madianita o, secondo altre versioni, Kenita. Miriam e Aronne lo rimproverarono di avere scelto una sposa etiope. Nel passo però si è ingenerata certamente confusione e l'origine imputata alla donna non è l'Etiopia (Cush), ma Cusan, una tribù madianita, come risulta da un versetto del libro di Abacuc dove i due nomi citati parallelamente appaiono sinonimi.
Altri esegeti ritengono che si tratti di due personaggi diversi, anche in considerazione delle varie tradizioni bibliche intrecciatesi sulla famiglia di Mosè. L'analisi dei legami famigliari di Mosè evidenzia infatti delle difficoltà: notano gli studiosi della École biblique et archéologique française (i curatori della Bibbia di Gerusalemme) che "i testi non sono d'accordo sul nome e la persona del suocero di Mosè. Abbiamo qui [Es2,18] Reuèl, sacerdote di Madian; in 3,1; 4,18; 18,1 si chiama Ietro; Nm10,29 parla di Obab, figlio di Reuèl, il Madianita; Gdc1,16; 4,11 di Obab il Kenita. [...] Di fatto le due tradizioni su un matrimonio kenita e un matrimonio madianita sono concorrenti e non bisogna cercare di conciliarle. La prima, originaria della Palestina del sud, riflette l'esistenza di legami amichevoli tra Giuda e i Keniti, conservando il ricordo del matrimonio di Mosè con una straniera. La seconda è più strettamente legata all'uscita dall'Egitto" e anche gli studiosi dell'interconfessionale Bibbia TOB ritengono che "le diverse tradizioni danno al suocero di Mosè nomi differenti, senza cercare di armonizzarli".
Altri esegeti ritengono che si tratti di due personaggi diversi, anche in considerazione delle varie tradizioni bibliche intrecciatesi sulla famiglia di Mosè. L'analisi dei legami famigliari di Mosè evidenzia infatti delle difficoltà: notano gli studiosi della École biblique et archéologique française (i curatori della Bibbia di Gerusalemme) che "i testi non sono d'accordo sul nome e la persona del suocero di Mosè. Abbiamo qui [Es2,18] Reuèl, sacerdote di Madian; in 3,1; 4,18; 18,1 si chiama Ietro; Nm10,29 parla di Obab, figlio di Reuèl, il Madianita; Gdc1,16; 4,11 di Obab il Kenita. [...] Di fatto le due tradizioni su un matrimonio kenita e un matrimonio madianita sono concorrenti e non bisogna cercare di conciliarle. La prima, originaria della Palestina del sud, riflette l'esistenza di legami amichevoli tra Giuda e i Keniti, conservando il ricordo del matrimonio di Mosè con una straniera. La seconda è più strettamente legata all'uscita dall'Egitto" e anche gli studiosi dell'interconfessionale Bibbia TOB ritengono che "le diverse tradizioni danno al suocero di Mosè nomi differenti, senza cercare di armonizzarli".
Sefora ebbe due figli da Mosè:
Gherson (da gher, residente) “perché era un'emigrata in terra straniera”
Eliezer “perché il Dio di mio padre è venuto in mio aiuto” (in lingua ebraica ezer).
Sennacherib (il cui
nome è traducibile in "Sin (il Dio della Luna) ha rimpiazzato i
fratelli"; Kalhu, 740 a.C. circa – Ninive, 681
a.C.) fu figlio di Sargon II, al quale succedette sul trono di Assiria il
dodicesimo giorno di Ab (luglio-agosto) intorno al 705 a.C. Nei primi
anni del suo regno conquistò Babilonia e scelse come sede del suo
impero la città di Ninive, situata vicino alla odierna Mosul, dove
fece costruire il celebre "Palazzo senza eguali", citato anche
dalla Bibbia. Morì nel 681 a.C., forse per un complotto familiare.
Biografia
La sua fama moderna è legata al suo assedio di Gerusalemme,
durante la sua campagna di conquista della Palestina.
Nel 701 a.C., nel regno di Giuda, era scoppiata una ribellione
capeggiata dai re di Fenicia e Palestina e appoggiata dall'Egitto. Sidone,
governata da Lule, Askalon dal re Sidka e Giuda sotto il re Ezechia entrarono
in rivolta, ricevendo un corpo di spedizione egizio guidato dal fratello del
faraone Shabataka, Taharqa. Sennacherib penetrò nel territorio della Palestina e
ne approfittò per saccheggiare diverse città, tra cui Askalon. Affrontati e
sconfitti i re coalizzati a nord di Ashdod, presso Elteqeh,
Sennacherib proseguì per stringere d'assedio Gerusalemme, ma presto tornò
a Ninive senza che Gerusalemme fosse stata toccata. Questo famoso
evento venne ricordato dallo stesso Sennacherib, da Erodoto, e da alcuni
passi della Bibbia.
La versione
biblica
Secondo la Bibbia,
l'assedio fallì perché «l’angelo di Yahweh giunse e colpì
185 000 soldati nel campo degli Assiri» (Secondo libro dei Re, 19.35).
La Bibbia accenna
all'assedio di Sennacherib a Gerusalemme con dovizia di particolari. Esso parte
dalla distruzione del regno settentrionale d'Israele e di Samaria, sua
capitale. Fu così che le dieci tribù perdute, come vengono ricordate
nel Secondo libro dei Re (17),
vennero condotte fuori del territorio e fatte mescolare con altre popolazioni
come era nell'usanza degli Assiri.
Sempre nel Secondo libro dei
Re (18,19) si trovano i passi che parlano dell'attacco di
Sennacherib alla capitale Gerusalemme. Secondo la Bibbia, Ezechia si era
ribellato agli Assiri, così che essi catturarono tutte le sue città. Rendendosi
conto del suo errore, egli inviò un grande tributo al re assiro. Ezechia pagò
il tributo imposto da Sennacherib di 300 talenti d’argento (oltre 1 549 370
euro) e 30 talenti d'oro (oltre 8 469 893 euro) (18:14-16). Tuttavia
gli Assiri marciarono ugualmente verso Gerusalemme occupando prima Lachis,
città giudea nella Sefela. Durante l'invasione lanciata nel 701 avanti Cristo
Lachis fu assediata da Sennacherib re d'Assiria, che la usò come una base per
le operazioni militari successive contro Gerusalemme, da lì mandò Rabsache,
Tartan e Rabsaris contro la città santa con imponenti forze militari nel
tentativo di indurre alla resa il re Ezechia. (Gsè 15:21, 33, 39) Lachis
viene oggi identificata con Tell ed-Duweir (Tel Lakhish), collina circondata da
vallate circa 24 km a ovest di Ebron. Anticamente occupava una posizione
di grande importanza strategica sulla principale carovaniera che collegava
Gerusalemme con l'Egitto. Sennacherib il re assiro inviò il suo comandante in
capo con un esercito per assediare la città, mentre lui stesso combatteva
contro gli Egizi. La delegazione assira era tornata da Sennacherib, che
combatteva contro Libna, quando giunse la notizia «circa Tiraca re d’Etiopia:
‘Ecco, è uscito a combattere contro di te’» (2Re 19:8, 9). Le iscrizioni di Sennacherib
parlano di una battaglia combattuta a Elteche (ca. 15 km a nord-nord-ovest di
Ecron) nella quale egli afferma di avere sconfitto un contingente egiziano e
l'esercito del "re d'Etiopia". Quindi sono descritti la conquista di
Ecron e il ritorno al trono di Padi, liberato da Sennacherib. Il
comandante assiro si incontrò con gli ufficiali di Ezechia e intimò loro di
arrendersi, insultandoli a voce così alta che la popolazione dalle mura poté
sentirlo, e bestemmiando contro Ezechia ed il suo dio. Come si arrivò a questo?
Sapendo che Dio deplorava qualsiasi unione o alleanze del suo popolo con altri
popoli pagani, adoratori di idoli, ai quali venivano offerti sacrifici umani, Ezechia
rifiutò di chiedere aiuto alle nazioni vicine aspettando che Yahweh lo
salvasse. Il re Ezechia, devoto seguace della Legge Mosaica decretata da Dio,
sapeva che lo stesso Dio non voleva che si allacciassero alleanze di nessun
"tipo", economiche, religiose, - inclusi naturalmente rapporti
sociali con popoli di fede e riti pagani, per il fine di conservare la purezza
spirituale, morale e fisica del suo popolo, - quanto meno politiche in quanto
Israele era considerato fino al tempo di Mosè governo teocratico, e la massima
autorità, Dio, emanò legge che chiunque allacciasse relazioni con stranieri che
adoravano altri dei , ne avrebbe similmente pagato le conseguenze,
verosimilmente, anche I Re che in seguito governarono Israele che furono
nominati da profeti per diretta volontà di Dio dovettero rispettare queste
restrizioni. Infine per evitare relazioni con nazioni che sfidavano le sue
leggi, le leggi che Dio affidò a Mosé per il suo popolo, per tale ragione
Ezechia si rifiutò inizialmente di pagare i tributi richiesti da Sennacherib e
di allearsi con l'Egitto. Ad aggravare le relazioni con gli Assiri fu lo stato
di prigionia nelle carceri israelite di Padi, Re di Ekron, importante
città filistea, che era uno dei 5 signori dell'asse dei Filistei (le altre
città che lo costituivano erano Gaza, Ascalona, Ashdod e Gat).
Padi era ritenuto un Re amico da Sennacherib ma fu tradito dalla sua stessa
gente e consegnato ad Ezechia. Secondo il Re Assiro, Ezechia deteneva
illegalmente Padi. La delegazione militare inviata dal Re assiro fece cadere
Ezechia in uno stato di profonda disperazione dopo che gli fu riferito delle
intimidazioni e delle bestemmie contro Dio.
Quando Ezechia seppe ciò, si strappò le vesti (un gesto tipico dell'epoca
per manifestare ira e sgomento) e pregò Dio nel Tempio di Salomone.
Il profeta Isaia disse al re che Dio avrebbe provveduto a scongiurare
la minaccia. Secondo il profeta Isaia Dio usò il suo potere per influenzare il
pensiero di Sennacherib mettendo una notizia nella sua mente che lo avrebbe
indotto a tornare nel suo paese dove poi in seguito avrebbe trovato la morte.
Quella notte l'angelo del Signore "Yahweh" uccise tutti i soldati
dell'accampamento assiro, forte di 185.000 uomini. Sennacherib, alla notizia di
quel massacro, si ritirò nuovamente a Ninive. Sia secondo la versione biblica
che per Erodoto, poco tempo dopo due dei suoi figli maggiori lo uccisero mentre
adorava il suo dio Nisroch nel tempio a lui dedicato. Gli
successe un altro figlio, Esarhaddon.
La versione
assira
Nelle cronache assire, l'assedio di Gerusalemme non solo non fu descritto
come causa di così gravi perdite per l'esercito di Sennacherib, ma fu anzi
tramandato come un totale trionfo, che costrinse il re Ezechia a pagare un
pesante riscatto dopo che il sovrano assiro, come racconta la cronaca,
«rinchiuse Ezechia il Giudeo come un uccello nella gabbia». Nel
cosiddetto Prisma di Taylor, una tavoletta d'argilla esagonale trovata
nel palazzo reale di Ninive ed ora conservato presso il British
Museum, sono incise le cronache delle otto campagne militari che questo sovrano
intraprese contro diverse popolazioni che si rifiutarono di sottomettersi alla
dominazione assira. La terza di queste campagne venne guidata contro il regno
di Giuda di re Ezechia.
Sennacherib nelle sue cronache fa un previo cenno delle sue vittorie lungo
la via per Gerusalemme e di come i suoi nemici si arrendessero al suo cospetto.
L'Egitto e la Nubia accorsero in aiuto delle città colpite. Ma
Sennacherib sconfisse sia gli Egizi che i Nubiani. Poi catturò e saccheggiò
altre città, compresa Lachish, e ne reinsediò sul trono Padi, loro capo,
che era stato consegnato al re di Gerusalemme e lì tenuto come ostaggio. Sennacherib
diresse a questo punto le sue forze contro Ezechia del regno di
Giuda, che si era rifiutato di sottomettersi a lui. Secondo la cronaca, 46
delle sue città vennero conquistate da Sennacherib, ma Gerusalemme non cadde.
Nel suo resoconto dell'invasione, dato dal Prisma di Taylor, si narra:
«Poiché Ezechia, re di Giuda, non volle
sottomettersi al mio giogo, io lo affrontai, e con la forza delle armi e con il
mio potere conquistai 46 delle sue città fortificate. Da quelle io feci
200 156 prigionieri, vecchi e giovani, uomini e donne, insieme a muli e
cavalli, asini e cammelli, buoi e pecore; e costrinsi Ezechia a chiudersi
dentro Gerusalemme come un uccello in gabbia, costruendo torri intorno alla
città per circondarlo, e innalzai banchi di terra sulle porte della città
affinché non potesse fuggire. Preso allora dal terrore per la potenza del mio
esercito, egli mandò a me i capi e gli anziani di Gerusalemme con 30 talenti
d'oro e 800 talenti d'argento, ed altri tesori per un immenso bottino.
Tutto ciò fu portato da me a Ninive, capitale del mio regno»
La versione
di Erodoto
Lo storico antico greco Erodoto scrisse nelle sue Storie (2:141) un resoconto del
disastro occorso per mano divina all'esercito di Sennacherib:
«Sicché quando, più tardi, mosse contro l'Egitto, con un grande esercito,
il re degli Arabi e degli Assiri, Sennacherib, i guerrieri d’Egitto non vollero
prestare aiuto al loro re. Il sacerdote, allora, trovandosi nell’imbarazzo,
entrò nel tempio e, rivoltosi alla statua del dio, lamentava la sorte cui
rischiava di soggiacere. Ma, mentre così si rammaricava, gli venne sonno e
nella visione che ebbe gli parve che il dio, standogli accanto, gli facesse
coraggio, assicurandolo che nulla di male avrebbe sofferto se avesse affrontato
l’esercito degli Arabi: egli stesso, infatti, gli avrebbe mandato degli aiuti.
Fiducioso per quanto aveva visto in sogno e raccolti quelli fra gli Egiziani
che accettavano di seguirlo, si accampò presso Pelusio (poiché è di
là che si entra nell’Egitto): nessuno della casta dei guerrieri lo seguiva; ma
solo piccoli mercanti, artigiani e gente del mercato. Quando giunsero in quel
luogo gli avversari […] un gran numero di topi di campagna durante la notte
avventatisi contro di loro, ne rosicchiarono le faretre, gli archi e le cinghie
degli scudi; sicché il giorno dopo, datisi alla fuga spogli delle armi, caddero
in molti. E ora sorge nel tempio di Efesto una statua in pietra di
questo re, che tiene su una mano un topo e un'iscrizione gli fa dire: «Guardando
me ognuno coltivi la pietà».
Sicon è un
personaggio biblico vissuto tempi dell'Esodo. Nel Libro dei Numeri è
presentato come uno di due potenti re amorrei che dominavano la Transgiordania,
che avevano strappato al regno di Moab. Il regno di Sicon si
estendeva tra i fiumi Arnon e Iabbok e
la capitale era Chesbon, espugnata dagli Israeliti e più tardi
riconquistata da Moab. Il profeta Geremia ancora la chiamerà "la
città di Sicon".
Il racconto
biblico
Sicon era re di Chesbon quando gli Ebrei, usciti dall'Egitto,
peregrinavano per il deserto alla ricerca di una via per entrare
in Canaan, la Terra Promessa da Dio. Similmente a come
avevano fatto nei confronti del re di Edom, gli Israeliti, guidati
da Mosè, chiesero a Sicon il diritto di attraversare il suo territorio,
assicurando di non avere intenzioni ostili e promettendo di pagare per l'acqua
e i viveri che avrebbero preso al loro passaggio. Sicon per tutta risposta
radunò il suo esercito e attaccò battaglia, finendo però rovinosamente sconfitto.
Con l'aiuto del Signore, gli Israeliti conquistarono il regno di Sicon e
passarono a fil di spada i suoi abitanti. Og, un secondo re amorreo della
Transgiordania, subirà di lì a poco lo stesso destino. Gli Israeliti in questo
modo occuparono un territorio fertile e si garantirono una solida testa di
ponte per la successiva conquista di Canaan.
La sconfitta di Sicon e Og
suscitò forte impressione negli altri re locali, seminando paura e sconforto e
facilitando la campagna di conquista narrata nel Librò di Giosuè. Nella
suddivisione della Terra Promessa tra le Dodici Tribù d'Israele, la
regione transgiordanica andò alle tribù di Gad, Ruben e ad una
metà della tribù di Manasse. Il nome "paese di Sicon"
persistette fino ai tempi di Re Salomone per indicare il territorio
affidato al dodicesimo prefetto di tale re.
Sisara o Sisera era un generale
dell'esercito di Iabin, re cananeo di Cazor. Menzionato nella Bibbia, fu battuto da Barac e Debora.
La figura di
Sisara nella Bibbia
La vicenda di Sisara è descritta nel quarto capitolo del Libro dei
Giudici.
Iabin, sovrano dei Cananei, opprimeva i figli d'Israele da vent'anni.
La profetessa Debora fece appello a Barac per attaccare Sisara, giovane
generale del re nemico, che disponendo di un temibile esercito con 900 carri da
guerra e controllando il territorio del Carmelo fino al lago di Galilea minacciava
quindi di isolare le tribù del Nord dal resto d'Israele. Sotto l'impulso di
Debora esse si schierarono insieme di fronte al pericolo. Lo scontro avvenne ai
piedi del monte Tabor, dal quale discese l'esercito guidato da Barac.
L'armata di Sisara, sorpresa da una improvvisa e fitta pioggia che rese
impraticabile il transito dei carri, fu decimata dalla fanteria nemica presso
il torrente Ghicon, e il condottiero fuggì a piedi, da solo, dirigendosi verso
la tenda di Eber, un Kenita che abitava non lontano da Kades e che egli
riteneva fedele al suo re. Fu accolto da Giaele, la moglie di Eber, e si
lasciò convincere da lei a riposare nella sua tenda. Ma mentre il giovane
dormiva, Giaele, armata di un piolo e di un martello, gli perforò la tempia.
Poi la donna andò incontro a Barac rivelandogli che ormai Sisara non avrebbe
più potuto nuocere agli Ebrei.
"Allora Giaele tolse un picchetto dalla tenda, prese in mano un martello
e si avvicinò a Sisara senza far rumore. Gli conficcò nelle tempia il
picchetto, ma così forte che rimase piantato anche in terra. Sisara passò dal
sonno alla morte". – Gdc 4:18-21.
Segue il cosiddetto "cantico di Debora" (non è chiaro però se sia
la profetessa a intonarlo), che celebra la sconfitta di Sisara e la sua
uccisione per mano di Giaele: secondo questo testo Sisara sarebbe stato colpito
mentre era sveglio e in piedi (" cadde lungo disteso "). Nella seconda parte del brano
viene data voce alle angosce della madre di Sisara, che nella sua casa aspetta
invano il ritorno del giovane, essendo ancora all'oscuro di quanto accaduto: da
qui si evince che i due vivevano insieme. La voce recitante, che in precedenza
aveva esaltato il gesto di Giaele nonostante ciò costituisse un crimine contro
le regole dell'ospitalità, non sembra rimanere indifferente alla rievocazione
delle premure che il nemico aveva per la genitrice, presumibilmente vedova;
un'immagine che senza dubbio contribuisce a differenziare Sisara da tutti gli
altri oppressori d'Israele nella Bibbia, personaggi generalmente descritti a
tinte fosche oppure non caratterizzati affatto (il racconto della drammatica
fuga di Sisara dopo la sconfitta può peraltro far pensare che egli sia
soprattutto pervaso dal terrore di premorire alla persona che l'ha messo al
mondo). L'anziana viene così risparmiata dall'ironia, che invece si riversa su
una vicina di essa, sbeffeggiata per la saggezza che le veniva a torto
attribuita: quest'altra donna, anonima come la madre di Sisara, si dice infatti
certa che le ragazze ebree sono state fatte prigioniere, con conseguente
bottino delle loro vesti. Da ultimo viene comunque sentenziato che la morte di
Sisara appare giusta, in quanto egli non era un adoratore dell'unico vero Dio
("Così periscano tutti i tuoi
nemici, Signore! Ma coloro che ti amano siano come il sole quando sorge in
tutto il suo splendore").
Secondo il Libro di Samuele l'oppressione di cui erano vittime
gli Ebrei in quel periodo era il castigo della loro infedeltà. Il Salmista
implora il Signore di trattare i nemici d'Israele come aveva fatto con Sisara “al torrente di Kison”.
Ipotesi sulle
origini di Sisara
A lungo si è pensato che Sisara fosse cananeo come il suo re Iabin; in
controtendenza va l'archeologo israeliano Adam Zertal, per il quale il
giovane sarebbe stato un mercenario Shardana, sulla base degli
insediamenti rinvenuti nel sito di El-Ahwat, località identificata come
l'antica Aroset Goim, nella quale Sisara abitava con la madre.
La figura di
Sisara nell’arte
È soprattutto nei secoli XVI e XVII che l'episodio dell'uccisione di Sisara
conosce una grande fortuna in campo pittorico. Nessuna delle opere si basa sul
cantico di Debora: Sisara si trova coricato sul giaciglio sempre (in qualche
caso già ucciso). Tra gli esecutori più importanti, si ricordano Artemisia
Gentileschi, Palma il Giovane, Jacopo Vignali, Gregorio
Lazzarini e Mattia Preti. Generalmente Sisara è raffigurato con la
barba. Nell'opera della Gentileschi ha un aspetto sgraziato, mentre gli altri
pittori danno al condottiero bellezza e prestanza fisica; appare biondo e
particolarmente giovane nel dipinto di Vignali, con una lanugine appena
accennata sopra le labbra e lungo il collo riverso. Gli artisti che
ingentiliscono i tratti di Sisara probabilmente colgono l'essenza intima del
nemico di Israele quale traspare dal cantico di Debora, figlio tenero e devoto
nonostante la fama di risoluto condottiero. Al contrario la Gentileschi vede
nell'uccisione di Sisara un esempio di superbia punita, suggerita ben
chiaramente dalla fisicità ripugnante; il dipinto risale al 1620 ed è dunque
successivo allo stupro subìto dalla pittrice, che dopo il gravissimo oltraggio
immortalò spesso nelle sue opere le grandi eroine bibliche come Giuditta, Susanna
e appunto Giaele, tutte vincitrici sul maschio dominante e oppressore.
Rare sono invece le rappresentazioni artistiche di Sisara vinto in
battaglia: la più nota è quella eseguita da Luca Giordano (Disfatta di Sisera).
La figura di
Sisara nella musica
La storia di Sisara è stata musicata dal compositore bavarese Johann
Simon Mayr nel 1793 e rappresentata in forma di oratorio, la cui
"prima" si tenne a Venezia nella chiesa di San Lazzaro
dei Mendicanti. In questa composizione, intitolata appunto Sisara, il giovane condottiero non
solo ha il ruolo da protagonista, ma è anche personaggio palesemente virtuoso,
di nobili sentimenti, a differenza della perfida Giaele, che per ingannarlo gli
fa credere di essere innamorata di lui, passando così per adultera. La medesima
vicenda è servita da spunto al compositore italiano Ildebrando Pizzetti per
la stesura della propria opera Debora
e Jaele, rappresentata per la prima volta al Teatro alla Scala di Milano
nel 1922. Qui il nemico di Israele è chiamato Sisera e il suo status è quello
di re dei Cananei: come nell'oratorio di Mayr egli è caratterizzato da una
nobiltà d'animo con cui spiazza più volte Jaele. La donna a un certo punto
realizza di essere innamorata di lui e quasi rinuncia al proposito omicida.
Alla fine ucciderà Sisera nel sonno, ma solo per non consegnarlo vivo in mano
agli Ebrei, che sicuramente lo massacrerebbero dopo torture atroci.
La Strega di Endor è
una negromante dotata del potere di evocare lo spirito dei morti citata
nella Bibbia.
Compare nel primo libro di Samuele della Bibbia. Il testo biblico non ne
riporta il nome, ma nella tradizione rabbinica è identificata con
Zefania, madre di Abner, primo cugino e comandante in capo dell'esercito
di re Saul.
Racconto biblico
Nel capitolo 28 del primo libro di Samuele si narra che, dopo aver cacciato
tutti i negromanti e i maghi da Israele, il re Saul, prima
della battaglia di Gilboa, si era rivolto a Dio e ai profeti per
ottenere consiglio sul come agire nei confronti dei Filistei.
Non avendo ricevuto risposta, si recò in incognito a Endor, un villaggio posto
tra il Monte Tabor e la collina di Moreh, per incontrarvi la
Strega, una donna nota per il possesso di un talismano in grado di
evocare gli spiriti dei defunti, sfuggita alla sua persecuzione.
Saul le chiese di evocare per lui lo spirito del profeta Samuele,
deceduto da poco. Lo spirito di Samuele non diede a Saul le risposte che
cercava, ma predisse l'imminente caduta del suo regno. Poiché la pratica della
necromanzia era vietata dalla Torah, rivolgendosi alla strega Saul si rese
colpevole di un grave peccato.
La profezia del fantasma di Samuele è in gran parte la ripetizione delle
parole di Samuele in vita (1Sam 15): l'unica informazione nuova è la profezia
che Saul sarebbe morto il giorno dopo. Tuttavia, se si considerano gli eventi
dei capitoli 1Sam 28-31 narrati in ordine cronologico, Saul non sarebbe morto
il giorno seguente, ma tre giorni più tardi, di modo che le truppe di Davide potessero
raggiungere Ziklàg "il terzo giorno" (1Sam 30,1).
Interpretazioni
Nella Septuaginta, la
traduzione greca dell'Antico Testamento, l'espressione "una donna con uno
spirito" (1Sam 28,7) è tradotta "un ventriloquo". Di
conseguenza Origene ha ritenuto che la voce del fantasma fosse quella
della donna.
Alcuni rabbini insegnavano che lo spirito di un morto restava nei
pressi della salma per circa un anno dopo il decesso e che in questo periodo lo
spirito poteva essere contattato, come avviene per Samuele.
I Padri della Chiesa e molti scrittori e teologi cristiani hanno
messo in dubbio la verità letterale di questo passaggio della Bibbia, che sembra avallare la
veridicità della necromanzia. Già nel medioevo la vicenda della
Strega di Endor fu reinterpretata in vario modo, così da escludere tale
conclusione. Alcune fonti suggeriscono che a essere evocato non fosse lo
spirito di Samuele, ma un demone che aveva preso la sua forma. Altre,
per esempio l'autore Hank Hanegraaff, che Samuele si fosse manifestato per
volontà di Dio e non a causa dei poteri della strega.
Al di là delle contestazioni di ordine teologico, la vicenda della Strega
ha lo scopo di mostrare la caduta morale di Saul che, persi i favori di Dio, si
riduce a partecipare a rituali proibiti. Il messaggio che ottiene da Samuele è
infatti solo una conferma della sua imminente rovina.
La storia di Susanna o Shoshana fa parte del libro
di Daniele al capitolo XIII, considerato deuterocanonico da cattolici e ortodossi e apocrifo dai protestanti.
Gli ebrei accettano il capitolo come racconto morale, ma non come
parte del Tanakh, sebbene i primi dodici capitoli siano considerati parte
degli Scritti, o Ketuvim, cioè la terza e ultima parte del Tanakh.
Il racconto
biblico
Susanna, una giovane donna molto bella e pia, viene concupita da due vecchi
che frequentano la casa del suo ricco marito Ioachim e riescono a introdursi
nel suo giardino sorprendendola mentre fa il bagno. Costoro erano stati eletti
giudici dalla comunità ebraica esule a Babilonia e, infiammati
di lussuria, minacciano di accusarla di averla sorpresa con un giovane
amante se non si concede a loro. Al rifiuto di Susanna l'accusano pubblicamente
di adulterio. Portata davanti al tribunale viene riconosciuta colpevole e
condannata a morte mediante lapidazione, ma a questo punto si fa
avanti Daniele:
«[45]
Mentre Susanna era condotta a morte, il Signore suscitò il santo spirito di un
giovanetto, chiamato Daniele, [46] il quale si mise a gridare: «Io sono
innocente del sangue di lei!». [47] Tutti si voltarono verso di lui dicendo:
«Che vuoi dire con le tue parole?». [48] Allora Daniele, stando in mezzo a
loro, disse: «Siete così stolti, Israeliti? Avete condannato a morte una figlia
d'Israele senza indagare la verità! [49] Tornate al tribunale, perché costoro
hanno deposto il falso contro di lei».»
Questo intervento di Daniele, che poi interroga personalmente i due calunniatori e
ne fa emergere l'inganno, costituisce anche l'inizio del suo percorso pubblico
di profeta. La reputazione di Susanna viene restituita all'onore e la fama
di Daniele cresce fra il popolo. I due giudici infami sono talvolta
identificati con quelli di cui parla Geremia (29,21-23).
Storia del
testo
Il testo greco ci è pervenuto in due versioni: la prima, ritenuta la più
antica, è presente solo nel Codex Chisianus della Septuaginta. Negli altri codici venne
sostituito con la versione di Teodozione, che è quella che appare nelle bibbie
cattoliche. Il racconto fu considerato come parte della letteratura di Daniele
e inserito all'inizio del Libro di Daniele nei manoscritti greci del Vecchio
Testamento. Nella Vulgata latina Gerolamo lo posizionò alla fine del
testo ebraico di Daniele, con la nota, appunto, che non era presente nella
bibbia ebraica.
Il consenso dei primi cristiani fu per considerarlo canonico, con
l'eccezione di Giulio Africano. Origene afferma, in Epistola ad Africanum, che fu
"celato" (apocrifo) dagli ebrei e nel Commentarium in Mattheum, che il testo era stato recepito dalle
chiese cristiane. Ne parlano, infatti, Cipriano, Tertulliano, Ireneo, Ilario e
Clemente Alessandrino. Non esistono riferimenti al libro nel primo giudaismo.
Rappresentazione
iconografica
Per il suo carattere edificante e il lieto fine che lo caratterizza, il
racconto della casta Susanna divenne un tema iconografico ricorrente fin dalla
primissima iconografia paleocristiana e poi in epoca medievale:
una delle primissime raffigurazioni della storia biblica si ritrova in una
delle catacombe di San Callisto, a Roma, e raffigura Daniele che
salva Susanna durante il processo.
L'episodio biblico è raffigurato in una gemma nota come Cristallo di
Lotario, realizzata in Lotaringia nel IX secolo e oggi conservata
al British Museum.
La storia venne spesso rappresentata nella pittura a partire
dal Rinascimento come "Susanna e i vecchioni", forse anche
perché, oltre all'esempio di virtù, giustificava la presenza di un nudo femminile.
Alcuni pittori evidenziarono il dramma, come Artemisia Gentileschi nel
suo dipinto conservato a Pommersfelden, mentre altri (come il Tintoretto)
si concentrarono sul nudo artistico. Nelle due versioni realizzate
nell’Ottocento da Francesco Hayez (una conservata alla Pinacoteca
di Brera di Milano, l’altra alla National Gallery di Londra)
sono eliminati del tutto i vecchioni, così come in un dipinto realizzato
dall'uruguaiano Juan Manuel Blanes nel 1862.[3] Un
altro tema diffuso è quello del processo, a volte con il profeta Daniele che
salva Susanna come soggetto centrale (come nel quadro La Justification de Suzanne, attribuito
al pittore francese François-Guillaume Ménageot).