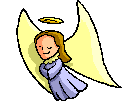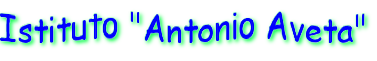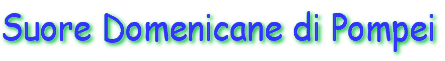Personaggi Biblici R
Con Gesù > Personaggi Biblici

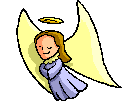
*Raab
Raab (ebraico: Rachav, il cui significato
probabilmente è "ampia" o "larga") è un personaggio biblico
menzionato nelle Sacre Scritture per la prima volta dal libro di
Giosuè. Fu una locandiera della città cananea di Gerico che
sarebbe vissuta nel XV secolo avanti Cristo (data, secondo alcune cronologie
bibliche, della caduta di Gerico) e che aiutò a rischio della sua vita e di
quella della sua famiglia due spie israelite dando loro alloggio nella sua casa
ed assistendole fino alla loro fuga. Successivamente, secondo il Vangelo di
Matteo, sposò Salmon, diventando antenata di Davide, o Giosuè stesso,
secondo alcune fonti rabbiniche.
La storia di
Raab nel libro di Giosuè
Secondo il racconto biblico di Giosuè 2:1-23 dopo la morte
di Mosè che aveva accompagnato il popolo israelita dall'Egitto
alla Terra Promessa, Giosuè mandò in esplorazione a Gerico due
spie israelite prima della conquista di quella città cananea. Giungendo a
Gerico le due spie trovarono alloggio nella casa di Raab. I due ospiti furono
però da alcuni riconosciuti come israeliti, cosa che fu riferita al re di
Gerico.
Mentre gli inviati di Giosuè si trovavano ancora presso di lei, il re
le ordinò di consegnarli ai suoi emissari. Decisa a salvarli, la donna usò un
sotterfugio, sviando gli emissari: affermò che non erano in casa, essendo
usciti sul far della notte.
Appena gli uomini del re si diedero a inseguirli, Raab nascose le due spie
sulla terrazza fra steli di lino accatastati.
Raab dichiarò a quelle due spie che sapeva che il loro Dio aveva assegnato
il paese a Israele, riconoscendo quindi il Dio di Israele come l'unico e vero
Dio in opposizione ai falsi dèi pagani. Poiché il Signore avrebbe consegnato
Gerico al suo popolo, li pregò di intercedere per risparmiare lei e la sua
famiglia nel momento in cui gli israeliti avrebbero conquistato la città. Le
spie giurarono sulla loro stessa vita che lo avrebbero fatto.
Raab li fece calare con una corda dalla finestra mettendoli in salvo: la
sua casa infatti era addossata proprio al muro di cinta. Raccomandò loro di
restare nascosti sulla montagna per tre giorni finché gli abitanti di Gerico
avessero desistito dal loro inseguimento. Prima di partire, i due uomini le
suggerirono di legare alla sua finestra una cordicella di filo scarlatto che
avrebbe segnalato la sua casa agli Ebrei quando fossero entrati in città.
Al momento della presa della città, così come descritto dal racconto
biblico in Giosuè 6:23, 25, Giosuè mandò le stesse spie ospitate da
Raab alla ricerca di lei e dei componenti della sua famiglia. Conquistata, la
città fu completamente incendiata. Da quel momento Raab abitò in mezzo ad Israele. Dio ricompensò la sua fede non
solo risparmiandole la vita insieme alla sua famiglia; avvenne infatti che
Raab, con lo sposare in seguito un israelita, Salmon figlio di Nacson (Rut
4:21), divenisse trisavola del Re Davide, dalla cui discendenza sarebbe nato il
Messia.
Negli scritti
successivi
Raab è citata nella epistola agli ebrei (ca 61 d.C.). Al capitolo
11 versetto 31, Raab è citata come esempio di fede, unica donna insieme a Sara,
moglie di Abramo (versetto 11) in un elenco di uomini fedeli (versetto 32)
come Gedeone, Barac, Sansone, Iefte, Davide e Samuele. Giacomo d'altronde
al versetto 25 del capitolo 2 della sua lettera (62 d.C.) cita Raab per le sue
opere quali l'ospitalità incondizionata e l'essersi schierata dalla parte
giusta, nascondendo e agevolando la fuga degli emissari di Giosuè. Anche
gli scritti rabbinici ne fanno una figura positiva per virtù e bellezza e la
considerano sposa di Giosuè.
Se secondo Paolo, a Raab fu risparmiata la vita terrena per effetto della fede, Giacomo 2:25 riporta il sacrificio di Isacco e il tradimento di Raab come esempio della giustificazione per opere in forza dell'obbedienza al Signore.
Se secondo Paolo, a Raab fu risparmiata la vita terrena per effetto della fede, Giacomo 2:25 riporta il sacrificio di Isacco e il tradimento di Raab come esempio della giustificazione per opere in forza dell'obbedienza al Signore.
In entrambi i passi, Raab è chiamata come la prostituta, parola che nel
Nuovo Testamento si trova riferita soltanto a lei ed alla Bestia dell'Apocalisse.
Raab nella
linea di discendenza diretta del Messia
Raab cambiò vita e divenne una fedele adoratrice di Dio nonché un'antenata
del Messia. Secondo il racconto del primo capitolo del Vangelo
secondo Matteo, Raab di Gerico si colloca sulla linea diretta della discendenza
di Gesù, il Messia atteso dal popolo d'Israele. Al versetto 5 e
6 del primo capitolo di Matteo, Raab (moglie di Salmon) fu la madre di
Boaz che sposò poi Rut. Dal matrimonio nacque Obed che generò Iesse ovvero
il padre del re Davide avo di Giuseppe marito di Maria.
Raab fu
davvero una prostituta?
Alcuni, in particolar modo gli ebrei tradizionalisti, negano che Raab fosse
veramente una prostituta nel senso comune della parola. Questa tesi risale
a Flavio Giuseppe, che nelle "Antichità Giudaiche" afferma che
Raab era una locandiera e non parla affatto di prostituzione. Dato che
nell'antichità le locande operavano anche come bordelli, un identico biasimo
morale avvolgeva entrambe le professioni. Perciò anche se Raab non avesse
esercitato la prostituzione direttamente (fatto che evidentemente nessuno potrà
mai verificare), il solo fatto che lei o la sua famiglia avessero una locanda
basta a spiegare come mai sia nel testo ebraico sia nella traduzione greca
dei LXX Raab sia stata designata con vocaboli molto espliciti. Il
termine ebraico zonàh implica
sempre una relazione illecita, sia in campo sessuale che in senso figurativo in
campo spirituale.
Quando il termine si riferisce ad una donna immorale viene
sempre tradotto come prostituta. Lo stesso vale per il vocabolo greco
"pornè". Il fatto che Raab fosse una locandiera è molto verosimile
perché spiega in modo banale come mai le due spie ebree avessero preso alloggio
presso di lei. Anche studiosi moderni seguono la tesi di Giuseppe Flavio. Ad
esempio Mary J. Evans afferma che Raab era una locandiera, una persona dotata
di accortezza politica, intelligenza, grande coraggio e acutezza spirituale.
Gerico di
Canaan perché votata alla distruzione?
Ma quale fu l'ambiente in cui visse Raab a Gerico? La storia biblica rivela
che la popolazione delle città cananee, Gerico compresa, conquistate dagli
israeliti furono tutte votate
alla distruzione.I cananei adoravano molti dèi fra cui il
principale Baal ma anche Anat ed Astoret. Dèi
sanguinari ed immorali che influenzavano la personalità e il comportamento dei
loro adoratori. Del culto fallico praticato dai cananei l'archeologo William
Foxwell Albright osserva: Nel
suo momento peggiore [...] l'aspetto erotico del loro culto dovette sprofondare
a livelli estremamente sordidi di degradazione sociale. Un'altra delle
pratiche degradanti delle popolazioni cananee (sebbene su questo punto non vi
sia accordo tra gli studiosi) era il sacrificio dei bambini in offerta ai loro
dèi pagani. Merrill F. Unger scrive: Scavi
eseguiti in Palestina hanno portato alla luce mucchi di cenere e resti di
scheletri infantili in cimiteri adiacenti ad altari pagani, a conferma della
diffusione di questa crudele e abominevole usanza Un'altra fonte
inoltre specifica: I cananei
praticavano il culto dandosi all'immoralità come rito religioso in presenza dei
loro dèi; quindi assassinavano i loro primogeniti come sacrificio a quegli
stessi dèi. Sembra che in gran parte il paese di Canaan fosse divenuto una
specie di Sodoma e Gomorra a livello nazionale [...] Una civiltà così
abominevole, sordida e brutale aveva ancora il diritto di esistere? [...] Gli
archeologi che scavano fra le rovine delle città cananee si chiedono perché Dio
non le abbia distrutte prima.
La distruzio0ne biblica di Gerico e le indagini
Secondo la Bibbia Gerico fu la prima città cananea a ovest del Giordano
conquistata dagli israeliti (Nu 22:1; Gsè 6:1, 24, 25). La città è stata
identificata con Tell es-Sultan (Tel Yeriho), circa 22 km a ENE
di Gerusalemme. Il sito è stato ripetutamente scavato dagli archeologi,
anche con l'obiettivo di verificare se esistevano tracce che potessero
confermare il racconto biblico.
A Gerico furono compiuti scavi nel corso di tre diverse spedizioni
(1907-1909; 1930-1936; 1952-1958). Ognuna delle tre spedizioni ha pubblicato
dei dati arrivando però a conclusioni diverse circa la storia della città e in
particolare circa la data della sua eventuale conquista da parte degli
israeliti. Ad ogni modo si può dire che una comparazione dei risultati presenta
il seguente quadro generale: Durante
il secondo millennio a.C., la città subì una terribile distruzione o una serie
di distruzioni, e rimase praticamente disabitata per generazioni. John
Garstang, direttore di una spedizione inglese a Tell es-Sultan tra il
1929 e il 1936, scoprì che quella che riteneva una delle città costruite sul
luogo aveva subìto violenti incendi e le sue mura erano cadute. Egli identificò
questa città con la Gerico del tempo di Giosuè e ne fece risalire la
distruzione al 1400 a.E.V. circa.
Anche se alcuni sono d'accordo con le
conclusioni di Garstang, altri sono di diversa opinione. L'archeologo G. Ernest
Wright ha scritto: Si è scoperto
che le due mura che cingevano l'antica città, che Garstang... ritenne distrutte
dal terremoto e dal fuoco al tempo di Giosuè, risalivano al III millennio e
rappresentano solo due delle circa quattordici mura o parti di mura diverse
costruite successivamente in quell'epoca. Molti pensano che poco, o
nulla, rimanga della Gerico esistente al tempo di Giosuè, poiché precedenti
scavi compiuti sul posto hanno rimosso quello che poteva essere rimasto dal
tempo della distruzione. Come ha osservato Jack Finegan: Ora sul posto non rimane alcuna evidenza in
base alla quale cercare di determinare la data in cui Giosuè può aver preso
Gerico.
Molti archeologi, inoltre, influenzati dal lavoro che Kathleen Kenyon svolse
negli anni '50, si convinsero che all'epoca dell'invasione israelita Gerico non
esistesse più. Sostenevano, infatti, che la città fosse stata distrutta ben più
di un secolo prima. Perciò, il racconto biblico di Giosuè e di Raab perse ogni
credito.
Successivamente, però, Bryant G. Wood, archeologo dell'Università di Toronto
(Canada), riesaminò i reperti di Gerico. In un numero del New York Times, dichiarò che la
conclusione a cui era giunto è che la dottoressa Kenyon ha cercato il vasellame di tipo sbagliato, e
nei luoghi sbagliati, e che i reperti sono in effetti in notevole accordo con la Bibbia.
Il dott. Wood menzionò uno strato di cenere spesso un metro in cui
abbondavano frammenti di vasellame e di mattoni provenienti dal crollo di un
muro e travi, tutti anneriti come da un incendio esteso a tutta la città. I
frammenti di ceramica erano stati datati al 1410 a.C., con uno scarto possibile
di 40 anni. Questo sarebbe in buon accordo con il periodo in cui, secondo
la cronologia biblica, potrebbe essersi svolta la conquista di Gerico
(XV-XIII secolo). Gli scavi inoltre rivelarono che le case dell'antica Gerico
avevano abbondanti scorte di grano nei depositi. La Bibbia indica che Gerico
cadde poco dopo il raccolto primaverile e senza un lungo assedio che la
costringesse alla fame. (Giosuè 3:14-16).
Nel 1981 il prof. John J. Bimson prese di nuovo in esame la distruzione di
Gerico. Studiò attentamente le rovine della Gerico distrutta mediante il fuoco
— secondo Kathleen Kenyon — a metà del XVI secolo a.E.V. Secondo Bimson non
solo quella distruzione collimava col racconto biblico della distruzione della
città compiuta da Giosuè, ma il quadro archeologico di Canaan nel suo insieme
collimava alla perfezione con la descrizione biblica di Canaan relativa al
tempo dell'invasione israelita.
Pertanto affermò che la datazione archeologica
è errata avanzando l'idea che quella distruzione ebbe luogo a metà del XV
secolo a.E.V., all'epoca di Giosuè. Tale metodo storico-critico (espressione
usata per descrivere lo studio della Bibbia che indaga su dettagli come
l'autore, la fonte del materiale e l'epoca in cui fu scritto ciascun libro)
secondo molti osservatori dimostra la veracità del racconto biblico su Gerico
associato alla storia di Raab.
Raab nella
Divina Commedia
Dante cita Raab nella Divina Commedia (Par, c. IX, vv. 112-126), affermando che, coll'aiuto
al condottiero ebraico Giosuè nella conquista della città, si meritò la
salvezza eterna. Si trova nel cielo di Venere, dove fu assunta prima di ogni
altra anima, e di quel cielo è la più luminosa.
Rachele è una personalità biblica, presentata nel libro della Genesi.
È la figlia minore di Labano, e quindi parente di Abramo, sorella di Lia, e favorita del patriarca Giacobbe, di cui diventerà seconda moglie.
Rachele e Giacobbe sono cugini (Labano è il fratello di Rebecca, madre di Giacobbe).
Rachele e Giacobbe sono cugini (Labano è il fratello di Rebecca, madre di Giacobbe).
Da Giacobbe avrà due figli, due dei dodici progenitori delle tribù di Israele: Giuseppe e molti anni in seguito Beniamino, morendo subito dopo il parto.
La tomba di Rachele si trova a Betlemme, in Giudea (dal 1995 amministrata dall'Autorità Nazionale Palestinese in attesa di uno status definitivo dopo essere stata sotto amministrazione israeliana) racchiusa dal muro israeliano è raggiungibile solo da parte israeliana.
Significato del nome
Il nome Rachele significa "mite come una pecorella", cioè “la mitezza di Dio”, per cui, secondo la tradizione, i figli di Giacobbe e Rachele avrebbero dato origine agli allevatori di ovini. Un'altra interpretazione lo traduce come "pecora di Dio": tutti i nomi ebraici che terminano in 'ele', come anche Daniele, Gabriele, Emmanuele ed altri, hanno 'Dio' come suffisso (dall'ebraico EL contrazione di Eloah, Dio).
Nell’Antico Terstamento - L'incontro con Giacobbe
Giacobbe si trovava presso un pozzo nella terra di Carran perché era diretto da Labano suo zio per prendere moglie secondo il desiderio di suo padre Isacco. Mentre attendeva di abbeverare le bestie giunse Rachele che portava ad abbeverare il bestiame del padre. Giacobbe fu subito colpito da Rachele, l'aiutò ad abbeverare il bestiame e piangendo si palesò come suo parente in quanto figlio di Rebecca sorella di Làbano.
Rivalità con Lia
Lia aveva gli occhi smorti (dal pianto, Bibbia C.E.I. del 2008), mentre Rachele era bella di forma ed avvenente di aspetto e fece subito colpo su Giacobbe, il quale pur di averla, si sottomise al servizio del padre Làbano per sette anni credendo alle sue parole: "Preferisco darla a te piuttosto che a un estraneo. Rimani con me". Poi Giacobbe disse a Làbano: "Dammi la mia sposa perché il mio tempo è compiuto e voglio unirmi a lei". Ma Làbano diede un banchetto e concesse a Giacobbe l'altra figlia Lia (o Lea in ebraico) la quale aveva occhi sofferenti, giustificandosi sul fatto che l'usanza imponeva di dare la figlia maggiore prima della più piccola e poi aggiunse: "Finisci questa settimana nuziale e ti concederò anche Rachele per altri sette anni al mio servizio".
Giacobbe per amore di Rachele accettò. L'usanza del popolo non era la poligamia, ma che lo sposo prendesse in moglie la figlia maggiore (Genesi 29:26), che con il tardare degli anni rischiava di non poter più avere figli e ciò era motivo di disonore (Gn 30:13). Vedendo che Lia riceveva poche attenzioni, il Signore la rese fertile e Lia concepì un figlio, mentre Rachele rimaneva sterile.
Entrambi gli eventi sono attribuiti all'opera mediatrice del Signore: Rachele era resa sterile (Genesi 30:2), come anche Sara e Rebecca. In accordo con Tykva Frymer-Kensky, l'infertilità delle matriarche ha il duplice effetto di mostrare quanto sia importante la nascita di un figlio, e quanto siano stati speciali Abramo, Isacco, e Giuseppe; e quanto il concepimento sia opera di Dio, e della sua grazia, per quanto dopo un atto di naturale unione di carne fra due sposi. Stesse considerazioni valgono nel Nuovo Testamento per Elisabetta, che concepisce in tarda età il più grande fra i nati di donna.
Lia ebbe cinque figli: Ruben, Simeone, Levi, e Giuda (Genesi 29:32-35), e Issaccar (Genesi 30:16-17: Giacobbe si coricò con Lia e Dio la esaudì concedendole di partorire un figlio).
Solo in un secondo momento il Signore concesse a Rachele di partorire due figli: Giuseppe, e alcuni anni dopo, Beniamino (Genesi 35, ricordata da Ger 31:15).
Nascita di Giuseppe
La rivalità tra Rachele e Lia era grande e, come era usanza del tempo, si combatteva sul numero dei figli. Esse non erano disposte a dare alla luce dei figli (non per loro scelta). Pur di dargli una discendenza, Lia diede a Giacobbe la sua schiava Zilpa in moglie, la quale partorì due figli: Gad ed Aser. Ma in seguito il Signore si ricordò anche di Rachele e la rese feconda ed ella concepì e partorì un figlio dicendo "Dio ha tolto il mio disonore" chiamandolo Giuseppe.
Nascita di Beniamino e morte di Rachele
«Dio scomparve da lui, nel luogo dove gli aveva parlato. 14 Allora Giacobbe eresse una stele, dove gli aveva parlato, una stele di pietra, e su di essa fece una libazione e versò olio. 15 Giacobbe chiamò Betel il luogo dove Dio gli aveva parlato. 16 Poi levarono l'accampamento da Betel. Mancava ancora un tratto di cammino per arrivare ad Efrata, quando Rachele partorì ed ebbe un parto difficile. 17 Mentre penava a partorire, la levatrice le disse: «Non temere: anche questo è un figlio!». 18 Mentre esalava l'ultimo respiro, perché stava morendo, essa lo chiamò Ben-Oni, ma suo padre lo chiamò Beniamino.
Così Rachele morì e fu sepolta lungo la strada verso Efrata, cioè Betlemme. 20 Giacobbe eresse sulla sua tomba una stele. Questa stele della tomba di Rachele esiste fino ad oggi» Gli esegeti della École biblique et archéologique française (i curatori della Bibbia di Gerusalemme), concordemente a quelli dell'interconfessionale Bibbia TOB, notano nel racconto biblico la presenza di due tradizioni che giudicano discordanti sul momento della morte di Rachele: la prima, sopra citata, al capitolo 35 e la seconda invece al capitolo 37 dove "il racconto deve seguire un'altra tradizione che poneva più tardi la morte di Rachele e la nascita di Beniamino (v 3 e 43,29)" La tomba di Rachele è meta di devozione da 1700 anni, localizzata nel IV secolo fra Betlemme e Gilo.
Dopo aver unto Saul nel nome del Signore, Samuele gli indica di recarsi alla tomba a Selsa sul confine con Beniamino in Zelzach (1 Samuele 10:2, unico riferimento biblico alla tomba di Rachele).
Nel Cristianesimo
Il personaggio biblico Rachele è divenuto il simbolo delle madri afflitte per le disgrazie che affliggono il popolo ebraico; è citato anche nel Nuovo Testamento, come simbolo delle madri inconsolabili per la strage degli innocenti da parte di Erode che cercava di uccidere Gesù Bambino:
«Un grido si è udito in Rama, un pianto e un lamento grande: Rachele piange i suoi figli e rifiuta di essere consolata, perché non sono più. »
Culto
È patrona delle madri che hanno perso un figlio. Santa Rachele viene festeggiata il 30 settembre. Viene festeggiata anche il 24 dicembre, in cui si ricordano gli Antenati di Gesù.
Rebecca è un personaggio biblico. È la moglie di Isacco, nipote di Abramo e la madre di Giacobbe ed Esaù. La sua storia è raccontata nel libro della Genesi.
Personaggio biblico
Rebecca il cui nome in ebraico «Ribqah» ha il significato di ‘corda’ e in senso figurato «che avvince con la sua bellezza», compare per la prima volta nel Libro della Genesi al cap. Qui mentre attendeva, che le donne e le fanciulle come di consueto, a sera venissero ad attingere l’acqua, il servo pregò il Signore di dare un segno per riconoscere la futura sposa di Isacco.Rebecca divenne incinta a 60 anni. Al parto nacquero due gemelli, il primo fu Esaù e il secondo Giacobbe. Per tradizione Rebecca, considerata fra le figure sante e benedette della Bibbia, viene ricordata il 23 settembre, giorno della celebrazione anche di un’omonima martire spagnola del I secolo.
Morta la sua consorte Sara, Abramo si prodiga a cercare una moglie per suo figlio Isacco. Questo compito lo affiderà a un suo servo, Eliezer, che giunge alla prossimità di un pozzo che si trova nella città di Arran e dove incontra una giovane donna dal nome Rebecca, che si rivelerà essere figlia di Betuel, figlio ultimogenito di Nacor, fratello di Abramo, e Milca, moglie di Nacor. Essa successivamente lo presenterà alla sua famiglia e a suo fratello Labano.
Alla fine sceglie di seguire il servo e di diventare sposa del cugino Isacco (cfr. Genesi 24). Per un lungo periodo di tempo Rebecca rimane senza eredi, ma successivamente porta alla luce due gemelli.
La sua gravidanza sarà difficile in quanto i gemelli che porta in grembo si rivoltano l'un contro l'altro, segno premonitore della discordia che nascerà tra di loro e fra le nazioni che discenderanno dagli stessi (cfr. Genesi 25,21-23). Da Rebecca nascono Esaù, primogenito, e Giacobbe (cfr. Genesi 25,24-26).
In seguito Rebecca aiuta il figlio prediletto Giacobbe ad usurpare (con pieno diritto perché Esaù in un'occasione vendette la sua primogenitura al prezzo di una zuppa di lenticchie (cfr. Genesi 25)) presso il padre Isacco la benedizione riservata al primogenito e che doveva toccare al fratello Esaù (cfr. Genesi 27).
Alla sua morte Rebecca è sepolta a fianco del marito nella tomba dei Patriarchi ad Hebron.
Nel Talmud, Rebecca è considerata progenitrice del popolo ebraico (attraverso Giacobbe) e del popolo romano (attraverso Esaù): i due figli si urtano e combattono nel suo grembo, prefigurando la futura inimicizia che dividerà i due popoli.
Culto
Santa Rebecca è ricordata dalla Chiesa cattolica il 23 settembre.
Letteratura
Dante Alighieri la cita nelle anime beate del XXXII Canto del Paradiso, insieme a Giuditta e a Sara.
Regina di Saba è
un'espressione antonomastica che si riferisce a una specifica sovrana
del regno di Saba, citata nella Bibbia (primo libro dei Re, e
nel secondo libro delle Cronache), nel Corano e nel Kebra
Nagast.
Nei testi biblici e nel Corano non viene mai chiamata per nome, ma solo
come Regina di Saba o Regina del
Sud. Per la tradizione etiope il suo nome era Machedà, mentre alcune fonti arabe la
chiamano Bilqis (talvolta
trascritto Balkiyis).
Viene ricordata come regina ricchissima; nella Bibbia, fa visita a Salomone per
metterne alla prova la grande saggezza.
Secondo il Kebra Nagast, che racconta più estesamente delle vicende
della regina, il sovrano etiope Menelik I era figlio
di Machedà e Salomone.
Da un punto di vista storico, la questione se la regina di Saba sia
realmente esistita è controversa. La regina di Saba viene citata da Gesù in
alcuni racconti evangelici (Matteo 12:42 e Lu 11:31): «La regina del meridione sarà destata nel
giudizio con gli uomini di questa generazione e li condannerà; perché essa
venne dai confini della terra per udire la sapienza di Salomone, ma, ecco, qui
c'è più di Salomone».
Il racconto
biblico
Secondo la Bibbia, la divina regina della terra di Saba venne
a conoscenza della grande saggezza del re d'Israele, Salomone, e si
mise in viaggio verso la sua terra portando con sé come doni spezie, oro e
pietre preziose. La regina fu colpita dalla saggezza e dalla ricchezza di
Salomone e pronunciò una preghiera al Dio di Salomone, che
la ricambiò con molti doni e con "qualsiasi
cosa desiderasse", fino a quando la regina non tornò nel suo regno.
Gli esegeti del cattolico Nuovo
Grande Commentario Biblico ritengono che la visita della regina di
Saba a Salomone sia "una leggenda popolare, ma può avere un nocciolo
storico in una visita da parte di una delegazione commerciale araba";
secondo il racconto biblico, tra i doni che la regina portò a Salomone vi
furono centoventi talenti d'oro, ovvero ben oltre le due tonnellate
di oro, una quantità inverosimile.
La regina di Saba riappare in Matteo 12:42 e in Luca 11:31,
dove Gesù afferma che lei e gli abitanti di Ninive il
giorno del Giudizio universale sorgeranno per condannare gli ebrei
che lo hanno rifiutato.
Nel Cantico dei cantici,
conosciuto anche come Cantico di Salomone, alcuni hanno voluto trovare
riferimenti interpretabili come prova dell'amore tra Salomone e la Regina di
Saba.
Leggende
ebraiche posteriori
Lo storico ebreo Giuseppe Flavio enfatizza il suo amore per
l'apprendimento. Le dà il nome di Nikaule, supponendo che ci sia una
connessione con la regina Nitocri descritta da Erodoto.
Altre leggende ebraiche sostengono che il regalo che promise Salomone («qualsiasi cosa desideri») sia
concretamente una relazione amorosa, e grandi sforzi sono stati fatti studiando
gli enigmi che la regina propone al re per testare la sua saggezza.
Il racconto
coranico
Neanche il Corano menziona il nome della Regina di Saba, malgrado alcune
fonti arabe la chiamino Bilqis. La storia è simile a quella della Bibbia.
Cambia il punto di partenza: è Salomone che viene a conoscenza del regno di
Saba perché il suo popolo venera il Sole. Dopo aver minacciato una guerra,
il re d'Israele riceve la regina di Saba che adotta la religione ebraica.
Recentemente, alcuni studiosi arabi hanno ipotizzato che Saba non si trovi
in Yemen, come sostengono alcune fonti, ma nel nord ovest dell'Arabia
Saudita, in una colonia commerciale fondata dai regni arabi del sud.
Gli scavi archeologici hanno confermato l'esistenza di queste
colonie, che possedevano le stesse caratteristiche della madrepatria, ma ancora
non è stato scoperto nulla su Bilqis.
Racconto
etiope, il libro Kebra Nagast
La visita della regina di Saba al re Salomone; dipinto di Sir Edward John
Poynter.
Secondo la testimonianza di questo antico documento sacro (IV-VI secolo
d.C.), la famiglia imperiale etiope discende direttamente
dall'incontro amoroso tra il Re Salomone e la Regina di Saba,
chiamata Machedà secondo la tradizione africana. Il libro epico etiope
dei Re, il Kebra Nagast, contiene la storia di Machedà e dei suoi
discendenti: riporta di come Salomone abbia incontrato la Regina (evento documentato
anche nella Bibbia, 1 Re 10, 2 Cr 9) e abbia avuto un figlio da lei, il
primogenito, incoronato Re con il titolo di Menelik I, primo
imperatore d'Etiopia. La testimonianza del Kebra Nagast riporta di
come Menelik abbia trafugato l'Arca dell'Alleanza da Gerusalemme
all'Etiopia, ove probabilmente si trova tuttora.
È stato provato che le antiche comunità etiopi erano formate da una
popolazione semita, emigrata attraverso il Mar Rosso dall'Arabia
meridionale, mescolatesi con i locali abitanti non semiti. Inoltre,
l'antico regno etiope di Axum ha governato anche una parte
dell'Arabia meridionale che comprendeva lo Yemen fino alla nascita dell'Islam nel VII
secolo. Per di più, l'amarico e il tigrino, le due principali lingue
dell'Etiopia, sono lingue semitiche.
Come prova della relazione tra Arabia ed Etiopia si hanno anche molti
reperti archeologici e alcune iscrizioni nell'antico alfabeto della
penisola arabica meridionale.
Persistenza
nell’età medievale
Giovanni Boccaccio, nell'opera De
mulieribus claris, e la scrittrice Christine de Pisan,
nell'opera Il Libro delle Città
delle Dame del 1404, proseguono con la tradizione avviata da
Giuseppe Flavio, attribuendo alla regina il nome Nicaula. La Regina di Saba
appare frequentemente nelle carte nautiche medievali di tradizione
maiorchina o più in generale iberica.
Ritrovamenti
archeologici
Il 9 maggio 2008 è stato diffuso un comunicato dell'Università di Amburgo secondo
cui un'équipe tedesca, guidata dall'archeologo Helmut Zeigert, avrebbe scoperto
i resti del palazzo della leggendaria "regina di Saba".
Le rovine ritrovate presso Dungur (Etiopia) e collocate sotto i
ruderi del palazzo di un re cristiano, erano quelle di un palazzo databile
intorno al X secolo avanti Cristo.
I pareri del mondo accademico sono, tuttavia, discordanti.
In particolare il professor Siegbert Uhlig, capo dell'unità di ricerca
degli studi etiopi, ha affermato: «Ziegert non ha discusso le sue ipotesi con
alcun collega che avesse lavorato nel campo degli studi etiopi o in quello
dell'archeologia africana. Zeigert non è un membro dell'Unità di Ricerca. I
membri ed il capo dell'Unità di Ricerca degli Studi Etiopi dell'Università di
Amburgo considerano l'identificazione pubblicata non scientificamente provata».
Secondo Ricardo Eichmann, direttore del Dipartimento dell'Oriente dell'Istituto
Archeologico Germanico di Berlino, attivo nella ricerca storica di fonti
attendibili circa la regina di Saba, fino ad oggi non ci sono prove della sua
reale esistenza.
Biografia
Durante il suo regno fu vassallo di re Tiglatpileser III d'Assiria.
Il regno di Rezin finì attorno al 732 a.C. quando Tiglathpileser saccheggiò
Damasco ed annesse Aram. Secondo la Bibbia, il sacco di Damasco fu
istigato da re Acaz di Giudea e terminò con l'esecuzione di
Rezin (secondo libro dei Re, 16:7-9).
L'esecuzione di Rezin non è né confermata
né smentita dalle prove raccolte.
Secondo il secondo libro dei Re, Rezin si alleò con Pekah, figlio
di Remaliah, contro Acaz.
La sconfitta dei due re viene promessa ad Acaz nella profezia di Emmanuele (Isaia
7:14), legata alla nascita di un bambino che sarebbe stato un infante, forse
l'erede reale di Acaz, Ezechia, quando sarebbe successo.
Rizpà, romanizzato
anche come Rispa, è un
personaggio femminile della Bibbia. Fu la figlia di Aià e una
delle concubine di Saul dal quale concepì Armonì e Merib-Bàal.
Etimologia
La parola Rizpà può probabilmente derivare dal verbo ebraico "tizzone
ardente", "pietra infuocata") Nella Septuaginta greca
il suo nome è ρεσφα (trasl: resfa).
È menzionata in 2 Samuele 3:7 e in 2 Samuele 21:8-11.
Nella Bibbia
Rizpà veglia nella notte quieta sui corpi in
disfacimento dei figli (William Turner, 1812)
Alla morte di Saul, Abner fu accusato di essersi unito con
Rizpah. La lite con Is-Bàal, l'erede di Saul, portò alla defezione di
Abner da Davide (2 Samuele 3:17-21), alla caduta di Is-Bàal e
alla riunificazione dei due regni di Israele sotto l'unica corona di Davide,
che già era a capo di quello Giuda.
Durante la prima metà del regno di David a Gerusalemme, Israele fu colpito
da una grave carestia di tre anni. Si credeva che questa calamità fosse
conseguenza delle azioni di Saul contro i Gabaoniti, che erano i
superstiti non ebrei del popolo di amorita. Quando Davide chiese ai
Gabaoniti quale fosse la riparazione da loro desiderata, essi risposero che
null'altro avrebbe potuto compensare i torti di Saul se non la morte di sette
dei suoi figli.
Davide consegnò loro i due figli di Rizpà e cinque dei figli di Merab, la
figlia maggiore di Saul, che questi diede in sposa al nobile Adriele. I
Gabeoniti li uccisero e appesero i loro cadaveri nel santuario di Gabaa In
seguito Rizpà prese dimora su una roccia di Gibaa e per cinque mesi rimase ad
osservare i corpi sospesi dei suoi figli, per impedire che fossero divorati
dalle bestie e dagli uccelli rapaci, finché il re Davide non gli diede una
degna sepoltura nella tomba di famiglia a Zela dove riposavano
anche i resti di Saul e Gionata.
Nella
letteratura
Il rabbino britannico Jonathan Magonet disse che Rizpà era come «ogni madre
che vede i suoi figli morire prematuramente per la ragione di Stato, siano essi
in tempo di pace o in tempo di guerra. Tutto ciò che le resta è preservare la
dignità della loro memoria e continuare a vivere per rendere testimonianza
testimoniare e chiedere conto ai governanti del mondo».
*Rut
Rut è un
personaggio della Bibbia ebraica e dell'Antico Testamento cristiano.
La sua storia è raccontata nel libro che da lei prende il nome.
Rut è una delle cinque donne menzionate nella genealogia di Gesù presente
nel Vangelo secondo Matteo, insieme a Tamar, Raab, la
"moglie di Uria" (Betsabea), e Maria.
Racconto
Biblico
Secondo il racconto biblico, Rut era una donna moabita che aveva
sposato un israelita. Infatti, nel tempo in cui i giudici governavano
le tribù d'Israele, ci fu una carestia. A causa della crisi, Elimelech,
un uomo proveniente dal Betlemme, dovette trasferirsi nel Moab con
sua moglie Noemi e i suoi figli Maclon e Chilion. Dopo la morte di
Elimelech i suoi due figli sposarono due donne moabite: uno sposò Orpa e
l'altro Rut. Passarono circa dieci anni prima che anche Maclon e Chilion
morissero.
Quando Noemi seppe che la carestia in Giudea era finita, decise
di tornare a casa e disse alle sue nuore di tornare alle case delle loro madri
e risposarsi. All'inizio sia Orpa che Rut si rifiutarono di lasciarla, ma poi
Orpa ritornò a malincuore dal suo popolo, lasciando Noemi e Rut.
In seguito, Noemi e Rut raggiunsero Betlemme all'inizio del periodo della
raccolta dell'orzo. A Betlemme viveva un parente di Elimelech, Booz (o
Boaz), e Rut decise di lavorare presso il suo campo e di spigolare insieme ai
suoi mietitori. Quando Booz giunse nel campo, egli chiese chi fosse quella
giovane donna arrivata da poco e poi le disse di non andare altrove, ma di
continuare a spigolare nel suo campo. Quando Rut gli chiese perché egli fosse
così gentile con una straniera, Booz le rispose che sapeva già quanto fosse
stata leale con Noemi. Giunta l'ora del pasto, Booz invitò Rut a mangiare con
lui e ordinò ai suoi mietitori di non rimproverarla, ma di lasciare qualche
orzo in più che lei potesse spigolare. Rut così continuò a spigolare nel campo
di Booz per tutta la raccolta dell'orzo e del grano.
Alla fine del raccolto, di notte, quando Booz stava crivellando l'orzo
nell'aia, Noemi consigliò a Rut di lavarsi e ungersi, andare all'aia e, una
volta che Booz si fosse addormentato, di scoprire i suoi piedi e restare lì.
Rut fece esattamente quanto le fu detto. A mezzanotte Booz si alzò e Rut gli
chiese di proteggerla, in quanto era il goel di suo marito, ovvero il parente più vicino che
potesse proteggere i suoi diritti. Booz le disse, tuttavia, che c'era un
parente più prossimo al quale chiedere.
Il mattino successivo, Booz andò a parlare con il parente alle porte della
città e disse a Noemi che questo avrebbe riscattato il terreno in vendita di
Elimelech. Il parente si rifiutò di sposare Rut tramite un levirato e
quindi Booz poté acquistare il terreno e sposare la giovane vedova. I due
ebbero un figlio, Obed, che divenne il padre di Iesse, a sua volta
padre del re Davide.
Interpretazione religiose
Ebraismo
La gentilezza di Rut, come notato da Booz nel libro biblico, viene vista
nella tradizione ebraica come un raro esempio di gentilezza da parte di una
moabita nei confronti degli ebrei: infatti, è scritto nella Torà (Deut.
23:5) che i moabiti non erano gentili nei confronti degli israeliti.
Secondo alcune interpretazioni ebraiche del libro biblico, i rabbah, Rut era la sorella di Orpa e
il loro padre era Eglon, il re di Moab; secondo la stessa interpretazione Eglon era
il figlio del re Balak. Tamar Meir, un membro del Jewish Women's Archive, afferma che
il fatto che Rut e Davide discendano da questi due re sia una sorta di
"ricompensa" per loro. Secondo lo stesso testo Rut non si
sarebbe convertita con il suo matrimonio con Maclon, contraddicendo il resto
della letteratura rabbinica, secondo la quale Rut si convertì formalmente
al giudaismo con il suo matrimonio con Maclon ma avrebbe realmente accettato la
fede solo in seguito.
Flavio Giuseppe riteneva che il libro di Rut fosse storico e lo citò
nella sua opera Antichità
giudaiche. Yitzhak Berger ipotizza che il piano di Noemi fosse che Rut
seducesse Booz così come Tamar e le figlie di Lot hanno sedotto dei
membri della famiglia più anziani per dare alla luce la sua prole. Al momento
cruciale, tuttavia, Rut avrebbe abbandonato il tentativo di seduzione e avrebbe
richiesto un'unione legale e permanente con Booz.
Cristianesimo
Katharine Doob Sakenfeld sostiene che Rut è un modello di gentilezza
amichevole (chesed in
ebraico) poiché agisce così da aiutare gli altri. Nonostante potesse rimanere
nella terra dei Moabiti, Rut decise di accompagnare sua suocera nella terra
degli Israeliti, di spigolare nei campi e di sposare Booz, anche se non era
obbligata. Barry Webb fa notare come Rut abbia avuto un ruolo fondamentale
nella riabilitazione di Noemi.
Rut è venerata il 16 luglio come matriarca nel calendario dei santi della chiesa
luterana–Sinodo del Missouri.
Luogo di
pellegrinaggio
Ad Ebron è situato un luogo ritenuto dalla tradizione la tomba
della moabita. All'inizio del diciassettesimo secolo Francesco Quaresmio riferiva
che i turchi e i popoli dell'Oriente ritenevano che la struttura contenesse al
suo interno le tombe di Iesse e Rut. Secondo Moše Šaron,
l'associazione del sito con Rut è molto tarda e inizia solo nel diciannovesimo
secolo. Ogni anno il luogo viene visitato da molta gente, soprattutto per
la Festa delle Settimane, una festività ebraica nella quale si legge
spesso il libro di Rut.
Nella cultura
di massa
Rut è una delle cinque eroine dell'Ordine della Stella dell'Est, un
ordine massonico.
Il poeta inglese John Keats cita Rut nella sua "ode a un
usignolo" come una donna isolata e addolorata che lavora faticosamente in
esilio. Lo scrittore francese Victor Hugo scrisse una poesia
intitolata Booz addormentato (Booz endormi) basandosi sulla storia
biblica.
Molti artisti si sono ispirati alla figura di Rut nel corso dei secoli,
come Francesco Hayez, Julius Schnorr von Carolsfeld, Antonio
Cortina Farinós e William Blake, che raffigurò per due volte la
partenza della vedova con sua suocera Noemi.
Rut è stata interpretata da Elana Eden nel fim La storia di Ruth di Henry
Koster (1960): in questa pellicola la donna è inizialmente una
sacerdotessa pagana del dio moabita Chemoš che
successivamente si converte all'ebraismo. Sherry Morris l'ha interpretata nel film The Book of Ruth: Journey of Faith del
2009.