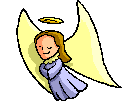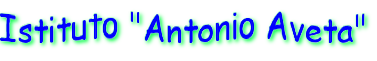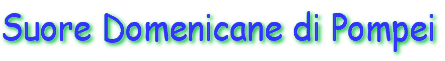Personaggi Biblici M
Con Gesù > Personaggi Biblici
Personaggi Biblici "M"

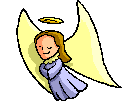
Madai è un personaggio biblico, menzionato due volte nella Bibbia. Secondo il libro della Genesi era figlio di Jafet e uno dei sedici nipoti di Noè. Madai è stato talvolta indicato come il capostipite di diversi popoli, dai Hurriti di Mitanni ai Medi (in ebraico, Māday).
Secondo il Libro dei Giubilei (10:35-36), Madai sposò una figlia di Sem e preferì vivere presso la sua famiglia che stabilirsi nella terra ereditata da Jafet oltre il Mar Nero. Così chiese ai suoi cognati Elam, Assur e Arpacsad di cedergli la terra che avrebbe avuto il suo nome, la Media.
Un altro verso dei Giubileo (8:5) sostiene che una figlia di Madai chiamata Milcah sposò Cainam, un avo di Abramo citato anche nella Genesi della Septuaginta.
Nella Bibbia, Madian è un figlio di Abramo e della sua seconda moglie Chetura (che, invece, secondo il midrash, è Agar).
I suoi discendenti, i Madianiti occuparono la regione nord-occidentale del selvaggio e disabitato deserto d'Arabia. Durante il periodo dell'Esodo il loro territorio includeva anche l'area del deserto di Paran nella penisola del Sinai.
Nella Bibbia, il territorio madianita nel Sinai fu il luogo dove Mosè trascorse i 40 anni tra il momento in cui lasciò l'Egitto dopo aver ucciso un egiziano che stava picchiando un ebreo e il suo ritorno per condurre alla Terra promessa gli Israeliti. Durante questi anni sposò Sefora, figlia di Ietro, sacerdote di Madian. Esodo 3,1 afferma che l'apparizione di Dio nel cespuglio ardente sull'Horeb (altro nome del monte Sinai) sia accaduta in Madian.
Mentre i discendenti di Ietro, i keniti, si unirono agli ebrei, le altre tribù madianite ebbero violenti contrasti con gli israeliti.
Oggi l'originario territorio di Madian è diviso tra l'ovest dell'Arabia Saudita, il sud della Giordania, il sud di Israele e il Sinai.
Anche nel Corano figura l'antico e storico popolo di Madian, che è menzionato col nome arabo Madyan. La tomba di Ietro sarebbe oggi la moschea e la tomba del profeta Shu'ayb (V sec. d.C. cfr. Sura XI, 95), che sono situate presso la città giordana di Mahis, in un'area chiamata Wādī Shuʿayb.
Magog è il
secondo dei sette figli di Jafet menzionati nella Tavola delle
Nazioni in Genesi 10.
Mentre l'origine del termine non è chiara, essa potrebbe fare riferimento
alla Lidia, nell'attuale Turchia. Il suo uso nel Libro di
Ezechiele, capitolo 38, ha portato alla sua associazione con tradizioni apocalittiche.
Varie tradizioni antiche e medievali hanno costruito sui riferimenti biblici e
aggiunto dettagli ad esso.
Etimologia
L'origine del nome Magog non è chiara. Potrebbe provenire dall'accadico mat Gugi, "terra di Gog",
cioè la terra di Gige, ovvero la Lidia.
Nella Bibbia
Magog è spesso associato a tradizioni apocalittiche, principalmente in
relazione a Ezechiele 38 e 39 che menziona "Gog della terra di
Magog, il principe di Meshech e Tubal" (Ezechiele 38,2);
sulla base di questa menzione, "Gog e Magog" nel tempo sono stati
associati tra loro in coppia.
Nel Nuovo Testamento, questa associazione si trova in Apocalisse 20,8,
nel qual caso possono essere semplicemente metafore per archetipici nemici di
Dio.
Nel Corano
L'apparizione di Magog nel Corano e in altre fonti islamiche è
principalmente dovuta alla sua fama apocalittica come parte dell'abbinamento
di Gog e Magog (in arabo: Ya'juj wa Ma'juj). Nella sura Al-Kahf
("La caverna", 18: 83–98) del Corano (inizi
del VII secolo d.C.), un individuo chiamato Dhu al-Qarnayn ("Colui
che ha due corni") viaggia verso una terra lontana in un passaggio tra due
montagne dove trova persone che soffrono del male di Gog e Magog. Dhu
al-Qarnayn costruisce quindi un muro di rame e ferro per tenere fuori Gog e
Magog, ma avverte che esso verrà rimosso nell'ultima era. Nella sura 21,
Al-Anbiyā (I profeti), il muro è menzionato di nuovo: lì Allah dice
al suo profeta Maometto che esiste un "divieto per [il popolo
di] una città che abbiamo distrutto che [sempre] ritorna, finché [la diga di]
Gog e Magog non sarà stata aperta e li vedrai, da ogni livello più alto, in
discesa. "
Interpretazioni
antiche e medioevali
Flavio Giuseppe si riferisce a Magog figlio di Iafet come progenitore
degli Sciti, o popoli a nord del Mar Nero. Secondo lui, i Greci
chiamavano la Scythia Magogia.
Un'identificazione alternativa, derivata da un esame dell'ordine in cui i nomi
tribali sono elencati in Ezechiele 38, "collocherebbe Magog tra Cappadocia e Media".
Secondo il rabbino Shlomo Ganzfried (XIX secolo) Magog si riferisce ai mongoli.
Egli cita uno scrittore arabo che si riferisce alla Grande Muraglia cinese
con il nome "Magog".
Getica di Giordane (551) menziona Magog come antenato
dei Goti, così come la Historia Brittonum, ma Isidoro di
Siviglia (c. 635) afferma che questa identificazione era popolare "a
causa della somiglianza dell'ultima sillaba" (Etymologiae, IX, 89). Giovanni
Magno (1488–1544) dichiarò che Magog emigrò in Scandinavia (passando
per la Finlandia) 88 anni dopo il diluvio e che i suoi cinque figli erano
Suenno (antenato degli svedesi), Gethar (o Gog, antenato dei Goti), Ubbo (che
in seguito governò gli svedesi e costruì la città di Gamla Uppsala), Thor
e Germano.
I resoconti di Giovanni Magno furono accettati a lungo presso la
corte svedese e fecero addirittura rinumerare di conseguenza i numeri dinastici
dei monarchi svedesi. La regina Cristina di Svezia si considerava la
numero 249 in un elenco di re risalenti a Magog. Giovanni influenzò anche
diversi storici successivi come Daniel Juslenius (1676–1752), che derivò le
radici dei finlandesi da Magog.
Secondo diverse cronache irlandesi medievali, in particolare l'Auraicept na n-Éces e il Lebor Gabála Érenn, la stirpe
irlandese discenderebbe da Magog. Baath, Jobhath e Fathochta mac Magog
sarebbero i tre figli di Magog secondo queste cronache, e vengono citati come
individui apicali nelle genealogie. In particolare i re milesi, antenati
di tutti gli Irlandesi, discenderebbero da Baath (Boath), figlio di Magog.
Magog avrebbe anche avuto un nipote chiamato Heber, la cui progenie si diffuse
in tutto il Mediterraneo.
Esiste inoltre una leggenda ungherese medievale secondo la quale gli Unni,
così come i Magiari, discendono rispettivamente dai fratelli gemelli di
nome Hunor e Magor, che vissero vicino al Mare di Azov negli anni
successivi al diluvio e presero le mogli dagli Alani. La versione di
questa leggenda nel Chronicon
Pictum del XIV secolo identifica questo Magor con Magog, figlio di
Jafet.
Mardocheo o Mordecai è un personaggio biblico di
cui si parla nel Libro di Ester.
Il nome
Mardocheo è il figlio di Giairo della tribù di Beniamino, una delle
due tribù che costituirono il Regno di Giuda prima della sua
distruzione da parte dei babilonesi e le deportazioni dell'élite del
regno nelle province dell'impero persiano.
L'origine del nome Mardocheo è
incerta. Sembra che significhi, in aramaico, "servitore di Marduk", dove Marduk è il nome di un dio
babilonese. Questi è generalmente descritto sia come dio creatore nella
mitologia babilonese (e questo renderebbe Mardocheo un "servitore di Dio") sia come un
dio della guerra (e allora "servitore di Marduk" potrebbe significare
"guerriero"). Ciò non
è inverosimile, giacché più volte nel libro di Daniele si fa menzione
di Giudei esiliati che hanno ricevuto dei nomi che si riferiscono a divinità
babilonesi.
D'altra parte nel libro di Esdra 2,2 il nome di Mardocheo è
seguito da Bilsan: nome
che può essere inteso come il suo originario ebraico.
Nel dizionario Dizionario Biblico Hitchcock sono state offerte altre
interpretazioni del nome Mardocheo supponendovi un'origine persiana:
"piccolo uomo", "penitenza", "amarezza", ecc. Mardocheo
è il primo personaggio della Bibbia ad essere qualificato come "Yehoudi", che si traduce con Giudeo.
Racconto
biblico
La genealogia indicata dal Libro di Ester 2,5-6 indica che Mardocheo
appartiene alla quarta generazione dei Giudei dopo l'esilio forzato degli
abitanti del regno di Giuda sotto Nabucodonosor. Alcuni hanno
interpretato il passo biblico come se Mardocheo stesso fosse della generazione
dei deportati.
Nella descrizione biblica, Mardocheo abita nella città di Susa in Persia con
sua cugina, orfana, Ester, ch'egli ha accolto ed allevato come sua propria
figlia. Quando il re Assuero fa cacciare dalla sua corte la regina Vashti per
aver rifiutato di presentarsi al suo cospetto, si scatena una ricerca
forsennata e violenta di giovani vergini da portare a palazzo con lo scopo di
trovare la nuova regina.
Ester entra così nell'harem del re Assuero e
diventa regina. Mardocheo occupa un posto a palazzo che gli permette di essere
vicino al re ed alla sua corte. Egli scopre così un complotto di eunuchi contro
la persona del re. Egli lo rivela al sovrano e questo servizio reso da
Mardocheo è annotato nei registri reali.
Mardocheo è inoltre in conflitto con Amàn, il ministro del re, il quale non
può sopportare che Mardocheo sia il solo personaggio della corte a non
prostrarsi davanti al re (il giudaismo, infatti, permette di prostrarsi
solamente davanti a Dio).
Amàn prepara un decreto per far uccidere nell'impero persiano tutti gli
esiliati di origine giudaica. L'esecuzione di questo decreto è pianificata con
la scelta di una data di esecuzione. Mardocheo ed Ester influenzano il re
perché permetta ai Giudei di difendersi.
Il piano di sterminio si ritorce
contro quelli che lo avevano organizzato: Amàn viene ucciso con i suoi figli,
ed i Giudei sono salvati. Il giorno anniversario in cui la sorte è ritornata
favorevole ai Giudei è celebrata con una festa detta di Purim.
Status di
profeta
Il Talmud elenca
sia Mardocheo sia Ester in qualità di profeti;
affermando che Mardocheo profetizzò nel secondo anno del regno di re Dario.
Mattatia è stato un sacerdote ebreo antico della prima classe sacerdotale (di Ioarib), "figlio di Giovanni e nipote di Simeone" È il padre dei Maccabei e dei loro successori, la dinastia degli Asmonei, iniziata dal figlio Simone.
La sua storia è narrata nel Primo libro dei Maccabei.
La sua storia è narrata nel Primo libro dei Maccabei.
Contesto
Antioco IV, in cambio di privilegi concessi all'élite ebraica ellenizzata, riuscì ad impadronirsi del tesoro del Tempio di Gerusalemme, che fece sconsacrare e adibire al culto pagano di Zeus Olimpo. Mattatia uccise l'apostata ebreo preposto al nuovo culto e si rifugiò sui monti insieme ai suoi cinque figli e a numerosi seguaci Asidei, dando l'avvio alla rivolta.
Storia
Il Primo Libro dei Maccabei afferma che il re Antioco IV Epifane impose il culto degli idoli pagani, perseguitando gli Israeliti che continuavano ad obbedire alla Legge, a compiere sacrifici e praticare la circoncisione:
«Nell'anno centoquarantacinque, il quindici di Casleu il re innalzò sull'altare un idolo. Anche nelle città vicine di Giuda eressero altari e bruciarono incenso sulle porte delle case e nelle piazze.
Stracciavano i libri della legge che riuscivano a trovare e li gettavano nel fuoco. Se qualcuno veniva trovato in possesso di una copia del libro dell'alleanza o ardiva obbedire alla legge, la sentenza del re lo condannava a morte. Con prepotenza trattavano gli Israeliti che venivano scoperti ogni mese nella città e specialmente al venticinque del mese, quando sacrificavano sull'ara che era sopra l'altare dei sacrifici.
Mettevano a morte, secondo gli ordini, le donne che avevano fatto circoncidere i loro figli, con i bambini appesi al collo e con i familiari e quelli che li avevano circoncisi.»
Flavio Giuseppe afferma nelle Antichità Giudaiche che Apelle, emissario di Antioco IV fece costruire a Modin un altare dedicato agli dei pagani, e che questi ordinò a Mattatìa, che era la più influente autorità spirituale del luogo, di accondiscendere al volere del re, compiendo sacrifici in onore dell'idolo.
Mattatìa si rifiutò, richiamando gli Ebrei a non abbandonare la tradizione e le pratiche religiose dei loro padri, e, quando un Ebreo ellenizzato si dichiarò pronto ad adorare il nuovo idolo e a collaborare col nuovo re, Mattatìa lo uccise e distrusse l'altare pagano, mentre i suoi figli uccidevano l'inviato di Seleuco. Nuovamente, Mattatìa disse alla folla di restare saldamente fedeli alla legge e di unirsi alla rivolta.
In modo simile, 1 Maccabei 2:23-28 afferma:
«Terminate queste parole, si avvicinò un Giudeo alla vista di tutti per sacrificare sull'altare in Modin secondo il decreto del re. Ciò vedendo Mattatia arse di zelo; fremettero le sue viscere ed egli ribollì di giusto sdegno. Fattosi avanti di corsa, lo uccise sull'altare; uccise nel medesimo tempo il messaggero del re, che costringeva a sacrificare, e distrusse l'altare. Egli agiva per zelo verso la legge come aveva fatto Pincas con Zambri figlio di Salom. La voce di Mattatia tuonò nella città: «Chiunque ha zelo per la legge e vuol difendere l'alleanza mi segua!». Fuggì con i suoi figli tra i monti, abbandonando in città quanto avevano.»
Morte ed eredità
Secondo il Primo Libro dei Maccabei, Mattatia "morì nell'anno centoquarantasei e fu sepolto nella tomba dei suoi padri in Modin; tutto Israele fece grande pianto su di lui". Le datazioni nel Primo Libro dei Maccabei sono riferite al primo anno di dominio dei Greci (I, v. 10) Flavio Giuseppe data la morte di Mattatìa nel 166 a.C., affermando che fu sepolto a Modin. La sua tomba giace non lontano da quella dei suoi figli.
Dopo aver educato i figli ad una scrupolosa osservanza delle prescrizioni bibliche, incaricò suo figlio maggiore Giuda Maccabeo di proseguire la lotta, e Simone di essere suo consigliere. Entrambi perirono in battaglia, così come gli altri fratelli: Giovanni, Eleazaro e Gionata.
Dopo la sua morte nel 165 a.C., i figli proseguirono l'attività politico-religiosa avviata dal padre.
Dopo la sua morte nel 165 a.C., i figli proseguirono l'attività politico-religiosa avviata dal padre.
Dinastia asmonea
Simone e i suoi discendenti diedero vita alla dinastia asmonea che regnò su Israele fino al tempo di Erode 37 a.C.). Questi sposò in seconde nozze Mariamne, diretta discendente del casato degli Asmonei, da cui ebbe quattro figli.
I due maschi Aristobulo ed Alessandro furono entrambi giustiziati per strangolamento nel 7 a.C. a Sebaste di Samarìa, ponendo così fine alla secolare dinastia asmonea.
Chanukkah
Gli eventi della Guerra dei Maccabei formano la base per la festività di Chanukkah, celebrata dagli Ebrei il 25 di Kislev nel calendario ebreo, che corrisponde al periodo compreso fra metà di novembre e la fine di dicembre nel Calendario Gregoriano.
Melchisedek è una figura emblematica e misteriosa presente nell'Antico testamento, della Tanakh o Bibbia ebraica.
Nella Bibbia è identificato come re del regno di Salem (che si ritiene fosse l'antica Gerusalemme) e come Sacerdote dell'altissimo Elyon; secondo l'esegesi ebraica si tratta di Sem, figlio di Noè.
Melchisedek nell’Antico Testamento
Nell'evidenza storica dell'Antico Testamento ci sono due brani in cui si definisce Melchisedec. Nel primo (Genesi 14:18-20) Melchisedec è un re e un sacerdote, una figura comunque umana. Nel secondo passo (Salmo 110:4) Melchisedec è invece un Sacerdote eterno.
Il Dixit Dominus viene citato in Ebrei 5, con un secondo significato profetico, oltreché storico. Il sacerdote ordinato dal Signore secondo Melchisedek non è solo Re Davide (che trascrisse il Salmo), ma anche Gesù Cristo, suo ultimo discendente (il «Germoglio di Davide», il «Leone della tribù di Giuda»).
Nella Genesi La figura di Melchisedek appare nel libro della Genesi 14,18:
«Quando Abram fu di ritorno, dopo la vittoria su Chedorlaomer e dei re che erano con lui, il re di Sodoma gli uscì incontro nella Valle di Save, cioè la Valle del re. 18 Intanto Melchisedek, re di Salem, offrì pane e vino: era sacerdote del Dio altissimo 19 e benedisse Abramo con queste parole: "Sia benedetto Abramo dal Dio altissimo, proprietario del cielo e della terra, 20 e benedetto sia il Dio altissimo, che ti ha messo in mano i tuoi nemici". Abramo gli diede la decima di tutto.»
Abramo, antenato degli Ebrei, rispettava Melchisedec come suo superiore.
Melchisedec non apparteneva al popolo ebraico.
Nel libro dei Salmi
Il secondo punto in cui si parla di Melchisedec nell'Antico Testamento è nel Salmo 109 (Dixit Dominus), in cui si prefigura la venuta di una figura messianica destinata ad esercitare il giudizio di Dio, che sarà sacerdote eterno in modo analogo a Melchisedec.
Dice il Signore al mio Signore: «Siedi alla mia destra, finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi». Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion: «Domina in mezzo ai tuoi nemici. A te il principato nel giorno della tua potenza tra santi splendori; dal seno dell'aurora, prima della luce, io ti ho generato». Il Signore ha giurato e non si pente: «Tu sei sacerdote per sempre al modo di Melchisedec». Il Signore è alla tua destra, annienterà i re nel giorno della sua ira. Giudicherà i popoli: in mezzo a cadaveri ne stritolerà la testa su vasta terra. Lungo il cammino si disseta al torrente e perciò solleva alta la testa. (Salmo 110)
La legge mosaica vietava ai Re di Israele di essere anche sommi sacerdoti, compito riservato ai leviti, con una provata discendenza (Neemia 7:61-65). Tuttavia, Dio nomina Re Davide, quale sacerdote alla maniera di Melchisedek. Nel contesto storico specifico, infatti, il re, pur non potendo essere sommo sacerdote, esercitava compiti sacerdotali in particolari occasioni (cfr. 1° Libro dei Re, 8,62-66)
Nel secondo libro di Enoch
Oltre che nei libri canonici, Melchisedek appare anche nel Secondo libro di Enoch, un apocrifo dell'Antico Testamento. Questo libro contiene una parte detta Esaltazione di Melchisedek, in cui si racconta la nascita di Melchisedek da una donna sterile e anziana di nome Sofonima (o Soponima). Ella era moglie di Nir, un fratello di Noè, ed era rimasta incinta miracolosamente, perché il marito non aveva rapporti con lei da lungo tempo, in quanto era stato nominato sacerdote. La donna morì prima di mettere al mondo il figlio, ma prima che Nir la seppellisse, Melchisedek venne fuori dal corpo della madre, essendo fisicamente sviluppato come un bambino di tre anni e capace di parlare e pregare Dio. Dopo 40 giorni, l'arcangelo Gabriele comparve a Nir e gli disse che avrebbe portato il bambino nel Giardino dell'Eden; Melchisedek fu così preservato dal Diluvio universale, in modo da poter tornare sulla Terra a tempo debito. Nir morì il giorno dopo che il bambino fu portato via da Gabriele.
Alcuni hanno visto un'analogia tra il concepimento miracoloso di Melchisedek e quello di Gesù.
Melchisedek nel Nuovo Testamento – Nei Vangeli
Non vi sono riferimenti diretti a Melchisedek nel Nuovo Testamento, ma esiste un riferimento indiretto: Gesù cita in Matteo 22,41-45 il Salmo 110, uno dei due passi dell'Antico Testamento in cui si parla di Melchisedek e fornisce la sua interpretazione delle qualità fondamentali che deve possedere il Messia (sottintendendo che queste qualità si applicano a se stesso): Gesù nell'ultima Cena (Mc.I4,22), spezza il pane e mesce il vino alla maniera di Melchisedek, Genesi, XIV,I8; seguendo il Salmo 110,4: Il Signore ha giurato e non si pente: "Tu sei Sacerdote in eterno al modo di Melchìsedek". Manifestando interiormente, con l'Eucaristia, il sacrificio del sacerdote levitico. Subito dopo, Gesù si unisce agli Apostoli intonando la prima parte dell'Hallel della Pasqua ebraica, Salmi CXII - CXII, e infine dell'agape con la seconda parte dei Salmi CXIV-CXVII. Evidente una correlazione tra il pane e il vino di Melchisedek e l'ultima Cena di Gesù, che aderente alle "Scritture" apre all'Eucaristia.
Melchisedek nella Lettera agli Ebrei
Nella Lettera agli Ebrei si afferma che il sacerdozio di Gesù è di tipo diverso rispetto al sacerdozio ebraico, che era ereditario e riguardava i discendenti di Aronne e i leviti, e senza giuramento a Dio. Diversamente, Gesù è il Germoglio di Davide e il Leone della tribù di Giuda (Apocalisse 5:1), divenuto Sommo Sacerdote eterno alla maniera di Melchisedek (Ebrei, 7:17) per merito di una vita indifettibile e per giuramento. Egli è sommo sacerdote di beni futuri:
«Lo Spirito Santo intendeva così mostrare che non era ancora aperta la via del santuario, finché sussisteva la prima Tenda. Essa infatti è una figura per il tempo attuale, offrendosi sotto di essa doni e sacrifici che non possono rendere perfetto, nella sua coscienza, l'offerente, trattandosi solo di cibi, di bevande e di varie abluzioni, tutte prescrizioni umane, valide fino al tempo in cui sarebbero state riformate. Cristo invece, venuto come sommo sacerdote di beni futuri, attraverso una Tenda più grande e più perfetta, non costruita da mano di uomo, cioè non appartenente a questa creazione, non con sangue di capri e di vitelli, ma con il proprio sangue entrò una volta per sempre nel santuario, procurandoci così una redenzione eterna.»
Ebrei 7,1-4 – Questo Melchisedek infatti, re di Salem, sacerdote del Dio Altissimo, andò incontro ad Abramo mentre ritornava dalla sconfitta dei re e lo benedisse; a lui Abramo diede la decima di ogni cosa; anzitutto il suo nome tradotto significa re di giustizia; è inoltre anche re di Salem, cioè re di pace. Egli è senza padre, senza madre, senza genealogia, senza principio di giorni né fine di vita, fatto simile al Figlio di Dio e rimane sacerdote in eterno. Considerate pertanto quanto sia grande costui, al quale Abramo, il patriarca, diede la decima del suo bottino.
Ebrei 7,14-17 – È noto infatti che il Signore nostro è germogliato da Giuda e di questa tribù Mosè non disse nulla riguardo al sacerdozio. Ciò risulta ancor più evidente dal momento che, a somiglianza di Melchisedek, sorge un altro sacerdote, che non è diventato tale per ragione di una prescrizione carnale, ma per la potenza di una vita indefettibile. Gli è resa infatti questa testimonianza: Tu sei sacerdote in eterno alla maniera di Melchisedek.
Ebrei 7,22-24 – Per questo, Gesù è diventato garante di un'alleanza migliore. Inoltre, quelli sono diventati sacerdoti in gran numero, perché la morte impediva loro di durare a lungo; egli invece, poiché resta per sempre, possiede un sacerdozio che non tramonta.
La contrapposizione del sacerdozio Levitico e di Melchisedek è solo storica in ordine ad un fine comune di salvezza umana: entrambi versano la decima ad Abramo. Fatto insolito, la stessa lettera inizia con la traduzione di Melchisedek e di Salem: re di Giustizia, re di Pace.
Melchisedek nei Manoscritti del Mar Morto
Uno dei manoscritti non biblici di Qumran, in specifico il manoscritto 11Q13/11QMelch rinvenuto nella grotta 11 di Qumran presso il Mar Morto è stato datato paleograficamente tra la fine del II secolo a.C. e l'inizio del I secolo a.C. Esso è composto di tredici frammenti dai quali si sono ricavate due colonne. La colonna 2 è preservata molto bene, la colonna 3 è ricostruita solo con alcune parole. Può essere riguardato come una sorta di targum, uno scritto che in ebraico significa letteralmente "interpretazione", una parafrasi dei passi biblici che serve a spiegare e a interpretare i brani delle sacre scritture. È stato tradotto in italiano da parte di Florentino Garcia Martinez e studiato di recente nella monografia di Franco Manzi, Melchisedek e l'angelologia nell'Epistola agli Ebrei e a Qumran (= Analecta Biblica 136), Roma, Editrice Pontificio Istituto Biblico, 1997, 433 pp.
Il papiro è intitolato "Melchisedek e il giudizio finale". In tale testo si definisce Melchisedec come un elohim e come Messia.
Nelle lettere Paoline
In Ebrei 7:1-3 Paolo di Tarso spiega il significato del nome Melchisedek, re di Giustizia e del suo titolo, re di Salem, re di Pace.
Il nome Salem nella Bibbia (nella sua traduzione) è presente soltanto in un altro verso (Salmi 76:1-2): «[Al Maestro di Neginoth, un salmo o una canzone di Asaph]. Dio è conosciuto in Giuda, / in Israele è grande il suo nome. / In Salem è il suo Tabernacolo, in Sion il suo luogo di dimora». Come Sion, Salèm è identificato con uno dei nomi di Gerusalemme.
Dopo la vittoria di Abramo sul re di Sodoma, il re di Salem, luogo in cui "è il suo Tabernacolo", per la prima volta nella storia offre a Dio il pane e il vino prima di pronunciare (cantare) una preghiera di benedizione e di lode, in cui sono presenti gli elementi propri del rito eucaristico.
Dopo la vittoria di Abramo sul re di Sodoma, il re di Salem, luogo in cui "è il suo Tabernacolo", per la prima volta nella storia offre a Dio il pane e il vino prima di pronunciare (cantare) una preghiera di benedizione e di lode, in cui sono presenti gli elementi propri del rito eucaristico.
Paolo sottolinea che per Melchisedek non è fornita nessuna genealogia. Di lui manca anche l'indicazione di un luogo di morte e sepoltura, dato invece per tutti i patriarchi, fra i quali Abramo la cui benedizione è detta inferiore a Melchisedek (v. 7). L'assenza di genealogia si verifica in un libro ricco di Genealogie come la Genesi, e malgrado:
1. il sacerdozio levitico fosse ereditario;
2. la genealogia fondante per gli Unti a re d'Israele, come Davide e Gesù Cristo, che furono anche sacerdoti secondo Melchisedek.
Abramo incontra tre angeli, identificati con la Trinità (ad es. da Andrej Rublëv), così come Lot, figlio di suo fratello, è avvisato e messo in salvo da due angeli in apparenza umana prima della distruzione di Sodoma e Gomorra.
Entrambi sono protagonisti di incontri con angeli e, forse per Abramo, Dio stesso. Le qualità di Melchisedek, "Principe di Pace" e "Principe di Giustizia", compaiono anche come titoli messianici in vari profeti maggiori, alcuni secoli dopo.
Entrambi sono protagonisti di incontri con angeli e, forse per Abramo, Dio stesso. Le qualità di Melchisedek, "Principe di Pace" e "Principe di Giustizia", compaiono anche come titoli messianici in vari profeti maggiori, alcuni secoli dopo.
Melchisedek nella tradizione cattolica – Nella figura di Cristo
È significativo che Melchisedek abbia offerto pane e vino al Signore, come fece Gesù nell'ultima cena istituendo l'eucaristia secondo i Vangeli. Melchisedek assunse un posto primario nel pensiero monoteistico e cristiano: egli è l’archetipo (figura) che precede Gesù Cristo, nelle sue funzioni di sacerdote (Gesù Cristo viene definito nella lettera agli Ebrei "Sacerdote in eterno dell'Ordine di Melchisedek") e anche per indicare la seconda venuta del Signore Cristo che ritorna come Re dei re, cioè Re in eterno secondo l'ordine di Melchisedek.
Melchisedek nella preghiera eucaristica cattolica
Melchisedec è ricordato nel canone della Messa durante l'Anamnesi come preghiera per accettare il sacrificio, come quelli di Abele e Abramo.
«Volgi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno, come hai voluto accettare i doni di Abele, il giusto, il sacrificio di Abramo, nostro padre nella fede, e l'oblazione pura e santa di Melchisedek, tuo sommo sacerdote.»
Melchisedek nell’esoterismo
Alice Bailey nelle sue opere esoteriche, da lei indicate come ispirate dal Maestro Djwal Khul detto «il Tibetano», asserisce che Melchisedek è uno dei nomi o appellativi con i quali ci si riferisce (soprattutto nell'Antico Testamento) a Sanat Kumara, colui che presiede la comunità di Shamballa, ossia una fratellanza di esseri divini, la quale sopraintende spiritualmente al percorso evolutivo dell'umanità terrestre. Nello stesso scritto Melchisedek è anche detto il Signore del mondo e l'Antico dei Giorni.
Nella Bibbia, Meshech o Mosoch è nominato come figlio di Jafet in Genesi 10:2 e 1 Cronache 1:5. Un altro Meshech è indicato come figlio di Sem in 1 Cronache 1:17 (corrispondente alla forma Mash in Genesi 10).
Interpretazioni
Meshech è nominato con Tubal (e Rosh, in alcune traduzioni) come principato di "Gog, principe di Magog" in Ezechiele 38:2 e 39:1, ed è considerata una tribù jafetita, identificata da Flavio Giuseppe con i "Mosocheni" (Mushki, anche associati ai Frigi o Bryges) e alla loro capitale Mazaca. Nella cronaca di Ippolito di Roma (234 d.C.), gli "Illiri" furono identificati come discendenti di Meshech.
Inoltre, i Georgiani hanno tradizioni secondo cui loro e altri popoli del Caucaso come gli Armeni condividono la discendenza da Meshech (georgiano: Meskheti), Tubal e Togarma.
Nel 1498 Annio da Viterbo pubblicò frammenti noti come pseudo-Berosso, ora considerato un falso, sostenendo che i registri babilonesi mostravano che un figlio di Jafet chiamato Samothes aveva iniziato a colonizzare quella che in seguito divenne la Gallia nel 13º anno di Nimrod. Gli storici successivi come Raphael Holinshed (1577) identificarono Samothes come Meshech, e asserirono che egli governò per primo anche in Gran Bretagna.
A partire dal XVI secolo, alcuni studiosi europei hanno proposto l'idea che i moscoviti fossero derivati da Meshech. Sir Walter Raleigh (c. 1616) attribuisce questa opinione a Philipp Melanchthon (1497-1560) e a Benito Arias Montano (1571), e successivamente fu seguito anche da Jonathan Edwards (1703–1758). Inoltre, secondo una leggenda apparsa per la prima volta nella Sinossi di Kiev (1674), Mosca (Moskva) fu fondata dal re Mosokh figlio di Japheth (cioè Meshech), e prese il nome da lui e sua moglie, Kva. In questa leggenda, si dice anche che abbiano avuto un figlio, Ya, e una figlia, Vuza, che hanno dato il loro nome al vicino fiume Yauza.
Secondo Archibald Sayce, Meshech può essere identificato con Muska, un nome che appare nelle iscrizioni assire, e generalmente si ritiene che si riferisca ai Mushki.
La maggior parte dei testi a partire da Flavio Giuseppe in genere identifica il Meshech dei tempi di Ezechiele come un'area nella Turchia moderna.
Il racconto biblico
La sua storia è raccontata nei libri di Samuele. Qui è raccontato di come Saul diede in moglie a David sua figlia Mikal, che era invaghita di lui. In seguito, quando Saul divenne invidioso di David per via del suo valore militare e del suo successo, il re ordinò di uccidere il genero, ma Mikal, contravvenendo al volere di suo padre, salvò il marito dai messi inviati da Saul per ucciderlo facendolo fuggire dalla finestra e nascondendo i terafim nel letto al suo posto. Mentre David era nascosto, Saul diede in moglie Mikal a Palti figlio di Lais, mentre David prese molte altre mogli, tra cui Abigail.
Più tardi, quando David divenne re di Giuda e Is-Bàal, il fratello di Mikal, divenne re di Israele, David gli chiese di riavere Mikal, come sigillo della pace tra i due regni, e Is-Bàal acconsentì nonostante le suppliche e le lacrime di Palti. Questi eventi hanno portato a diversi dibattiti morali all'interno del giudaismo, soprattutto riguardo alla proibizione di ristabilire un matrimonio con una donna risposata presente nel Deuteronomio.
Alcuni commentatori tuttavia sottolineano come David non avesse divorziato da Mikal, ma Saul avesse rotto il loro matrimonio, risposando la figlia senza il consenso di David.
Secondo questo punto di vista i due non sarebbero stati quindi tecnicamente divorziati, in quanto David non avrebbe presentato un regolare atto di ripudio in ottemperanza alla legge biblica.
Dopo che Mikal tornò da David ebbe occasione di criticarlo in quanto lo vide danzare, parzialmente svestito, nel momento in cui l'Arca dell'Alleanza stava entrando nella Gerusalemme appena catturata. A differenza che per Abigail e Betsabea, di Mikal non è mai descritta la bellezza, anche se la letteratura rabbinica la descrive come di un'"incantevole bellezza"
Discendenza
Per quanto nel Secondo libro di Samuele ci sia scritto che «Mikal, figlia di Saul, non ebbe figli fino al giorno della sua morte», vi sono tuttora dubbi se Mikal ebbe o meno una discendenza. Questi dubbi nascono dal fatto che siano state ritrovate diverse versioni di un versetto successivo, 2Sam 21.8 che, nella versione della CEI, parla dei: «cinque figli che Meràb figlia di Saul aveva partoriti ad Adrièl il Mecolatita figlio di Barzillài.» ma che in molti manoscritti reca il nome di Mikal al posto di quello di "Meràb".
Questa versione, tra l'altro, è quella accettata dalla Bibbia di Diodati che, in questo versetto, scrive appunto dei «cinque figli, che Mikal, figlia di Saul, aveva partorito ad Adriel di Mehola, figlio di Barzillai.»
Nella poesia
Una costante della poetica dell'autrice israeliana Rachel Bluwstein è il paragonarsi proprio alla moglie di David: entrambe accomunare dal triste destino di dover amare un uomo che disprezza.
Anche Vittorio Alfieri, nel suo Saul, presenta Mikal in modo fedele alla visione biblica. Nell'opera viene preferito e riportato il nome "Micol".
Onomastica
Il nome "Mikal" (anche nelle versioni "Michal" e "Mical" o, seguendo la pronuncia sefardita, "Micol" o "Mikol"), per quanto si trovi raramente come nome di persona durante la storia ebraica, ha conosciuto una fiorente riscoperta nell'ambito del Sionismo ed è tuttora un nome femminile molto diffuso nell'odierno Israele. Nonostante la totale (o quasi) omografia, i nomi ceco "Michal" e polacco "Michał" non hanno nulla a che fare con la Mikal biblica, ma sono forme derivate dal nome Michele.
Miriam (o
Maria, a seconda di come ogni versione traduce il suo nome) è, nella Bibbia,
la sorella di Mosè e Aronne. È menzionata in sei testi, tra cui
i cinque libri del Pentateuco. Ma il più delle volte la sua figura viene
associata al salvataggio di Mosè bambino (Esodo 2), dove però, benché prenda la
parola, a differenza di molte altre donne, si parla di lei solo come di «sua
sorella», senza identificarla. È una delle poche donne del Pentateuco nominata
in altri passi della Bibbia.
Il racconto
biblico
Miriam era la figlia primogenita di Amram e Iochebed; quando
il faraone egiziano ordinò di uccidere ogni figlio maschio che nasceva agli
israeliti, Iochebed depose suo figlio infante Mosè in una cesta nelle acque del
fiume Nilo per salvarlo, affidandolo alla provvidenza divina.
Miriam, dopo averla accompagnata, seguì il percorso della cesta fino a che non
giunse al palazzo del faraone, dove la figlia del faraone trovò il
piccolo e decise di adottarlo. Uscita allo scoperto, la bambina chiese alla
principessa se avesse voluto una nutrice ebrea per svezzare il
bambino e, avendo questa acconsentito, chiamò sua madre per svolgere quel
compito.
Miriam viene denominata "profetessa" ed è artefice del canto di
un inno che recita assieme alle altre figlie d'Israele quando il popolo
d'Israele attraversa il Mar Rosso e poi le truppe del faraone
vengono annegate nelle sue acque dall'ira di Dio.
«Voglio cantare in onore del Signore: perché ha mirabilmente trionfato, ha
gettato in mare cavallo e cavaliere.»
Questo è considerato come uno dei più antichi componimenti poetici nella
storia ebraica.
In seguito Miriam rimprovera Mosè per il suo matrimonio con una donna madianita, Sefora;
per questo viene punita con la lebbra. Incitato da Aronne, Mosè intercede
presso Dio per la sua guarigione, e Miriam viene risanata dopo sette giorni di
esilio fuori dal campo:
«Miriam dunque rimase isolata fuori dall'accampamento sette giorni; il
popolo non riprese il cammino finché Miriam non fu riammessa
nell'accampamento.»
Il profeta Michea la dipinge come una profetessa di importanza
pari a quella dei due fratelli (Michea 6,4
Cultura
ebraica
Miriam è una figura popolare della cultura ebraica. Alcuni, durante
la Pasqua ebraica, oltre al bicchiere di vino serbato in onore
di Elia, conservano anche un bicchiere d'acqua in onore di Miriam, che
accompagnò il suo popolo nel deserto. Ebrei ortodossi hanno inoltre recuperato
un'antica tradizione secondo la quale, dopo l'agnello e l'uovo, viene inserito
nella cena pasquale anche del pesce. I tre cibi simboleggiano i tre fratelli
Mosè, Aronne e Miriam.
Mizraim è, secondo la Tavola delle Nazioni della Bibbia (Genesi 10: 6; Cronache 1: 8) il secondo figlio di Cam, figlio di Noè, ed è anche il nome ebraico e aramaico per la terra dell'Egitto Mizraim è la doppia forma di matzor, che significa "tumulo" o "fortezza", ed era il nome generalmente dato dagli ebrei alla terra d'Egitto e al suo popolo. Per questa ragione il personaggio biblico è comunemente associato all'Egitto, ed è generalmente identificato come l'antenato biblico degli egiziani.
I figli di Mizraim, secondo Genesi 10, furono Ludim, Anamim, Lehabim, Naphtuhim, Pathrusim, Casluhim (da cui discesero i Filistei) e Caphtorim.
Attestazioni
I testi neo-babilonesi usano il termine Mizraim per l'Egitto. Il nome era, ad esempio, inciso sulla Porta di Ishtar di Babilonia. Le iscrizioni ugaritiche si riferiscono all'Egitto come "Mṣrm", nel 14 ° secolo a.C. Nelle lettere di Amarna l'Egitto è chiamato Misri, e nei registri assiri è chiamato Mu-ṣur. La parola araba classica per Egitto è Miṣr/Miṣru, nome che si riferisce all'Egitto nel Corano, sebbene la parola sia pronunciata come Maṣr in arabo colloquiale egiziano.
Secondo il Chronicon di Eusebio di Cesarea, Manetone aveva suggerito che la grande antichità di cui si vantavano gli egizi aveva effettivamente preceduto il Diluvio e Mizraim vi si stabilì di nuovo dopo il diluvio.
Una storia simile è raccontata da storici islamici medievali, come Sibt ibn al-Jawzi, l'egiziano Ibn 'Abd al-Hakam e i persiani al-Tabari e Muhammad Khwandamir, affermando che le piramidi erano state costruite dalle genti antidiluviane, ma il discendente di Noè Mizraim (Masar o Mesr) fu incaricato di rioccupare la regione in seguito. Le fonti islamiche rendono anche Masar figlio di Bansar o Beisar e nipote di Cam, piuttosto che un figlio diretto di Cam, e aggiungono che visse fino all'età di 700 anni.
Alcuni studiosi ritengono probabile che Mizraim sia una doppia forma della parola Misr che significa "terra", e che fu tradotta letteralmente nell'antico egizio come Ta-Wy (le due terre) dai primi faraoni di Tebe, che in seguito fondarono il Medio Regno.
Tuttavia, secondo Giorgio Sincello, il Libro di Sothis, attribuito a Manetone, identifica Mizraim con il leggendario primo faraone Menes, che si dice avesse unificato l'Antico Regno e costruito Menfi.
David Rohl ha suggerito un'interpretazione diversa: “Tra i seguaci di Meskiaggasher (sovrano sumero) c'era il suo 'fratello' più giovane - a sua volta un leader forte e carismatico. Fu il capo della tribù dei "falchi", i discendenti di Horus il "Lontano".
La Bibbia chiama questo nuovo re degli Egizi "Mizraim", ma questo nome non è in realtà altro che un epiteto. Significa "seguace di Asr" o "Asar" (arabo egiziano m-asr con preposizione egiziana m 'da'). Mizraim è semplicemente m-Izra con il plurale che termina 'im'. Allo stesso modo, un altro grande popolo di lingua semitica - gli Assiri - chiamò il paese dei faraoni "Musri" (m-Usri).
Sodoma, la moglie di Lot viene trasformata in una statua di sale, mentre
Lot e le loro figlie fuggono. Mosaico della Cattedrale di Monreale
La moglie di Lot è
una figura menzionata per la prima volta nella Bibbia, in Genesi 19,26
che descrive come la donna divenne una statua di sale dopo aver guardato Sodoma.
Nella Bibbia non le viene attribuito un nome ma in alcune tradizioni ebraiche
viene chiamata "Ado"
o "Edith". Si fa
riferimento a lei anche nei libri deuterocanonici, nel Libro della
Sapienza (Sapienza 10,7) e nel Nuovo Testamento, in Luca 17,32.
Narrazione
della genesi
La storia della moglie di Lot inizia in Genesi 19 quando al tramonto
due angeli arrivarono a Sodoma e furono invitati a trascorrere la
notte nella casa di Lot. Gli uomini di Sodoma erano estremamente malvagi e
cercarono di portare con loro i due angeli/visitatori ma Lot, invece di
consegnarli, offrì le sue due figlie. Tuttavia, la sua proposta fu rifiutata.
Al sorgere del giorno, gli angeli ospiti di Lot lo esortarono a riunire la
sua famiglia e a fuggire dalla città che sarebbe stata distrutta a causa
dell'iniquità dei suoi abitanti. Gli angeli dissero anche che, durante la fuga,
non avrebbero dovuto guardarsi indietro o fermarsi nella valle; avrebbero
dovuto, invece, raggiungere le montagne per non essere travolti.
Tuttavia, durante la fuga, la moglie di Lot si voltò verso Sodoma e venne
trasformata in una colonna di sale.
Elementi
linguistici
Il verbo ebraico usato per la moglie di Lot che "guarda" indietro
è Il suo guardare indietro verso Sodoma è diverso dal verbo usato per
Abramo che "guarda" verso Sodoma in Genesi 18,16.
Colonna di
sale
La storia sembra essere tratta in parte da una leggenda popolare che spiega
una caratteristica geografica. Una colonna di sale chiamata "moglie
di Lot" si trova vicino al Mar Morto, sul Monte Sodoma in Israele.
La Mishnah stabilisce che la benedizione deve essere pronunciata
nel luogo in cui si trova la colonna di sale. Il termine "moglie di
Lot", per queste peculiarità geografiche, è entrato successivamente nel
linguaggio comune poiché uno degli affioramenti che compongono Long Ya Men è
stato anch'esso denominato così.
Lo storico ebreo Flavio Giuseppe affermò di aver visto il
pilastro di sale che era indicato come la moglie di Lot. L'esistenza della
colonna di sale è anche attestata dai primi Padri della Chiesa, Clemente di Roma e Ireneo.
Commenti ebraici
Nell'ebraismo, una comune interpretazione della trasformazione della moglie
di Lot in statua di sale è che sia stata punita per aver disobbedito
all'avvertimento degli angeli: guardando indietro alle "città
malvagie", ha palesato il suo desiderio segreto di vivere in quelle città.
Per questo è stata considerata indegna di essere salvata.
Un altro punto di vista nell'esegesi ebraica di Genesi 19,26 è che
quando la moglie di Lot si guardò indietro, si trasformò in una colonna di sale
vedendo Dio che scendeva per distruggere Sodoma. Un altro racconto riportato
dalla tradizione è che la donna guardò dietro di sé per vedere se le sue
figlie, sposate con uomini di Sodoma, stessero o meno arrivando.
Un'altra narrazione ebraica narra che la moglie di Lot fu punita con il
sale poiché aveva peccato con il sale. Infatti la notte in cui i due angeli
visitarono Lot, questi chiese alla moglie di preparare un banchetto per loro.
Non avendo sale, la moglie di Lot ne chiese un po' ai suoi vicini. Questa
richiesta li allertò riguardo alla presenza dei loro ospiti dando luogo a
quell'azione che mise in pericolo la famiglia di Lot.
Nel Midrash, il nome della moglie di Lot viene indicato come Ado o Edith.
Prospettiva
islamica
Lut (arabo: nel Corano coincide con Lot della Bibbia ebraica ed è
considerato un messaggero e un profeta di Dio.
Nella narrazione coranica, Lut avvertì il suo popolo dell'imminente
distruzione della città se non avesse cambiato le sue abitudini malvagie, ma il
popolo si rifiutò d'ascoltarlo. Lut ricevette da Allah l'ordine di
fuggire di notte dalla città con i suoi seguaci, ma di lasciare indietro sua
moglie. Non appena Lut partì, Allah fece cadere su di loro una pioggia di
pietre d'argilla.
La differenza tra questo racconto e quello
giudaico-cristiano narrato dal Libro della Genesi è che la moglie di Lut non
fuggì con il marito e fu uccisa insieme ai malvagi: questo perché la moglie di
Lut era colpevole quanto coloro che furono puniti e, infatti, nel Corano viene
menzionata insieme alla moglie di Nuh (Noè); sono entrambe considerate donne
empie e miscredenti che furono punite per la loro malvagità indipendentemente
dal fatto che fossero sposate con dei profeti.
Altri
riferimenti biblici
La moglie di Lot viene citata da Gesù nel Vangelo di Luca (17,
32) nel contesto dell'ammonimento ai discepoli sui tempi difficili del
futuro quando il Figlio dell'uomo tornerà; Gesù disse loro di
ricordare la moglie di Lot ed era un monito a non esitare in quel momento.
Cultura
popolare
La poesia Lot's Wife di Anna
Akhmatova offre un approccio più solidale alla decisione della moglie di
Lot di guardarsi alle spalle. Anche la poesia di Scott Cairns, The Turning of Lot's Wife, rielabora
la storia in una prospettiva femminile. Nel primo capitolo di Mattatoio n.
5 di Kurt Vonnegut, l'autore elogia la moglie di Lot per aver
guardato indietro nonostante sapesse che sarebbe stata annientata; Vonnegut
paragona lo sguardo della donna su Sodoma al suo ricordo del bombardamento
di Dresda.
Racconto biblico
Nella Genesi 39,6-20 si racconta come Putifarre, ricco signore d'Egitto, comprò come schiavo il giovane Giuseppe e che più tardi, vedendone le capacità, pose Giuseppe a carico dell'amministrazione della propria casa. La moglie di Putifarre si invaghì del giovane, cerca di sedurlo, e lui la respinse, perdendo la veste nel tentativo di liberarsi da lei.
Offesa dal rifiuto del giovane, si vendicò accusandolo di fronte al marito di aver tentato di farle violenza, mostrando come prova la veste dello schiavo: per questa calunnia, Giuseppe fu rinchiuso nelle prigioni del Faraone. Qui Dio diffuse su di lui misericordia, facendogli trovare grazia agli occhi del direttore del carcere al punto che costui gli affidò le sue stesse mansioni.
Nella mitologia greca, una vicenda analoga ha per protagonisti Stenebea, moglie del re di Tirinto Preto, e l'eroe Bellerofonte. Si ricordi anche la vicenda di Fedra ed Ippolito.
La donna e la sua vicenda nell’arte
La storia della moglie di Putifarre ha ispirato numerosi artisti in varie epoche. Molti pittori hanno illustrato il momento dell'adescamento della donna e il tentativo di Giuseppe di allontanarsi dalle sue braccia, oppure la scena del racconto artefatto dell'episodio al marito Putifarre. Per citare solo i più famosi possiamo ricordare gli italiani Tintoretto, Guido Reni, Orazio Gentileschi e la figlia Artemisia, l'olandese Rembrandt, lo spagnolo Murillo, il francese Gauguin.
Altri riferimenti religiosi e letterari
* La moglie di Putifarre, il suo tentativo di seduzione, la falsa accusa ed il successivo imprigionamento sono citati anche nel Corano, nella Sūra XII Yûsuf (Giuseppe), ai versetti 23-35.
* Dante Alighieri la collocò all'Inferno tra i falsatori di parola, ovvero i bugiardi: "L'una è la falsa che accusò Giuseppo" (Inf. XXX, 97).
* La passione della donna per Giuseppe è ampiamente trattata, con approfondimenti psicologici e di costume, nei capitoli VI (La toccata) e VII (La fossa) del terzo romanzo Giuseppe in Egitto della tetralogia di Thomas Mann Giuseppe e i suoi fratelli. Nel romanzo la moglie titolare di Putifarre (Potifar il Flabellifero, Camerlengo del Sole e Comandante onorario), figlia del principe Mai-Sach-me e discendente della "nobile stirpe di Mut", è indicata con il nome di Mut-em-enet e i diminutivi di Eni o Enti.
Lo scrittore tedesco ne esalta la bellezza, appena velata da "aria tessuta", con grande efficacia: "Con i seni piccoli e sodi, la fine nuca e il dorso, le delicate spalle, le perfette braccia scultoree, le gambe dalla linea nobilmente affusolata culminanti nel trionfo di muliebrità della fastosa regione delle anche e dei glutei, era, per universale riconoscimento, il più bel corpo di donna che si potesse vedere ...". Mann spiega il tentativo di seduzione della donna con la sua condizione di sposa, ancora "in tenera età" e per convenienze familiari, di un uomo, Potifar, mutilato della sua virilità, per la decisione degli "augusti genitori", Huij e Tuij, che avevano voluto consacrarlo alle divinità per favorirne l'ingresso nella corte di Faraone.
* L'episodio in questione è citato anche nella fiction televisiva Il giovane Montalbano nell'episodio "Ferito a morte", quarta puntata del ciclo trasmesso da Rai 1 nel corso del 2012.