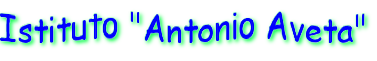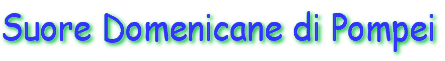Altarini e Cappelle in Santuario
Il Santuario > Pompei tra Cronaca e Storia
*Altarino a: *Altari e Decorazioni *1-San Vincenzo Ferreri *2-Sacro Cuore di Gesù e Santa Margherita Maria Alacoque *3-San Tommaso d'Acquino *4-San Michele Arcangelo *5-Santa Rosa da Lima *6-San Giovanni Battista de la Salle *7-San Pio V - Papa *8-Santa Caterina da Siena *9-La morte di San Giuseppe *10-Sant'Alfonso Maria dei Liguori *11-*San Francesco d'Assisi *12-San Domenico di Guzman


Nell’interno della Basilica si aprono piccole cappelle con altare, pala e catino dove sono riprodotti alcuni misteri del Rosario.
Nella crociera trovano posto, a destra, l’altare dedicato a S. Giuseppe e, a sinistra, a S. Michele Arcangelo, speciali protettori del Santuario.
È da notare che nella Basilica originaria, vi erano solo otto altari, cui furono aggiunti gli altri all’epoca dell’ampliamento.
I dodici altari si susseguono nell’ordine così come riportato nelle foto.
1 – S. Vincenzo Ferreri e le anime del Purgatorio, opera del pittore Ponziano Poverini (1983). Nel catino, in mosaico: l’agonia di Gesù nell’orto del Getsemani.
2 – Sacro Cuore di Gesù mentre appare a S. Maria Margherita Alacoque, opera del pittore Orazi Orazio (1891). Nel catino il mosaico raffigurante la flagellazione di Gesù.
3 – S. Tommaso d’Acquino, dottore angelico, rivestito del cingolo di castità; opera del pittore C. Calmieri (1938).
Nel catino il mosaico raffigurante Gesù coronato di spine.
4 – S. Michele Arcangelo, pala di Ponziano Poverini (1891). Il mosaico in alto al centro, raffigura Gesù che porta la croce.
A destra, Gesù apre il suo manto per accogliere nuove anime.
A sinistra, il sacrificio eroico di P. Reginaldo Giuliani O.P. mentre soccorre un ufficiale ferito durante la guerra italo-etiopica (1936).
La cappella fu realizzata anche grazie al contributo di £. 20.000 dato dal Comitato del Voto Nazionale.
5 – S. Rosa da Lima, opera del pittore Tito Ridolfi (1942).
Il mosaico nel catino raffigura la crocifissione di Gesù sul Calvario, alla presenza della Madonna ed altri discepoli.
6 – S. Giovanni Battista de la Salle , fondatore della Congregazione dei Fratelli delle Scuole Cristiane, educatore della gioventù, opera del pittore Mariani (1939).
Il mosaico nel catino raffigura la risurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo.
7 – S. Pio V e la visione della vittoria di Lepanto, opera del pittore Calmieri.
Il mosaico nel catino raffigura la discesa dello Spirito Santo su Maria Vergine e gli Apostoli riuniti nel Cenacolo.
8 - S. Caterina da Siena raffigurata in estasi mentre riceve le stimmate, opera del pittore Federico Maldarelli (1883).
Nel catino il mosaico della disputa di Gesù tra i dottori nel tempio.
Sotto l’altare una copia della statua di Santa Cecilia di Stefano Maderno.
9 – La morte di S. Giuseppe, pala del pittore Ponziano Poverini (1890).
Nel catino il mosaico raffigurante la presentazione di Gesù al tempio.
A destra un affresco dello sposalizio di Maria Vergine ed a sinistra altro affresco della Sacra Famiglia di Nazaret.
10 – S. Alfonso Maria dei Liguori, dottore della Chiesa, opera del pittore M. Richter (1938).
Nel catino il mosaico che riproduce la scena della nascita di Gesù Cristo nella grotta di Betlemme.
11 – S. Francesco d’Assisi nella grotta della Verna, opera del pittore Ponziano Poverini, (1892).
Nel mosaico del catino si rappresenta la visitazione di Maria Vergine a S. Elisabetta.
12 – S. Domenico di Guzman che risuscita il principe Napoleone Orsini, nipote del card. Stefano di Fossanova, divenuto poi Papa Gregorio IX. Il dipinto è opera del pittore Ponziano Poverini (1892).
Nel mosaico nel catino la scena dell’Annunciazione di Maria Vergine.
Continuando la visita, ripartendo dall’ingresso centrale, si può ammirare nella volta della navata la scena dell’Assunzione di Maria Vergine, affresco di Vincenzo Paliotti (1888).
Più avanti, in un riquadro, lo stemma di Bartolo Longo e quello del vescovo Mons. Antonio Anastasio Rossi, con una data del periodo dell’ampliamento del Santuario A.D. MCMXXXVIII.
Alle pareti i monumenti in bronzo di Bartolo Longo, a sinistra, inaugurato il 5 ottobre 1928, e a destra quello della contessa Marianna de Fusco, inaugurato il 13 febbraio 1930, entrambi opera del prof. Antonio Giuseppe Tonnini.
In basso sono inseriti quattro artistici confessionali ordinati da Bartolo Longo agli ebanista napoletani Vincenzo Truda e Luigi Bellavista. Un anonimo, devoto della Madonna, nel maggio del 1892 donò per quest’opera cento napoleoni d’oro.
Bellissimi lampadari sono appesi agli archi della navata e del presbiterio.
San Vincenzo Ferreri e le anime del Purgatorio, opera del pittore Ponziano Poverini (1983).
Nel catino, in mosaico: l’agonia di Gesù nell’orto del Getsemani.


Sacro Cuore di Gesù mentre appare a Santa Maria Margherita Alacoque, opera del pittore Orazi Orazio (1891). Nel catino il mosaico raffigurante la flagellazione di Gesù.
*L'altare in onore del Sacro Cuore di Gesù nel Santuario di Pompei
Dopo di avere nell'anno 1887 eretto un Trono meraviglioso alla Regina e Madre di Misericordia; dopo avere, nel maggio dell’anno 1890 consacrato un altare al castissimo Sposo di Lei il glorioso Patriarca San Giuseppe Protettore dell'agonia; intendiamo ora edificare un altare ad onore del Cuore sacratissimo di Colui che tanto ha amato gli uomini e che compie quella celeste Trinità terrena, la quale un giorno fu viatrice su questa terra.
L'altare dedicato al SS. Cuore di Gesù nel Santuario di Pompei verrà consacrato il 7 maggio del 1891.
Già abbiamo accettato l'offerta di valorosi artisti che hanno assunto l’incarico di riprodurre sulla tela la soave immagine del Redentore che sulla ombrosa pendice di Paray apparendo alla discepola prediletta del suo Cuore, la B. Margherita, Alacoque, gliene svelò i reconditi tesori e la esortava a propagarne la devozione tra gli uomini. L'altare in onore del Sacro Cuore di Gesù nel Santuario di Pompei. Dopo di avere nell'anno 1887 eretto un Trono meraviglioso alla Regina e Madre di Misericordia; dopo avere, nel maggio dell’anno 1890 consacrato un altare al castissimo Sposo di Lei il glorioso Patriarca San Giuseppe Protettore dell'agonia; intendiamo ora edificare un altare ad onore del Cuore sacratissimo di Colui che tanto ha amato gli uomini e che compie quella celeste Trinità terrena, la quale un giorno fu viatrice su questa terra. L'altare dedicato al SS. Cuore di Gesù nel Santuario di Pompei verrà consacrato ai 7 di maggio del 1891. Abbiamo accettato l'offerta di valorosi artisti che hanno assunto l’incarico di riprodurre sulla tela la soave immagine del Redentore che sulla ombrosa pendice di Paray apparendo alla discepola prediletta del suo Cuore, la B. Margherita, Alacoque, gliene svelò i reconditi tesori e la esortava a propagarne la devozione tra gli uomini.
*Dettagli sulla Cappella del Sacro Cuore e della B. Margherita
La
grande Nave del Tempio ha quattro cappelle, due per ogni lato: una delle due a
sinistra è dedicata al Sacro Cuore di Gesù, e la decorazione della medesima
determinerà quale debba essere il disegno da adottarsi per le altre.
Il
fronte di detta cappella è limitato dal ricchissimo cornicione corintio, che
forma coronamento alla imposta della volta della gran nave, ed ha due magnifici
pilastri in breccia lumachella di Francia, con base attica di marmo bianco, con
zoccolo di nero Isest, e capitello corintio dorato. In
alto, sull'arco d'ingresso, da un rilievo sferico, incorniciato con intagli e
dorature, spicca il busto di S. Bonaventura, il Dottore Serafico Scrittore della
Madonna.
Nei
due vani, fra l'arco e i pilastri, sono due dipinti a fresco dell'artista
Salvatore Cozzolino. Quello a destra rappresentante S. Caterina da Siena nel momento
dello scambio del suo cuore con quello di Gesù, e quello a sinistra mostra la
B. Margherita Alacoque nell'atto che presenta alle sue novizie Salesiane la
prima volta l'effigie del Sacro Cuore. Il fronte interno dell'arco è riccamente ornato di fregi e dorature con grandi rosoni,
partiti in guisa da lasciar liberi due fondati, nei quali dal predetto artista
sono dipinti due angioli in atteggiamento allusivo al Sacro Cuore.
La
volta della cappella, di figura a botte, è ripartita in due quadri nella parte
bassa che fiancheggiano un tondo, il quale occupa la parte centrale. Corrono
attorno ornati delicatissimi e fine dorature. Nel tondo centrale è
rappresentato, a piccole figure, Gesù nell'orto degli ulivi. Il quadro a
destra. Figura San Giovanni, il discepolo prediletto, nell'atto che poggia il capo
sul petto del Signore. L'altro a sinistra esprime Gesù Signore nostro nell'atto
di dividere il pane, in fratione panis, o sia di dare il suo Corpo ai discepoli
sotto le specie eucaristiche. Tali
dipinti sono stati eseguiti dal medesimo Cozzolino
Le
due pareti laterali della cappella sono rivestiti di marmi di lusso a colore,
ripartiti in quadri, così pure la parete in cui si apre l'arco, ma questa è
ancora più ricca. Tutto poi concorre a dare gran maestà alla intera cappella.
Essa ha due porte laterali di comunicazione con la crociera, una a destra e l’altra,
con un passaggio, a sinistra. Gli architravi e gli stipiti sono di breccia
Serrancolino.
Il
quadro, l'Apparizione alla Beata Margherita M. Alacoque, è lavoro dell'egregio
artista Sacerdote Don Orazio Orazi di Camerino. Il quadro, ora che scrivo, non
è ancor giunto.
Esso,
per concetto decorativo, non si discosterà dalla forma di quelli della
Crociera; e la cornice, pur ispirandosi a quelle della crociera stessa, sebbene
di una relativa importanza minore, è per sé medesima ricchissima e degna del
quadro reale che le è destinato.
L'Altare
del Cuore di Gesù e della B. Margherita sostiene anch'esso il necessario
accordo coll'Altare Maggiore e con gli altri della Crociera. Però con
compiacimento dobbiamo rilevare, che questo altare, pur serbando il generale
disegno a degli altri, per la scelta dei marmi ha superato l'aspettativa. Ove
negli altri altari si ammira un vivo risalto di colori, qui invece: si è ottenuta
una gentilezza elegante, senza ricorrere al marmo bianco. Con dei “Campan
chiari” si è costituita la massa dell’intero altare tramezzato da fondi di
ricchi e rari Serrancolini con fasce di una breccia bruna, e colonne di una “Griotta”
molto fine, con basi di bronzo dorato, tutto poggiante su predella
grigia.
Lo
stile corretto delle linee, la scelta del materiale, la inappuntabile esecuzione,
fanno di questo Altare un gioiello del Santuario. Sicché è da prevedere che
allorquando nelle rimanenti cappelle, altari simili verranno allogati, la nave
del Santuario avrà tale compimento artistico, che niente si vedrà essersi omesso
per darle quel carattere che si addiceva alla grande Opera monumentale.
Anche
questo altare è arredato di un parato di candelieri di bronzo dorato, il quale
alla sua volta serba il disegno di quello dell'Altare Maggiore e dei due della
crociera, formante perciò con questi un ordine solo. Tal lavoro di bronzo è
stato
affidato
all'artista Michele Circelli di Napoli.
I
marmi dell'intera cappella, come tutti gli altri che decorano il Santuario, Sono
stati forniti dalla Grande Marmeria de Bagnerès de Bigorre rappresentata da A.
Jammy. Il
concetto del lavoro e la direzione è del
medesimo Architetto Rispoli.
*Pompei e il Sacro Cuore di Gesù, un legame profondo e indissolubile
La lettura di questo testo del Beato Bartolo Longo ci fa capire perché a Pompei sia così profonda la devozione per il Sacro Cuore di Gesù e per Santa Margherita Maria Alacoque. Tutto nasce da eventi prodigiosi, che videro protagonista il Fondatore del Santuario.
Nel 1889 io ero gravemente infermo. Questa volta vedevo non molto lontano il tramonto della mia vita. E perciò volli presso di me il mio confessore, Padre Giuseppe Maria Leone. Venne da Angri l’amato Liguorino. Nella confessione mi parlò così, secco, reciso, con la sua consueta serenità: - Sei disposto ad accettare quello che io ho promesso in tuo nome per ottenere la grazia della tua vita?” – Io lo guardai negli occhi per scrutarne il pensiero. Ma senza esitazione, pronto risposi. – Accetto. – A me dorrebbe assai, - egli continuò – se tu morissi ora, e rimanesse incompiuta l’opera di Dio, il Tempio della Vergine. Mentre questa mattina pregavo per la tua vita dinanzi alla Madonna e al SS. Sacramento, Gesù mi ha fatto udire questa promessa: “Se l’infermo erigerà nel Tempio un altare in onore del mio Cuore, Io gli farò vedere finita la Chiesa di Pompei”. Ho fatto io un voto per te, un voto al Cuore di Gesù.
Tu dunque erigerai un Altare in onore del Cuore di Gesù in questo Santuario di Pompei; ed il Cuore di Gesù ti accrescerà gli anni e la salute per compiere l’Opera di sua Madre in questo luogo. Ecco il voto che ho fatto per te.
A queste parole io rimasi confuso, ma freddo, immobile: un senso di rincrescimento turbò la serenità del mio animo. A dire la verità, non mi sentivo inclinato ad accettare quel voto, perché a me pareva che l’introdurre in un nascente Santuario, non ancora compiuto e neppure consacrato, un culto estraneo al Rosario, per cui avevo speso tante fatiche, avesse potuto in certo modo distogliere e scemare l’ardore che andava di giorno in giorno crescendo per la Vergine del Rosario di Pompei e per il nuovo Santuario che in suo onore e con il suo titolo si edificava. (…) Ma subito mi sopraggiunse il pensiero che innanzi a Dio vale più l’ubbidienza che qualsiasi offerta; e perciò rassegnato, ma risoluto, risposi: - Poiché voi, mio confessore, avete fatto per me questo voto, io lo ratifico, e lo adempirò… ma, a suo tempo.
Indi a poco mi levai di letto. (…) Il solo ricordarlo mi affatica e mi accerta che io vivo per miracolo. E tutto ciò per il voto fatto dal Padre Leone, senza mia saputa, al Cuore di Gesù! Il Divin Redentore aveva dunque gradito quel voto: Egli voleva che il suo Cuore avesse un culto speciale nel Santuario delle grazie della Madre sua in questa Valle del miracolo e della misericordia. Se non che, insieme con il culto al Sacro Cuore la Provvidenza voleva introdotto nel Santuario di Pompei anche il culto a Santa Margherita M. Alacoque. Io non volevo assolutamente saperne; fu necessario che intervenissero Dio e il Papa, Dio con un suo prodigio, il Papa con la sua parola. Di fatto un anno appresso, 1890, il Conte Francesco de Fusco, figlio della Contessa mia consorte, si trovava in fin di vita, consunto per grave infermità. (…). Comincia il mese di Giugno, il mese del Cuore di Gesù.
Si pensò di far una dolce violenza al Divin Cuore per impetrare la sospirata grazia. Io per primo confermai il proposito di compire il voto del P. Leone, con l’erigere senz’altro nel Maggio seguente il promesso Altare al Cuore di Gesù nel Santuario, per aver adesso la grazia della vita del giovane Conte… Fu stabilito d’incominciare la sera di mercoledì, 4 Giugno, una fervorosa Novena al Cuore di Gesù da noi tutti, e dai nostri amici, e ne scrivemmo a monasteri di Napoli, di Roma, di Fabriano, di Arona.
Qui, nel santuario, l’istitutrice delle Orfanelle, la pia fiorentina Sig.na Anna Minucci, insieme con la romana Licinia de Paolis, prendendo viva parte al dolore della Contessa, raccolsero tutte le Orfanelle ai piè dell’Altare della Vergine e cominciarono fin da quella sera 4 Giugno una fervidissima Novena al Cuor di Gesù. Spuntava l’aurora del giorno seguente 5 Giugno, festa del Corpus Domini, quando la Contessa, pare in un torpore di sonno, si sentì d’improvviso inondata da forte consolazione di spirito. Quindi le parve di vedere la dolce figura del Cuore di Gesù che aveva al lato sinistro la S. Margherita Alacoque.
Il Divin Redentore, accennando alla Beata, fece intendere alla Contessa queste parole: - Voglio che sia glorificata la Beata Margherita.
E tutto sparve. La Contessa si desta, invasa da una gioia indescrivibile (…). A me non disse nulla per tema che io la rimproverassi di prestar fede ai sogni: ma difilato corre al Santuario… e tutta commossa e concitata, narra l’accaduto. – Avete qualche preghiera in onore della Beata Margherita? – domandava frettolosamente – La reciteremo noi, la faremo recitare da altri, la diffonderemo a sua gloria.
(…) E dopo due ore le preghiere in onore della Beata Margherita erano diffuse tra quante persone giungevano al Santuario. Immantinente dal Casino La Balme in Torre Annunziata, dov’era degente il Conte, si ebbe notizia che il moribondo era fuori pericolo. Sonavano i Vespri dell’Ottava del Corpus Domini, Vigilia della festa del Cuor di Gesù. (…) In quel momento il Conte si sentì risorto repentinamente a nuova vita … e dopo trenta anni, il Conte viveva ancora, e noi possiamo affermare che la sua mirabile guarigione fu il primo fatto prodigioso con cui il divin Cuore di Gesù voleva glorificata qui, a Valle di Pompei, la Beata Margherita Maria!
Nell’anno seguente 1891 era già costruito l’Altare del Sacro Cuore nel Santuario di Pompei, secondo il voto fatto per me dal P. Leone e da me ratificato e rinnovato; e si era promessa la solenne dedicazione di detto Altare nel Maggio dello stesso anno.
Si doveva dipingere un artistico quadro del Sacro Cuore a cui andava dedicato l’Altare. Eravamo di parere diverso la Contessa mia consorte ed io: io volevo che sull'Altare del Sacro Cuore fosse posto il Cuore di Gesù da solo, secondo il voto da me fatto per mezzo di P. Leone: la Contessa invece, seguendo l’ispirazione avuta nel sogno, voleva che fosse messa anche la Beata Margherita.
(…) Ne parlammo col Cardinale Monaco La Valletta; questi ne riferì al Santo Padre Leone XIII, e il Papa diede la seguente decisione: - Non ci è nulla di male che accanto al Cuore di Gesù sia dipinta anche la Beata Margherita nel Santuario della Valle di Pompei.
Così contro nostro volere, ma per volere divino, il culto di santa Margherita Alacoque entrava nella storia ammirabile e misteriosa della Valle Pompeiana. E così nel 7 Maggio di quell'anno medesimo 1891, per mano dell’Eminentissimo Cardinale Monaco La Valletta veniva consacrato l’Altare e dedicato al Cuore di Gesù e alla Beata Margherita…
(Dagli scritti del Beato Bartolo Longo)
*L'Altare da consacrarsi al Cuore di Gesù ed alla beata Margherita Alacoque
0 fratelli, tre mesi ci separano dal giorno in cui quel Cuore, che tanto amato gli uomini, avrà un trono nel Santuario di Pompei, e con Lui sarà qui glorificata quella eroica rerginella, alla quale Egli rivelò i tesori nascosti della divina carità, la beata Margherita Alacoque.
Il Pontefice Leone XIII, che copre con il suo augusto patronato il Santuario di Pompei, invierà qui l'Em.mo Protettore da lui preposto a tutela di esso, il Principe di Santa Chiesa Raffaele Monaco La Valletta, Decano del Sacro Collegio e Penitenziere Maggiore, a consacrare, il giorno otto maggio del 1891, il Santuario di Pompei. Ed in tale fortunatissima opportunità quel Cardinale che è più da presso al soglio Pontificio, e sovrintende ai più delicati uffici della Chiesa di Gesù Cristo, e che rappresenterà il Papa nella consacrazione del Santuario di Pompei, ha già scelto per sé, tra gli altari da consacrarsi in quel giorno, quello dedicato al Cuore SS. di Gesù ed alla B. Margherita Maria.
Il nostro spirito è fin da oggi rifatto da un'onda di giubilo, pensando a quel fortunatissimo giorno, nel quale, in Valle di Pompei, con la consacrazione del Santuario si compirà a un tempo l’apoteosi del Cuore di Gesù e della beata donzella che, prima, ebbe la sorte d'intendere dalle labbra stesse del Redentore i benefici che si contengono nella divozione verso quel Cuore divino, e ne ebbe la missione di diffonderla a tutta la terra.
Ed è veramente mirabile lo slancio col quale, da ogni parte, i devoti del Cuore di Gesù e della beata Margherita concorrono a procurarne in questo luogo la splendida glorificazione. Dall'elenco degli oblatori, che riferiamo, si avrà qui appresso una bastevole conoscenza.
Ma a noi qui meglio piace osservare, come fin dall'esordire dell'Opera di Pompei, la Vergine benedetta, la cui devozione non converge in sostanza ad altro che alla maggior gloria finale del divin suo Figlio, si degnò operare il primo prodigio nel Piemonte a favore appunto di una Suora Salesiana, Suor Maria Giuseppa di Gesù Donegana, del Monastero di Arona in Piemonte. La quale, appartenendo all'Istituto della Visitazione, fondato da S. Francesco di Sales, è perciò sorella, nello spirito e nella professione religiosa, della beata Margherita Alacoque. Essa, undici anni or sono, giaceva sul letto di morte con l’assistenza a lato; e quando disperava umano rimedio, ebbe per caso tra le mani un nostro libro ove era la Novena della Madonna di Pompei, e la recitò con fede.
Al nono giorno fu vista colei, che tutti spacciavano per morta, discendere da sola in chiesa e farsi la Santa Comunione a, ringraziamento. Ripeté perciò la salvatrice Novena, e venne di persona a compirla qui, nel luogo dei prodigi di Maria. Alla sua Valle di predilezione. Detto il 7 Te Deum con la Sua compagnia, rapidamente fece ritorno alla sua Casa Madre di Arona in Piemonte, ove tuttora vive sana e dedita alle opere faticose del suo Istituto. Del quale prodigio fu, in breve tempo, pieno il Piemonte e la Svizzera: di guisa che da esso queste due regioni attinsero la primitiva fiamma di devozione alla Madonna di Pompei. E di là eziandio procedé che un'altra consorella della beata Margherita, Suor Ignazia Castiglione di Sales, salpando da Venezia per l'America, introducesse nel Nuovo Mondo in tutte le Case del suo Istituto la devozione verso la Madonna di Pompei. Così un'altra consorella della Beata Alacoque divenne apostola del Santuario di Pompei nel Nuovo Mondo.
A questo modo, per arcane vie, la Provvidenza disponeva fin da principio, che per occasione del Santuario di Pompei fosse contraddistinto con un'eletta grazia quell' Istituto, nel quale la Beata Margherita aveva ricevuto dal Cuore di Gesù le sovrane rivelazioni di carità. Il che ci è pegno di altre più splendide grazie e benedizioni per tutti coloro che qui, con ardore di fede, concorrono a glorificare il Cuore di Gesù e la sua prediletta Discepola, la beata Margherita Alacoque.
*Il Sacro Cuore, Pompei e Santa Margherita
Cento anni fa, a Pompei, il 26 giugno del 1900, Luisa Coleschi guariva da una grave malattia per intercessione di Santa Margherita Maria Alacoque, ma tutta la storia del Santuario e del Fondatore è legata intimamente alla devozione al Sacro Cuore di Gesù.
Una grande tela raffigurante il Cuore di Gesù con santa Margherita Maria Alacoque domina il secondo altare a sinistra nella Basilica di Pompei. Gesù, in aspetto maestoso e bello, dominando dense nuvole bianche, regge con la destra il cuore e con la sinistra lo addita alla Santa che gli sta di fronte proiettando su di lei un fascio di luce. Margherita, serena ed umile, in ginocchio è assorta in profonda contemplazione.
Il quadro fu dipinto dal Sac. Orazio Orazi da Camerino, su commissione di Bartolo Longo nel 1891 per sciogliere un voto che per lui aveva fatto il suo santo confessore P. Giuseppe Leone Redentorista.
Narra Bartolo Longo: “… accanto al mio letto (era infermo in pericolo di morte) egli (P. Leone), da parte di Gesù Sacramentato, con parola sicura di quel che diceva, mi promise la vita se io avessi eretto un altare al S. Cuore” (R.N.P.). È da ricordare: nel 1865, anno della conversione dopo l’esperienza dello spiritismo, il 28 giugno, festa del S. Cuore, Bartolo Longo riceve di nuovo l’Eucarestia: “Rifeci la mia Prima Comunione, pentito e rientrato nel seno della Chiesa di Gesù Cristo”.
Egli narra ancora: “Nel giugno 1866… fui spinto a promuovere in Latiano la devozione al Sacro Cuore” …
“Esposi, nella chiesa del Sacramento, l’immagine del S. Cuore davanti alla quale è morto mio padre”.
Da Latiano il balzo a Napoli su suggerimento dell’amico Prof. Vincenzo Pepe: avrebbe potuto diffondere la devozione al S. Cuore incontrando Caterina Volpicelli.
Ripensando al soggiorno presso la santa apostola napoletana, Bartolo Longo scrive: “Ricordi di tenerissima misericordia tra il S. Cuore e un peccatore. Il S. Cuore fu il mezzo e l’occasione della conoscenza mia con la Contessa e della futura opera della Chiesa di Pompei”. Siamo agli inizi. Presto il binomio si consoliderà nell'esperienza di Bartolo Longo: Gesù (S. Cuore) – Maria (Rosario), con l’immensa ricchezza che ne proviene.
Tornando alla malattia di Bartolo Longo nel 1890, ricordiamo, oltre il voto di P. Leone, la visita che durante la convalescenza ebbe dalla Volpicelli. “Ogni giorno, gli disse lei, prego il S. Cuore di Gesù per voi perché voi lavorate per Dio, mentre ci sono molti che lavorano direttamente per Satana, ed io conosco parecchie di queste persone”. Qui gli eventi si intrecciano. Siamo al 1890: il 5 giugno, la Contessa Marianna de Fusco è destinataria di un evento prodigioso. Il figlio Francesco è ammalato gravemente. Da Napoli si trasferisce a Valle di Pompei, quindi a Torre Annunziata. La madre, già vedova, vede che un male ribelle sta per strapparglielo.
Ferita nel cuore, si aggrappa ad una tenue speranza. Ma non può immaginare che un prodigio si prepara per lei. Non sa, come dirà in seguito, se in sogno o in una visione, le è dinanzi Gesù nella classica iconografia del S. Cuore che le mostra la Beata Margherita Maria Alacoque, dicendo: “Voglio che sia glorificata la Beata Margherita”.
La Contessa è invasa da una grande gioia. Contemporaneamente, il figlio Francesco si sente meglio e, qualche giorno dopo, guarisce. Bartolo Longo irrompe da uomo di punta. Bisogna pregare e far pregare perché il Signore glorifichi la Beata Margherita e sviluppa un’autentica crociata, i cui risultati non tarderanno a manifestarsi.
Qualche anno dopo, nel 1896, il 17 ottobre, festa della Beata Margherita, nel secondo Centenario della sua morte, un miracolo sorprende tutti. Sr. Ersilia Cella, malata dal febbraio 1892, con paralisi ad ambedue le gambe e tormentata da cure incredibilmente dolorose, guarisce nel Santuario di Pompei.
Bartolo Longo aveva detto la sera precedente: “Domani è la festa della Beata Margherita Maria Alacoque. Manca un miracolo per essere dichiarata santa. Chi sa, domani che è sabato, la Madonna non voglia glorificare questa eletta serva del Cuore di Gesù nel suo Santuario?”. Anche il Papa Leone XIII, informato dell’evento, fa pervenire a Bartolo Longo ringraziamenti e benedizioni. Ma gli eventi si sviluppano ancora. Siamo al 1900, anno giubilare.
Dimorarono a Valle di Pompei, dal 1884 i coniugi Luisa Agostini da Siena ed Emilio Coleschi da Sansepolcro, con una bambina, Maria Rosaria, nata qui nel 1889.
Dalla nascita di questa piccola, la mamma comincia a deperire lentamente: è la spinite, gravissimo male, per il quale il dott. Raffaele Paterno, direttore dell’Ospedale Civile di Piedimonte d’Alife, uomo di scienza e di fede, si esprime così: “Mi avete fatto vedere un guaio. Preparate il marito alla brutta notizia, è questione di spinite e la moglie se ne va”.
Nel Santuario di Pompei si prega con intenso fervore la glorificazione di Margherita Maria Alacoque. Anche Luisa prega, chiedendo la rassegnazione alla divina volontà. Sabato 23 giugno 1900, dopo la festa del S. Cuore.
In casa Coleschi è ospite un Missionario Francescano, P. Bonaventura Magnanini, che viene dal Cairo. Tutta la famiglia è a pranzo, eccetto Luisa, che rimane nella solita camera, seduta ed immobile.
La piccola Maria Rosaria, quel giorno ha dimenticato di metterle accanto il panierino con gli attrezzi per lavoretti femminili e qualche libro. Luisa, accortasi della dimenticanza, esclama: “Oh, Maria Rosaria che ha fatto! Non mi ha dato nulla, nemmeno il libro di devozioni!”. Non può chiamare perché non ha voce; né vuol dormire per non dover vegliare poi tutta la notte.
D’improvviso, un pensiero, un coraggio tutto nuovo, una decisione: si alza in piedi, le gambe bloccate da oltre un anno, si muovono liberamente. È guarita. Preferisce non recarsi nella sala da pranzo per non impressionare i familiari e il Padre Missionario. Attende.
Dopo qualche istante, la piccola Maria Rosaria le va incontro: “Mamma hai bisogno di qualcosa”? “Sai, Maria Rosaria, che sto bene”?
La bambina l’abbraccia e le dà un bacio, poi: “Non è vero, mamma, tu dici bugie… ti vuoi divertire”.
“Come, tu hai dimenticato di darmi il panierino ed io mi sono alzata e sono andata a pigliarlo”. “Non è vero, il panierino te l’ha dato Maria Grazia” (la donna di servizio). “Ah, tu non ci credi, vuoi sincerarti che dico il vero”? E così dicendo, si alza e comincia a camminare.
Maria Rosaria, in un balzo è già nella sala da pranzo: “Babbo! Babbo! La mamma cammina, la mamma è guarita”!
Miracolo autentico.
Con questo miracolo e con quello che seguì a Milano il 28 ottobre 1903 nella persona della Contessa Antonietta Astorri vedova Paveri, il Santo Padre benedetto XV, in data 17 marzo 1918, decretava: “tuto procedi posse ad solemnem canonozationem”.
Ci fermiamo a questi pochi accenni sulla “preferenza” del S. Cuore nell’iter storico della nuova Pompei. Ma non possiamo tacere almeno due punti salienti di questa storia: l’opera per i Figli e le figlie dei carcerati e il maestoso campanile dedicato appunto al Cuore di Gesù.
Sull’opera per i Figli dei Carcerati ascoltiamo Bartolo Longo: “… mi sento sospinto da una forza nuova e occulta a metter fuori una parola che è pure un desiderio intenso, una fiamma, un voto, che depongo in quel Cuore di bontà sconfinata, e nel cuore dei miei amati fratelli”. E lancia un appello: “Un voto del mio cuore”.
L’opera nascerà e sarà pagina gloriosa nella storia non solo di Pompei me della Chiesa e dell’umanità.
Nulla diciamo del campanile.
Chiunque viene a Pompei se lo trova di fronte maestoso e svettante: un inno fatto di pietra e di bronzo al Cuore di Gesù.
(Autore: Baldassarre Cuomo)
San Tommaso d’Acquino, dottore angelico, rivestito del cingolo di castità; opera del pittore C. Calmieri (1938).
Nel catino il mosaico raffigurante Gesù coronato di spine.


S. Michele, l’Angelo Protettore del Santuario e di tutte le Opere di Pompei
S. Michele Arcangelo, pala di Ponziano Poverini (1891). Il mosaico in alto al centro, raffigura Gesù che porta la croce.
A destra, Gesù apre il suo manto per accogliere nuove anime.
A sinistra, il sacrificio eroico di P. Reginaldo Giuliani O.P. mentre soccorre un ufficiale ferito durante la guerra italo-etiopica (1936).
La cappella fu realizzata anche grazie al contributo di £. 20.000 dato dal Comitato del Voto Nazionale.
Un’artistica opera del Loverini
Al culmine del suo impegno pompeiano emerge in B. Longo la consapevolezza della celeste protezione. Alla consacrazione del Tempio (1891) si aggiunge la dedicazione di un altare a S. Michele.
Nel periodo dell’Aprile del 1891, Bartolo Longo, partecipando a tutti: fedeli e zelatori, sostenitori e devoti il grande disegno programmatico per le solenni cerimonie, affermava: “il culto religioso nella sua più sublime rappresentazione, la civiltà nei suoi ultimi portati del progresso: ecco il titolo più grande, più glorioso nella festa del prossimo maggio in Valle di Pompei. L’Opera Pompeiana, avviatasi a grandi passi alla sua pienezza, dimostra eloquentemente che tra la religione e la civiltà non poteva sussistere dissidio: la fede e la pietà creano e supportano la vera civiltà. “La religione, reintegrando il supporto logico ed ontologico della creatura con il creatore, tramite il culto, crea l’arte, la scienza, la beneficenza” (B.L.).
In dettaglio il programma prevedeva le grandi feste divise in due sezioni che potremmo, definire sacre e profan
Il fastigio del culto
Giovedì, 8 maggio (1891) ore 8. Mattino. La consacrazione del Tempio: L’atto sacrale rappresentava, secondo il concetto di don Bartolo, la sintesi, il traguardo da raggiungere con ogni sforzo, il compendio di un passato di quindici anni, un segnale luminoso ed un sicuro pegno delle grandi speranze dell’avvenire.
La dedicazione di un altare all’Arcangelo San Michele: Singolare Protettore del Santuario e di tutte le Opere di Pompe
L’erezione di un trono al Cuore di Gesù: L’esaltazione, nel perenne ricordo, della pietosa apparizione alla beata Maria Margherita Alacoque.
Giovedì 8 maggio ore 7. Sera. La scienza trova il suo fastigio nella nuova Pompei. Inaugurazione della luce elettrica.
Bartolo Longo, festante ed orgoglioso scrive nel suo periodico: “Fiat lux, sia fatta la luce e la notte sarà illuminata come giorno”.
Nella cronaca della cerimonia leggiamo che il Cardinale Raffaele Monaco La Valletta secondo la previsione del programma pigiò con il pollice un bottone e la luce invase la Valle propagandosi contemporaneamente e con fulminea rapidità dalle sale delle officine tipografiche, all’orfanotrofio, alle sale di lavoro, e di qui, agli asili infantili, alle scuole; illuminò l’osservatorio, la Cupola del Santuario, la Piazza della nuova Pompei, le case operaie, la Posta, la Via Sacra, la Colonna Miliare, la piazza della Stazione e le altre vie adiacenti, già coperte di caseggiati.
L’elenco, non completo, non sembri enfatico o magniloquente; le opere enumerate erano state tutte concepite e realizzate da don Bartolo.
La beneficenza
Altro frutto significante della religione. Citiamo qualche passo più eloquente di B. Longo: “Anche la beneficenza celebrerà i suoi trionfi, o suoi progressi.
Oggi (1891) dopo tre anni, questo Ospizio, asilo di beneficenza, accoglie settantacinque orfanelle. Anche quest’anno esse, faranno la loro esposizione, dove metteranno in mostra i lavori compiuti nel corso dell’inverno ed i dono ricevuti. Tra questi primeggiano i vini che formeranno la prima esposizione enologica di carità a beneficio delle orfanelle inferme”.
La profonda devozione di Bartolo Longo
Bartolo Longo, profondamente devoto a san Michele, in forma solenne, partecipa ai fedeli tutti: “Raccolti nel Santuario della Regina degli Angeli, in questa Valle santificata, daremo onore all’eccelso Arcangelo, il luogotenente di Dio, il difensore della Chiesa Universale. Il singolare custode della regina degli Angeli, colui che ha protetto sempre la erezione del Tempio di Pompei. Lo chiameremo: Singolare custode di questo Santuario di Maria, Difensore di tutte queste opere nostre e Tutelare della Pompei che risorge cristiana sotto la protezione della Regina delle Vittorie” (B.L.).
La radice di tanta devozione a San Michele, in Bartolo Longo, va ricercata, riportandosi più indietro nel tempo, esaminando gli accadimenti verificatisi ai primordi della prestigiosa opera pompeiana. In questi primi anni, il fondatore era impaziente di dare inizio alla edificazione di un altare, anzi si sentiva intimamente incitato da uno stimolo che non gli concedeva né tregua né quiete. Teso con tutto se stesso e con ogni mezzo alla conquista di quel prestigioso traguardo credeva “che il demonio, il quale suole mettere in campo tutte le sue male arti per opporsi all’opera di Dio” (B.L.), non avrebbe potuto vincere l’ardore dell’animo suo, la fermezza dei suoi propositi. Tuttavia, “Per tristi prove assai presto ebbi ad avvedermi quale energia spiegasse Satana per impedire che fosse elevato un Tempio e quale potere esercitasse sulla terra di Pompei dove da secoli aveva avuto incontrastata signoria” (B.L.).
Contro gli assalti del demonio, era necessario, sosteneva Bartolo Longo, opporre un guerriero, un difensore potentissimo che proteggesse la chiesa: per tale primaria necessità, per un efficace protezione si rivolse fiducioso a San Michele, “quel Principe celeste che, come scacciò dal cielo Lucifero, angelo ribelle, son certo, scaccerà Satana da Valle di Pompei” (B.L.).
*L’Altare di S. Michele Arcangelo nel Santuario di Pompei
Veramente ci tardava assai di vedere la glorificazione dell'Arcangelo S. Michele in questo Santuario, in questa Nuova Pompei dove tutto parla di lui, tutto si glorificava del suo nome tutto fu iniziato e compiuto sotto il suo potente patrocinio.
Ma noi dovevamo procedere con ordine, e i primi onori spettavano alla Madre del Re immortale dei secoli, alla gloriosa Regina degli Angeli, che siede a destra del Re ammantata di bisso e di porpora, poi allo sposo celestiale di lei, il soave patriarca S. Giuseppe, ed in terzo luogo a Colui, che essendo vero figliuolo dell'una e reputato figliuolo dell’altra, si mostra in questo Santuario di pace e di misericordia col segnale più sensibile dell'amore qual è il Cuore.
Ora è venuta la volta anche per l'invincibile arcangelo Michele, per l'intrepido guidatore delle milizie celesti, pel tremendo zelatore dell'onore di Dio contro i secolari attacchi di Satana.
Con cuore commosso e confidente ci avviciniamo al grande avvenimento che cingerà una corona di gloria sul capo di colui, che ci fu lume e conforto nelle dolorose vicende che attraversammo per compiere questa Opera provvidenziale, a cui Dio volle chiamarci per fini inaccessibili.
Da quel giorno che levammo gli occhi alla cima del Gauro invocando la protezione del potentissimo Arcangelo di Dio, il soccorso è stato sensibile. Egli per volere di Dio tolse a custodire questa santa cittadella, in cui la Vergine siede per iniziare una nuova guerra contro Satana e rinfervorare i suoi devoti alla mistica pugna contro i nemici della nostra salute.
Il giorno che commemora la miracolosa apparizione dell'Arcangelo sul monte Gargano, vide collocare la prima pietra su cui vennero gettate le fondamenta di questo tempio, il quale per magnificenza di arte e per forma di miracoli suona benedetto e ammirato da un capo all’altro del mondo.
Nel corso successivo di pochi anni che ci separano da quel primo giorno, l’otto maggio è stato sempre inauguratore e auspice di nuove meraviglie.
La festa e il nome dell’Arcangelo delle Puglie s'intrecciava a tutte opere religiose e civili, che operano al presente strepitoso miracolo di una città risorgente a grande avvenire sotto il palladio della religione e della civiltà cristiana.
Il giorno di S. Michele fu battezzata la prima campana che doveva invitare i poveri abitatori di questa Valle alla preghiera quotidiana.
Il giorno di S. Michele fu inaugurata la nuova città con tutti gli elementi di civile progresso e di benintesa beneficenza cristiana.
Nel giorno di S. Michele venne la taumaturga effigie della nostra Regina incoronata, e corteggiata da quindicimila eletti, accorsi d'ogni parte, entrò la prima volta nel suo Tempio, con gli onori di Regina, a prendere il possesso del trono apparecchiatole dalla pietà dei figli suoi. Finalmente il giorno 8 maggio del 1891 il potente Arcangelo riceverà alla sua volta quella gloria e quel trionfo che sarà l'espressione della nostra gratitudine e il principio e l'affidamento di più valida protezione per l'avvenire.
Quando proponemmo di erigere un altare in onore di S. Michele ci trovammo perplessi intorno al luogo da scegliere.
Stavamo in dubbio fra due, se all'altro lato della crociera dirimpetto all’altare di San Giuseppe si dovesse esporre alla venerazione dei fedeli il Sacro Cuore di Gesù, o l'immagine di S. Michele.
Interrogato il Papa su questa convenienza, Sua Santità si degnò di risponderci nel seguente modo: “Il luogo con veniente all'adorazione del Sacro Cuore di Gesù è l'Altare maggiore, dove questo cuore palpita di amore per gli uomini nel corpo Sacramentale del Redentore veramente, realmente, sostanzialmente presente nel tabernacolo. Date il posto d'onore a S. Michele nell'altro altare della crociera.
E cosi sarà fatto!
Fratelli, ravvivate la fede, e aspettatevi dalla potente protezione dell'Arcangelo novella profusione di favori celesti e difesa validissima contro il demonio e gli altri nemici della nostra salute.
Chi vuol concorrere tanto per il sontuoso altare marmoreo di San Michele, quanto per il grandioso quadro a dipingersi, scriva a noi il suo nome, che nel giorno della consacrazione sarà deposto ai piedi di quell'Altare, il quale verrà solennemente consacrato il giorno della Grande Vigilia della festa di maggio, quel giorno che precede la Notte beata nel Santuario di Pompei. (B.L.)
La Cappella e l'Altare di S. Michele nella Crociera
Nell’anno
1891 presentiamo compiuta la Crociera del Tempio col Cappellone del lato
sinistro di essa, da dedicarsi all'Arcangelo S. Michele.
Per
dare una esatta idea di questa parte del Santuario, dobbiamo aver presente il
gran Cappellone a destra. Le esigenze pertanto di una severa arte
architettonica
hanno
imposto un tipo obbligatorio di decorazione al cappellone sinistro, che,
secondo le leggi di euritmia (disposizione armonica
e proporzionale delle varie parti di un’opera d’arte), non doveva
per nulla discordare dall'altro di rincontro.
I
ricchi marmi dei Pirenei ornano del pari le grandi pareti del nuovo cappellone,
nei quali, come in altrettanti specchi di stupenda lucentezza, risaltano quei
mirabili colori, che armonicamente si intrecciano fra loro. E la loro ricchezza
spicca maggiormente ora che si trova compiuta l’intera crociera: l’occhio si
perde in un ricco accordo di marmi variopinti e rari. I grandi pilastri di
lumachelle di Francia scanalati, poggianti su bianche basi di marmo di Carrara
e zoccoli di fino nero d'Isest, sormontati da capitelli corinti, seguono quelli
dei quattro archi maggiori della cupola, ed aumentano quel decoro e lusso tanto
ammirato nella rimanente parte del sacro Tempio.
Le
stupende porte della Crociera, di marmo africano, terminate nell'alto da
sculture decorative, risultano in piena armonia col tutto, e trovano
perfettamente il posto che ad esse era stato dal bel principio destinato.
Vogliamo
anche ricordare, che nella parte centrale di detto braccio di crociera è collocata
una ricca cornice simile all’altra di rimpetto, ove non si è trascurato di
profondere ornamenti e dorature di un effetto incantevole. La parte che serve di
coronamento a detta maestosa cornice è istoriata in rilievo di teste di
cherubini intrecciate in un alloro che scende vagamente nei fianchi della
inquadratura.
L’Altare,
nuovissimo nel suo genere, senza scostarsi dalle regole liturgiche, è degno anch'esso
di ammirazione. L'ardimento nella scelta di colori serbando la severità di
linee, supera l’aspettazione si che ne risulta un insieme artistico e
sommamente devoto. Il tipo è rispondente all'Altare Maggiore per concetto e ripartizione.
Un'ardita breccia rossa sanguigna, denominata “Griotta di Caunes”, ne forma la
orditura principale, spezzandosi bruscamente nei fondati con durissime
stalattiti di una fosforescenza abbagliante, laddove i fondati dei capi-altari
sono arricchiti di una rara breccia chiazzata a molti colori, denominata
Serrancolino. La mensa, di un sol pezzo, è sorretta da due elegantissime
colonne di breccia nero africano, calzate da basi attiche, fregiate in bronzo
dorato come i ricchi capitelli.
Questo
altare è corredato di Custodia, alla quale eziandio si è voluto imprimere un carattere spiccatissimo, uscendo dalle
forme usuali e rispondente al tipo dell'altare. Presenta, nel suo fronte un
proneo architettonico con colonne di stalattiti con basi di bronzo dorato,
sormontate da capitelli di bronzo dorato anch'essi. La trabeazione, mirabile
per esecuzione tutta in breccia rossa, e poggia sulle colonne e sulla, parte
centrale
della custodia, la quale, tutta i in bronzo dorato, s’informa ad un rigoroso
concetto architettonico espresso con grande finezza.
La
predella, col sottostante scalino in marmo grigio dei Pirenei, forma base
all'altare, ed armonizza perfettamente col rimanente.
Il
pavimento, in marmo bianco alternato con altro scuro, offre lo stesso disegno
di quello ove s'incrociano i bracci del Santuario.
A
destra dell'altare è addossata al basamento di un pilastro della crociera la
mensa per deporvi le ampolle, ricca di una tavola di raro marmo giallo di
Siena, e con gran mensola scolpita in marmo bianco di Carrara.
Un
parato di candelieri correda l'altare. I candelieri, come al solito, Sono di
bronzo massiccio dorato, e, per disegno, conformi al tutto a quelli dell’Altare
Maggiore, con la quale, anche per questo capo, si è voluto serbare quell’accordo
che tanto conferisce alla gravità del culto.
Nel
vuoto della gran cornice è allogato il quadro del Professore Ponziano Loverini
di Bergamo. Rappresenta il più gran fatto dell’epopea Angelica: Il momento dopo
la vittoria!
Si
vedrà l’Arcangelo principe che, debellato Lucifero, ascende al trono di esso;
mentre che il superbo, decaduto, spodestato, immerso nella più vergognosa
disperazione, precipita nell'inferno che si apre la prima volta. In quell’istante
gli altri sei Spiriti assistenti al Trono di Dio, cioè Gabriel (Forlezza di
Dio), Raphael (Medicina di Dio), Uriel (Fuoco di Dio), Barachiel (Benedizione
di Dio), Jeuthiel (Lode di Dio), Sealthiel (Orazione di Dio), adoreranno,
inneggianti al Trono di Dio, in fondo al quale appare il Signum magnum rivelato
a S. Giovanni, cioè la Immacolata, la Donna ammantata di sole, coronata di dodici
stelle con sotto ai piedi la luna.
Soggetto
questo, cinto di irte e spinose difficoltà, impossibile quasi a mano umana il
plasmarlo su tela. Eppure noi rendemmo nella nostra mente fin dagli inizi di
questo Santuario, meditando sulla Mistica Città di Dio, ossia sulla Vita della
B. Vergine rivelata alla Ven. Maria d'Agreda, tanto studiata dal più grande
ascetico moderno, l' inglese P. Faber).
E
la calda fantasia del Loverini, e la non comune cognizione che egli ha della
storia ecclesiastica, e l’amore infaticabile all'Arte, ha reso possibile ed
attuabile quel che altri ha reputato strano e superiore alle forze dell'uomo;
ed ha dato splendida vita e movenze ardite al nostro altissimo ed ardito concetto.
Non
si vuole oggi nei quadri il simbolismo. Ma che cosa sono il Convenzionalismo,
il Naturalismo, la Scuola, come aggi dicono, se non parole che non rivelano
altro se non la
ristrettezza
e la limitazione del potere umano? Ora l’Arte, io dico, deve servire alla
pietà, non deve imperare alla pietà.
Non
diciamo più nulla oggi, volendo lasciare libero il giudizio dei visitatori che
accorreranno nel prossimo maggio.
Il
disegno dell'Altare, come la direzione, è dell'Architetto Giovanni Rispoli. I
marmi furono forniti e lavorati dalla Grande Marmeria di Bagnerès de Bigorre
(presso Lourdes) rappresentata dal sig. Alberto Jammy. I bronzi tutti eseguiti
dalla ditta
Alfano.
Le sculture e gli ornati dallo artista Luigi Prezioso: le dorerie da Francesco
Galante.
L’erezione di un altare nel Tempio
Leggiamone la gustosa narrazione di don Bartolo: “Per la decima volta spuntava l’alba degli 8 maggio indorando dei primi raggi del sole il cratere del Vesuvio e la vetta più alta del monte Gauro, che a questo Santuario si eleva di rincontro. Sulla più alta delle tre vette che sormontano quel monte, apparve un dì San Michele arcangelo al vescovo di Castellammare, San Catello, mentre pregava con Sant’Antonino Abate vescovo di Sorrento e chiese loro che in quel luogo innalzassero un tempio in onore del principe degli Angeli” (B.L.)
Fin dal 1872, Bartolo Longo, mettendo piede per la prima volta a Pompei, aveva chiesto notizie per conoscere la storia del monte Gauro e, nell’apprendere che sulla vetta più alta si ergeva un tempio dedicato a S. Michele, “illuminato dalla grazia, avevo disposto al tutto in cuor mio che anche in questa Valle avrei, un dì, innalzato un altare al glorioso S. Michele” (B.L.).
La tela. Lavoro di Ponziano Loverini
Della nutrita corrispondenza intercorsa tra il Maestro e Bartolo Longo, sebbene essenziale per la conoscenza più puntuale del progetto e dell’esecuzione del grande quadro di San Michele, con rincrescimento non ci è consentito, solo per ragioni di spazio, far cenno. Siamo stati invece attratti da uno scritto di Bartolo Longo, tuttora in bozze, del quale furono stampate solo tre pagine, nel periodico dell’anno 1891 e, nonostante se ne annunciasse la continuazione, il seguito non fu più pubblicato. Trascriviamo per tanto qualche passo illuminante per la conoscenza del gusto e della finissima educazione estetica dello scrittore: “... nell’Arcangelo vincitore, che occupa e rischiara del suo dolcissimo splendore il mezzo della tela, convergono e si fondono le due parti estreme del dipinto, tanto diverse nell’atteggiamento delle figure, nella intonazione dei colori, nella distribuzione della luce. In alto gli angeli vittoriosi scintillano e si piegano in una schiera che si dilegua gradatamente; in basso, tra le tenebre fitte, solcate da lampeggiamenti sinistri che prorompono dall’abisso infernale or ora dischiuso, precipitano i ribelli completamente sgominanti. Tra gli uni e gli altri si erge San Michele, che mentre è in stretto rapporto con gli Angeli fedeli perché loro duce, con quelli ribelli perché loro vincitore, con la viva tonalità del suo colorito, acceso qua e là dai riflessi del balenio infernale, rende possibile i8l passaggio dalle tinte dolcissime del coro trionfante a quelle risentite e dure dello sconfitto e della fiammeggiante caligine che lo incalza e gli si addensa intorno […].
Sotto questa figura (San Michele) ed in completo contrasto con essa, si distende orizzontalmente Lucifero, nell’ombra sinistra che gli fanno intorno due ali sterminate di pipistrello. Dove però singolarmente risplende la somma maestria e l’arte squisita del professor Loverini, è nella terribile espressione del volto. La parte inferiore di essa è celata dal manto, quella superiore foscamente adombrata dalla negra capellatura, trae dagli occhi furenti, dalla fronte corrugata l’apparenza della più rabbiosa disperazione che si possa immaginare.
Il volto di Lucifero serba ancora qualche pallida traccia di antica bellezza, ma terribile nell’atteggiamento, truce nella espressione, folgora dagli occhi lampi sinistri che svelano l’ambascia di chi è stato raggiunto da un castigo ignominioso ed eterno […]. In altre parole, nel quadro mirabilmente dipinto dal Loverini, non è riprodotto il concetto della vittoria, perché allora sarebbe stato necessario che Lucifero fosse apparso tra le fiamme dell’inferno e l’Arcangelo tra gli splendori dell’empireo; ma è in quella vece rappresentato solo il primo momento dopo la vittoria, onde sulla tela di cui si parla è colto quell’attimo fuggevole nel quale, mentre il debellato ribelle precipita tra le fiamme dell’abisso, il fedele vincitore rientra tra le angeliche schiere”.
A conclusione, una arguta osservazione comunicataci da P. Buondonno, pompeiano, missionario, indirizzato e sostenuto da Bartolo Longo alla scuola Apostolica dei Monfortani. Il fondatore commissionava il quadro e l’artista, appena abbozzato, lo sottoponeva al benestare del committente a cui rivolgeva l’invito di fare osservazioni o proporre suggerimenti prima che l’esecuzione dell’opera potesse essere definita. Così avvenne anche per la pala da sistemare sull’altare di San Michele.
Bartolo Longo, ricevuto dal Loverini il bozzetto, lo rispedì all’artista con questa osservazione: “Mi piace assai il complesso del quadro: è un vero poema. Però mi permetto di fare un rilievo: Lucifero, sotto i piedi di San Michele, lo ha fatto troppo bello, creda a me che lo conosco personalmente, egli è molto più brutto, occorre tenerne conto nella sua opera”.
(Autore: Nicola Avellino)
Santa Rosa da Lima, opera del pittore Tito Ridolfi (1942).
Il mosaico nel catino raffigura la crocifissione di Gesù sul Calvario, alla presenza della Madonna ed altri discepoli.


San Giovanni Battista de la Salle , fondatore della Congregazione dei Fratelli delle Scuole Cristiane, educatore della gioventù, opera del pittore Mariani (1939).
Il mosaico nel catino raffigura la risurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo.
*Il Quadro dedicato al grande Santo francese - San Giovanni Battista de La Salle
"Il Cardinale Luigi Maglione, Segretario di Stato di Sua Santità Pio XII, il 6 maggio 1939, consacrò solennemente l’Altare maggiore e la nuova Basilica tra l’esultanza e la benedizione del popolo”. Quest’iscrizione, incisa in una lapide marmorea posta alle spalle del Trono della Madonna nel Santuario di Pompei, ricorda una data storica per il tempio mariano, un giorno che, ogni anno, è commemorato con il rito della discesa del Quadro che si svolge a due giorni dalla Supplica dell’8 maggio. Tra l’altro, nel 2019, si è celebrato un anniversario speciale: gli ottant’anni dalla consacrazione del Santuario, ampliato e reso ancora più bello per volontà dell’Arcivescovo Antonio Anastasio Rossi, Prelato di Pompei dal 1928 al 1948.
Tra le opere realizzate nel 1939 e di recente sottoposte a restauro grazie all’aiuto dei benefattori vi è anche la tela dell’artista Aurelio Mariani (1869–1939) che raffigura San Giovanni Battista de La Salle tra i suoi ragazzi. Fu un educatore illuminato, innovatore nel campo della pedagogia e venerato come Santo della Chiesa per aver consacrato la sua vita all’educazione dei bambini poveri e dei ragazzi di strada. Nel 1907, Bartolo Longo chiamò i Fratelli delle scuole Cristiane a dirigere l’Ospizio Educativo per i figli dei carcerati.
*Altarino N° 7 - San Pio V - Papa V
San Pio V e la visione della vittoria di Lepanto, opera del pittore Calmieri.
Il mosaico nel catino raffigura la discesa dello Spirito Santo su Maria Vergine e gli Apostoli riuniti nel Cenacolo.
Il Papa del Rosario
Dal taccuino di un terziario:
illustrazioni sui nuovi dipinti
Voi
ditela come volete; ma in persona di S. Pio V la storia severa ha visto sempre
uno di quei gradi Papi, che la Provvidenza suscita di quando in quando per
vendicare il passato e preparare l’avvenire. E se mi venite fuori con il dirmi
che il Papato, occupandosi di faccende temporali, corre pericolo di
indebolirsi, nel suo organismo e di oscurarsi nel concetto de’ popoli, vi
ringrazierò due volte: una per la sviscerata tenerezza che mostrate sentire per
il papato, ed un’altra per la propizia occasione che mi offrite per
spiattellarvi sul muso, che voi dovete ignorare tondamente come S. Pio V, pure
implicato in tanti e spirituali e temporali negozi, fu tuttavia in tutta l’estensione
del termine altrettanto gran Papa quanto gran re.
Se
non gradite che vel conti io, non isgradirete sicuramente che vel rassegni
l’illustre Conte di Falloux, l’egregio storico di S. Pio V.
“Rimetter
le armi nelle mani del Lavallette, e con i suoi frati cavalieri per ubbidienza
e per onore incatenarlo, per così dire, sui baluardi di Malta come avanguardia
di Europa; farsi presente nelle tempestose Diete della Germania; timoneggiare
il vacillante carattere di Massimiliano; buttarsi in mezzo ai combattimenti fra
cattolici ed ugonotti; esortare Carlo IX alla fermezza e Caterina de’ Medici
alla rettitudine; pacificare la Corsica e rabbonirne i vincitori; sostenere
Maria Stuarda con i suoi consigli e la causa scozzese con i suoi denari; affrontare
imperterrito la potenza inglese intimando ad Elisabetta o di regnar secondo Dio
o di scendere dal treno; moderare o eccitare Filippo II secondo che questo
principi gli sembri o dominato dalla cupidigia o trattenuto dall’interesse; con
il manto della Chiesa tutta coprir l’immensa stesa delle Americhe, sottraendo
quei poveri selvaggi o alla crudeltà dei padroni o all’abbruttimento della
schiavitù; penetrar nelle conventicole de’ Mori e tener desta la sorveglianza
sull’islamismo tuttora persistente nel cuore stesso della cristianità;
combattere nei Paesi Bassi l’eresia nascente, o con il soffio della potente parola
ammorzare la rivolta a Lovanio; riaprire le pratiche presso l’Impero per
rassodare un’opera imperfetta e raddrizzare uno spirito che forvia; correre in
Polonia per domarvi passioni bollenti e calmarvi impazienti dolori; vendicare,
a di lui malgrado, il Borromeo a Milano, e, riluttante l’Impero, coronare a
Firenze un fedele servo della Chiesa; tutti sventare gli artifici della
politica senza mai ricorrere a veruna finzione; vincere le inclinazioni stesse
della natura senza essere neppure una volta caduto in nessuna debolezza; in una
parola far dappertutto prevalere i principi
contro la forza quando questa si acceca, e prestar la propria forza
contro la forza quando questa si acceca, e prestar la propria forza ai principi
quando questi soccombono: è questo l’abbozzo di un gran regno, troppa gloria
sarebbe per qualunque gran Papa; ma è appena mezzo il grand’elogio di S. Pio V.
Nella immensità di tante cure potrebbesi forse obbliare il gran santo; ma è appunto
questo che in lui devesi punto nulla perdere di vista. Mentre il suo nome
correva da un capo all’altro del mondo come protettore dei giusti e terrore dei
malvagi. Roma non era commossa che dalla sua umiltà, dalle sue mortificazioni e
dalle ineffabili tenerezze della sua carità.
L’Europa
ammirava in lui il successore di S. Gregorio VII, e Roma venerava l’imitatore
dei più ferventi cenobiti /Cap. XXI.)”.
Tre
grandi accuse la Riforma gettava in viso al Papato: l’alterazione della
dottrina in materia di fede, il lusso e il nepotismo in materia di costumi, ed
i crescenti progressi dell’islamismo attribuiva all’oblio delle crociate, per
le quali pagavansi tuttora inutili sussidi; ma chi vide Pio V salir la prima
volta gli scalini del soglio pontificio potè ben leggergli in viso che il nuovo
Papa portava già in petto lo schema della gran risposta. Erasi già votato a compiere
tre grandi imprese: salvare la fede, rifare il costume e contro il Turco
ripigliar l’offensiva.
Se
non è questo il vero concetto storico di tutto il non lungo pontificato di S.
Pio V, venga chi vuole a suggerir4mene un altro. (V, Matthieu, Il temp. Dom. de’
Papi ecc. Epoca 2ª, Periodo 2°, Cap. IV, passim.).
Dopo
diciotto anni di lavoro, il Concilio di Trento aveva finito il suo compito,
aveva risposto a tutti i voti de’ cattolici, salvati tutti i diritti, tutte
sciolte le questioni messe in campo dalla Riforma: null’altro mancava fuorché
una sanzione efficace ed una esecuzione vigorosa. Non chiedevasi soltanto che l’aureola
della santità rutilasse sul Capo visibile della Chiesa; ma bisognava che il suo
genio sorvolasse a qualunque timidezza, e che la sua pietà sorpassasse ancora
il suo genio. Paolo III aveva raccolto il Concilio, Pio IV lo aveva terminato;
ad un altro Papa era riservato di propagarne le dottrine e di far sentirne i
benefici. I Padri avevano decretato; ma un Papa doveva eseguire, e questo Papa
fu Pio V.
A
salvare la fede Pio V intese con l’applicazione del Sinodo Tridentino. Ne
diffonde il Catechismo, facendolo tradurre in francese, in tedesco, in polacco,
ed i Vescovi esortando di unire al precetto l’esempio, ed all’esortazione la
pratica. Il Concilio ha ordinato l’istituzione dei Seminari; e Pio V si dà
tutto ad effettuare questo voto, che ha da produrre la rigenerazione del clero
e del popolo. Il Concilio prescrive la residenza; e Pio V ne raccomanda ai
Vescovi il dovere, lor domandando con bella eloquenza se è forse troppo il
condurre con le proprie mani quella Chiesa, che Gesù Cristo ha ricompra con il
proprio sangue. Il Concilio ha interdetto la pluralità dei benefici; e Pio V
colpisce l’abuso, in ciascuna Chiesa mostrando una sposa, e nel titolare
investito lo sposo mistico, di cui Gesù Cristo chiede il cuore e le cure. Il
Concilio ha lasciato al Papa il carico immenso della riforma liturgica; e l’universo
cattolico riceve da Pio V il Messale e il Breviario, non senza savie riserve a
favore delle liturgie più illustri e più antiche. Il Concilio ha regolate le
condizioni severe da imporre alla musica religiosa; e Pio V con l’ispirare
Palestrina fa parere ritornata l’arpa davidica.
Più
ancora con l’austerità del proprio esempio che con la rigidità dei suoi
regolamenti Pio V torna in fiore la santità del costume.
Digiuna
rigoroso e dorme su duro pagliericcio, e Roma sotto gli occhi di lui è già
mutata d’aspetto. Finita la licenza del gioco e il lusso della tavola, si
frequenta i divini uffici, si visitagli ospedali, si ripiglia la pratica dei
sacramenti. E se i nostri finanzieri non sdegnano una lezioncina di scienza
camerale, restino serviti di veder un momento come intendeva Pio V la pubblica
economia.
Ebbe
anch’egli il suo mo’ di vedere in questa, che a ragione fu detta la metafisica
delle scienze sociali; e non degnossi avere la pazienza di aspettare che
venissero a dirgli dei punti i Smith, i Cobden, i Sismondi, i Malchus, i Say.
Come non fosser punto le strettezze della Camera Apostolica, parte assottiglia
e parte sopprime i diritti di entrata ed uscita, le imposte troppo onerose e il
prezzo esorbitante di talune derrate.
Ma
la più tonda roncigliata al nepotismo non meritava sicuramente di venire d’altre
mani, che quelle non fossero di Pio V. Dopo l’abolizione dei Vicariati più di
un Papa aveva dovuto gemere sulle ambizioni ed arrossire dei disordini delle
proprie famiglie; e l’avere tanto largheggiato di terre e castella con i
Borgia, con i Farnesi, con i Carrafa era riuscito alla più tagliente
requisitoria del nepotismo.
Doveva
essere importato ben poco che quei Papi, con il dotar si riccamente i propri
nipoti, sperassero di trovare in quelli più sicuro appoggio e più cordial
difesa alla S. Sede, quando, dopo un cinquantennio di esperienza, illudersi più
oltre non fu lecito più a nessuno. Pio V l’aveva sentito; ma è tutto merito di
S. Pio V l’aver tradotta in legge invariabile della Chiesa la troppa dura
lezione della storia; ed a lui va singolarmente dovuto se la Bolla “Admonet nos”
ha sbarrata per sempre la via a tutte le debolezze purtroppo inseparabili dell’umana
natura.
Ma
dove il genio politico di S. Pio V smagliò di sua luce più bella fu nel colpo
mortale, che portò ai feroci ardiri dell’islamismo.
(Sac. Nicola Borgia)


Santa Caterina da Siena raffigurata in estasi mentre riceve le stimmate, opera del pittore Federico Maldarelli (1883).
Nel catino il mosaico della disputa di Gesù tra i dottori nel tempio.
Sotto l’altare una copia della statua di Santa Cecilia di Stefano Maderno.
La morte di San Giuseppe, pala del pittore Ponziano Poverini (1890).
Nel catino il mosaico raffigurante la presentazione di Gesù al tempio.
A destra un affresco dello sposalizio di Maria Vergine ed a sinistra altro affresco della Sacra Famiglia di Nazareth.
*Cronaca di B.L. del il 22 di Aprile del 1887
Mi gode l’animo in questo punto, rammentarvi, o pii lettori un brano della Storia gloriosa.
L’otto Maggio del 1887 sarà sempre scritto a caratteri indelebili negli Annali di un popolo che risorge in Italia sotto lo scudo della Regina della Vittoria. Rammenterà alle venture generazioni, che in quel giorno la dolce Madre di Misericordia veniva incoronata dai figli suoi, convenuti qui da ogni contrada, con un diadema di preziosissime gemme attestanti i prodigi del suo amore verso degli uomini.
Ed entrava la prima volta la sua venerata Immagine con gli onori di regina per la porta maggiore del Santuario a Lei dedicato; e prendeva in quel giorno il possesso del Trono monumentale apparecchiatole dall'amore dei figli suoi.
Un eminente principe della Chiesa di Gesù Cristo, il Cardinale Raffaele Monaco La Valletta, deputato dal Capo di tutta la Cristianità, il venerando Pontefice Leone XIII, consacrava quel primo Altare dedicato alla Regina delle rose eterne. E mille e mille nomi venivano rinchiusi nel gran Cuore di argento ai piedi di quel Trono, significanti la fede e l’amore di quanti hanno eretto quell’Ara a Maria.
La Regina delle Vittorie adunque siede Madre di clemenza su quel Trono.
Posta in venerazione nel Santuario di Pompei la più Santa tra’ Santi, come la chiamò San Bernardo, conviene oggi mettere in onore accanto a Lei, l’immacolato suo Sposo, il più Santo fra’ Santi, come lo appella la Ven. Maria Agreda, il Patrono della Chiesa universale, il protettore dell’agonia, il glorioso Patriarca S. Giuseppe.
“È impossibile amare Maria senza amare S. Giuseppe, scriveva il P. Huguet. Chi non ama l’uno deve necessariamente non amare guari l’altra. Queste due devozioni si danno mano a vicenda, e ci aiutano a portare a Gesù l’amore che Gli dobbiamo.
“San Bernardo ha detto che: Per Mariam itur ad Jesum. – Per mezzo di Maria si va a Gesù.
“E noi non abbiamo difficoltà a soggiungere: - Per mezzo di Maria si va a Giuseppe, e per mezzo di Giuseppe a Maria, e per l’una e l’altro a Gesù. “Gesù medesimo si conduce a Maria ed a Giuseppe”.
“In una parola, Gesù, Maria e Giuseppe non devono mai essere disgiunti nel nostro amore”.
Noi dunque, o Fratelli e Sorelle associati al Santuario di Pompei, che formiamo la gran famiglia dei prediletti di Maria sulla terra, e vogliamo amare assai Gesù e la divina sua Madre, dobbiamo onorare ed amare di singolarissimo amore il Padre putativo di Gesù, il fido custode di Maria, il capo della più santa Famiglia del mondo.
Dobbiamo innalzargli un Altare nel Santuario di Pompei! Un Altare conveniente allo splendore della Vergine sua Sposa, ed alla magnificenza del Tempio a Lei dedicato.
Il posto di esso deve essere il più degno dopo quello della Immacolata Regina. Gli abbiamo già assegnato il Cappellone a destro della Crociera. Ora, se per l’Altare della Immacolata del Rosario e per l’Assida che lo comprende, abbiamo speso con gioia la somma di lire Duecentomila; per l’Altare e per la Cappella di S. Giuseppe conviene spendere una somma proporzionata, che non sarà minore di lire Cinquantamila, senza il quadro.
Il progetto l’ho già bello ed apparecchiato. È frutto dello studio e del genio dello stesso mio Architetto Signor Giovanni Rispoli.
È dunque nostro disegno di decorare le pareti del Cappellone con quattro ricchi pilastri baccellati di marmo lumachelle dei Pirenei, con i capitelli bianchi e con le rispettive basi di lucido marmo bianco di Carrara, con zoccoli di marmo nero Izest dei Pirenei, in relazione con gli altri già posti in Assida.
Due fascioni di rari marmi a colori e intagliati, fiancheggeranno la ricca cornice di stucco e di oro che racchiuderà l’ampia tela figurante il Santo. La sola cornice è alta 5,00 e larga 3,40.
L’Altare. Serbando il tipo e le linee del Maggiore, sarà ricchissimo per le scelte dei colori e la finezza dei marmi, innestandosi alla fulva “Griotta rossa” la elegante “Stalattite”, la quale presenterà sotto il pulimento scintillanti lamelle.
Il Ciborio ancora sarà monumentale, subordinato sempre a quello dell’Altare Maggiore, ma di una elegante correttezza con marmi scelti e bronzi dorati: bronzi che verranno innestati ancora nei capitelli e nelle basi delle colonne che sorreggeranno l’ampia Mensa, nella Croce e nel Paliotto, ed in altre parti ancora dei Capi-altari e dei gradini.
Sarà completo il Cappellone venendo decorate altresì le due pareti a destra e a sinistra con due magnifici “Portali” di marmo “Bigio Africano”, con controfasce alla mostra e fregio di “Griotta e Rossovivo”, simili detti Portali ad un altro già esistente al vano d’ingresso alla Sacrestia, e con sculture decorative.
Occorrerà ancora finire la faccia interna dell’arcata della Cupola che immette in detto Cappellone: ed a ciò sarà provveduto con un elegante rivestimento di marmo grigio, con basamento e zoccolatura in relazione con i Pilastri.
E per finire, dall’appiombo di detto grande vano arcuato fino a raggiungere l’estremo delle pareti, verrà collocato il ricco pavimento che ricadrà in detta Cappella, e che farà parte dell’intero Pavimento della Chiesa.
Sarebbe nostro vivo desiderio che la consacrazione dell’Altare di S. Giuseppe potesse aver luogo nel dì 8 Maggio del prossimo anno 1890.
*Il Quadro e i Candelieri per l’Altare di S. Giuseppe nel Santuario di Pompei
Fin dal mese di marzo del volgente anno disponemmo di erigere in questo Santuario di Pompei un Altare maestoso, nel Cappellone destro della Crociera, in onore dell’augusto Sposo do Maria Vergine, da dedicarsi alla Morte di San Giuseppe, di quel Santo, cui Pio IX dichiarò protettore della Chiesa Universale, il Capo Patrono delle famiglie cristiane e valido Protettore dell’agonia.
Era conveniente, noi dicevamo, che accanto al Trono di Colei che fu compagna in vita del Santissimo Patriarca; sorgesse un’ara in onore di Lui, che fu difensore e custode della Sposa dello Spirito Santo e dell’Unigenito Figliolo del Padre.
E con maggior ragione, giacché S. Giuseppe fin dall’inizio non solo venne da noi dichiarato Protettore e Patrono di questo Tempio; ma ancora e Padre e Custode dell’Orfanotrofio della Vergine di Pompei, da noi edificato a fianco del monumentale Santuario per accogliervi le orfanelle abbandonate di tutte le città.
E però senz’altro attendere, né aspettare consiglio o incoraggiamenti di sorta. Mettemmo fuori un progetto di uno splendido cappellone da costruirsi in marmi finissimi con un altare sontuoso e proporzionato in bellezza e ricchezza al monumentale Santuario ed altare Maggiore dedicato alla Regina del Rosario. La spesa presuntiva montava la somma di oltre lire cinquantamila. E ciò senza tener conto di un quarto di milione di debiti da noi contratti per completare per il prossimo maggio 1890 tutta la Nave del Santuario, senonché tutta la Crociera e tutto il pavimento marmoreo del Tempio, e innalzati e messi a posto tutti i pilastri di marmo, con le occorrenti pitture, e dorerie, e stucchi, e bassorilievi, ed infine la superba Cantoria, poggiata su colonne di rari marmi d’un solo pezzo, con in Organo monumentale orchestrale, liturgico sinfonico, che sarà una gemma preziosa dell’arte italiana, e che per la perfezione del lavoro e per la dolcezza della melodia e per il progresso dell’arte meccanica sosterrà il paragone dei migliori organi delle più grandi badie.
Quand’ecco il 15 agosto di questo stesso anno si ode per il mondo la voce autorevole del Capo della Chiesa militante, che esorta i fedeli ad invocare in tutto il mese di ottobre, sacro al Rosario, il nome augusto dello sposo di Maria.
Era intenzione del grande Leone XIII di unire insieme la protezione della Madre di Gesù e quella del Padre putativo di Gesù sul popolo cristiano: congiungere insieme il culto del Rosario che rammenta tutte le gioie, i dolori e le glorie di Gesù e di Maria, e il culto di S. Giuseppe, il quale divise con la Madre e con il Figlio le caste gioie della casa di Nazareth, le durezze della povertà e le ansie dell’esilio, ed ora divide in Cielo gli splendori delle loro glorie immortali.
La parola del Papa dunque generò nell’animo nostro un conforto ineffabile, e sospinse tanto oltre la nostra iniziativa, che fermammo senz’altro nel maggio del 1890 aversi a consacrare, solennemente l’Altare di S. Giuseppe nel Santuario di Pompei.
Il lavoro difatti è cominciato e prosegue con febbrile attività. Siamo grati alla grande marmerie de Bagneres de Bigorre della fiducia prestata alla nostra persona, e del novello credito apertoci per altre lire Novantamila di marmi, che già ci ha mandati, e che pagheremo ai tempi. Mancano ora, per potersi eseguire la solenne consacrazione dell’Altare di S. Giuseppe per il prossimo maggio, il gran Quadro rappresentante “la morte del Santo Patriarca”, ed il parato dei Candelieri e degli arredi sacri opportuni.
Del Quadro abbiamo già data all’insigne Professore Ponziano Loverini di Bergamo: e confidiamo che la nostra espettazione nel valore di cotanto artista non sarà delusa. Il Bozzetto è stato da noi scelto ed approvato.
Rappresenterà il Santo Patriarca che muore poggiato a Gesù, nell’atto che Maria, in ginocchio, prega in soave mestizia; ed una schiera di Angeli, prostrati anch’essi, e conformantisi alla mestizia che si legge nel volto del Redentore, loro Re, assistono il morente.
Ed un’altra schiera di Angeli, spiccantesi dal Paradiso, volta a ricevere ed incornare l’anima del Giusto.
Restano a disegnare e commettere i Candelieri per l’Altare di S. Giuseppe.
Ci rivolgiamo ai devoti del S. Patriarca acciocchè abbiamo il merito di concorrere non solo ad erigere l’Altare ad esso dedicato nel Santuario della Vergine di Pompei; ma ancora a compirlo.
Molti zelatori di questo Santuario, devotissimi di S. Giuseppe ci hanno fatto richiesta di fogli o Moduli per raccogliere le firme e le offerte anche di piccolo momento, per compiere il Cappellone del Santo, con tutto quello che occorre alla solenne funzione del prossimo maggio. Chiunque vuol concorrere a compiere l’Altare di S. Giuseppe, scriva il suo nome nel Modulo con una offerta qualsiasi.
Tutti i nomi di coloro che avranno concorso all’erezione della Cappella di S. Giuseppe saranno rinchiusi in un’urna, la quale nel giorno della consacrazione dell’Altare verrà religiosamente fabbricata sotto di esso, quale segnale di filiale abbandono e di viva fiducia nel patrocinio di S. Giuseppe.
Quei nomi racchiusi sotto l’altare indicheranno la speranza che ha ciascuno di noi che nell’estrema ora della vita discenda propizio dal Cielo a nostro conforto il “Santo protettore dell’agonia”. (B.L.)
*Un Artista per Pompei
La collaborazione tra il Loverini e Bartolo Longo iniziò in occasione della costruzione di una Cappella in onore di S. Giuseppe. Al pittore fu commissionata una tela.
La tela era stata commissionata dal Vescovo e dal clero di Bergamo con l’intento di offrirla in dono al Papa Leone XIII nella ricorrenza del suo giubileo sacerdotale (1887). Il dipinto, portato a Roma, riscosse lusinghieri consensi nell’ambito della Curia, meritando così di figurare nell’Esposizione Vaticana del 1888. Bartolo Longo in quella occasione ebbe l’opportunità di ammirare l’opera ricevendone un’impressione profonda. Quel “carattere spirituale e devoto” trasfuso nella figura della Santa, suscitava intensa commozione.
Il Maestro, senza mezzi troppi appariscenti e con lo studio profondo dei particolari, era riuscito ad assurgere ad un felice concetto, esprimendo tutta la santità della scena, piena di dolcezza e di mistico e puro senso di tristezza.
Un artista per il Santuario
Bartolo Longo aveva scoperto finalmente l’artista che desiderava lavorasse per il Santuario a Valle di Pompei.
Risoluto gli spedì una lettera da cui chiari traspaiono i suoi desideri e le sue emozioni: “Al Signor Ponziano Loverini, Pittore. Borgo S. Caterina – Bergamo. Chiarissimo Signore, vidi un suo quadro all’esposizione Vaticana, Santa Grata con Sant’Alessandro e fui invaghito dal suo stile e dalle sue concezioni nell’arte. Dissi tra me: l’opera di questo pittore non deve mancare nel santuario Monumentale di Pompei, che è una mostra dell’arte italiana cristiana moderna di fronte alle vestigia dell’arte pagana antica. Io non ho il bene di conoscerla di persona, né conosco le sue esigenze nei lavori di pittura. Però se ella pensasse, nel suo cuore, come tanti artisti italiani e stranieri hanno inteso un desiderio di visitare quest’opera di religione, di arte e di civiltà che sorge rimpetto all’antica Pompei, sarei ben lieto di comunicarle i miei sentimenti, e, col viso della voce, potremmo accordarci per qualche dipinto, che, usufruendo il lustro di questo Santuario, renderebbe mondiale anche il suo nome. Intanto per farle avere qualche breve ragguaglio di quest’opera che la Provvidenza ha affidato alle mie cure, le mando alcuni quaderni del mio Periodico ed una immagine della nostra Vergine del Rosario. Sono, con profondo ossequio, suo devotissimo Bartolo Longo”.
L’incontro con il pittore Loverini fu provvidenziale; Bartolo Longo aveva piena ed urgente necessità di un artista cristiano a cui poter commettere le pale per gli altari che andava man mano erigendo nel novello Tempio dedicato alla Vergine del Santo Rosario. L’occasione gli si offriva propizia per l’erezione dell’altare di S. Giuseppe.
Non conosciamo, purtroppo, la risposta del Loverini alla lettere così lusinghieri di Bartolo Longo.
Sappiamo, però, che l’Avvocato il 29 maggio del 1889 rinnovò l’invito all'artista con termini veramente affettuosi: “Venite a passare qualche giorno a Pompei, facendomi il più grande dei favori. Resterà a mio conto la spesa per il viaggio e starete con noi in quei giorni come persona di famiglia” (B.L.)
*Il gran quadro del transito di San Giuseppe
Dipinto del Prof. Loverini di Bergamo
A
lettori non saprà male se troppo tardi ci siamo occupati di questo indiscusso
capolavoro di pittura, che abbellisce il Santuario di Pompei. Il Transito di S.
Giuseppe del prof. Loverini, condotto con alto magistero artistico, con la intonazione
larga e solenne della Scuola storica, col movimento drammatico che rende sulla
tela viva
e
palpitante l'azione, afferma splendidamente tre cose a un tempo:
1. una nuova gloria dell'Arte
italiana che trae le sue ispirazioni dall’ideale religioso:
2. un trionfo incontrastato sul
falso indirizzo della nuova Scuola verista:
3. una nuova manifestazione del
nostro principio, cioè di mostrare come la fede potentemente ispiri e fecondi della
sua luce le più sublimi facoltà dello spirito umano.
A
parte qualunque apprezzamento estetico, il quadro del Loverini riceve un altro
pregio dalla difficoltà del soggetto felicemente superato. L’egregio artista
non doveva ritrarre sulla tela un soggetto umano, unilaterale, una di quelle
rappresentazioni in cui il carattere, o, come dicono, l'individualità del lavoro
si rinviene più nella perfezione plastica di una esecuzione accuratissima, che
nella espressione di un ideale qualsiasi. A questo sogliono riuscire anche i
mediocri, perché il risultato dipende, più che dall’ispirazione, da uno studio coscienzioso
di particolari, dalle convenzioni artistiche, da minuziosa leccatura del
disegno e da altri partiti che sono l'unica risorsa dei pittori comuni. Il
Loverini doveva incarnare un soggetto che va annoverato trai più sublimi nella
storia della religione soprannaturale, e che si reputa il più difficoltoso dai
grandi artisti. Come abbiamo notato, la scena non è umana soltanto, ma umana e
sovrumana ad un tempo.
I
personaggi sono tre, e tutti tre offrirono un grado di eccellenza che diventa
ineffabile sotto il punto di vista dei rapporti che li uniscono nel compimento
di una missione altissima. Da una parte l’omo-Dio, dall'altra Maria e Giuseppe.
L'Uomo Dio entra in relazione sensibile con questi due esseri umani col
rapporto domestico
e
giuridico di figlio. Maria, pur riconoscendo la sua inferiorità di natura a
Gesù, è madre, e ne esercita il ministero.
Giuseppe,
uomo santo e caro a Dio, è sposo della Madre di Gesù, e di conseguenza entra
effettivamente ad occupare in questa società domestica l'ufficio di padre. Il
momento in cui questi tre esseri si debbono rappresentare è la morte di
Giuseppe. Dunque la grandezza dell'artista sarà appunto dall'incarnare questo
momento non in
un
simbolo, ma nell'atteggiamento, nella individuazione dei tre personaggi,
chiedendo all'arte tutte le risorse per creare poi attorno a questi personaggi
un ambiente che armonizzi completamente col loro carattere.
Gesù
è Dio, ma è anche uomo, è anche figlio adottivo di Giuseppe. Quale difficolta a
esprimere il dolore su quel volto in cui balena i! raggio della divinità! Quale
difficoltà a far che il dolore non turbi il sublime contemperamento delle due
nature che sono in lui, perché non appaia troppo Uomo a scapito della divinità,
nemmeno troppo Dio a scapito della natura umana.
Maria
è madre affettuosa, è sposa tenerissima. Da una parte è consapevole degli alti
misteri che si vanno compiendo in quella casa, ma sente dall’altra tutto il
dolore, tutto lo strazio della separazione.
Chi
non vede quanto è arduo armonizzare in questo punto il dolore vivamente
sentito, la maestà di Madre di Dio, e la profonda consapevolezza di una
missione che si deve compiere con dignità pari alla sua eccellenza sovrumana?
Ma
non è tutto. La fede lascia intravvedere ancora un barlume di gloria
soprannaturale che irradia sul volto del morente e gli fa presentire il premio
de giusti, anzi fa che di questo premio cominci a godere le primizie in quel
momento che per altri è foriero di
terribili
ambasce e di angosciose perplessità sul destino eterno.
È
riuscito il Loverini a incarnare sulla tela questo sublime momento? Ha saputo
conciliare in rapporto a questo momento, le esigenze di un dolore naturale e
doveroso, con le esigenze di un'altra personalità che Maria e Gesù rivestivano
in presenza del morente Giuseppe? Si scorge dunque nella grande tela del
Loverini la morte e il trionfo visibile di Giuseppe? Agli intendenti la non
ardua sentenza.
Ma
sotto un altro rapporto la tela del Loverini ha un grande e forse raro
privilegio: ti fa meditare; ma non con meditazione artistica, o storica, o
filosofica, ma con profonda pietà cristiana. Questa nota di rado tu incontri in
tutti i quadri dei più grandi maestri moderni.
Tu
ti trovi già nella umile e modesta casetta di Nazaret insieme con quei tre
altissimi ed umili personaggi, ed assisti in realtà alla morte del Giusto.
Bella
nella sua povertà la Casa di Nazaret! Non ricche masserizie, non ornamenti
doviziosi; qua e là sparsi gl'istrumenti del fabbro. Si vedono per terra i
gigli che cedono il posto alle palme del vincitore recate per mano degli Angeli,
ma sta ritto al canto del Vergine patriarca il bastone fiorito. In lontananza
si vede un'ombra
della
Croce, il segnale di contraddizione predetto trent' anni indietro da Simeone
nel Tempio di Gerusalemme, segnale degli eletti, che si vede e regna ovunque
vive Gesù.
Lo
sguardo però di chi guarda è tirato involontariamente a posarsi sugli occhi di
S. Giuseppe.
A
sessanta anni di vita, già logorata dalle fatiche incessanti, dalle privazioni
della povertà, dai rigori della penitenza, dalle infermità sopravvenute, S.
Giuseppe mostra di essere più vecchio di quel che è. Le sue forze sono esaurite
innanzi tempo. Cosi ce lo presenta la Venerabile Maria d'Agreda nella Vita
della Beata Vergine a lei rivelata, ed approvata dalla Chiesa, e cosi ha saputo
presentarcelo il pittore da Bergamo.
II
Santissimo Patriarca posato su quella scranna, sulla quale per tanti anni usava
di concedere brevi riposi al corpo stanco, ove nei sonni interrotti dalle continue
preci richiamava su di sé la pace inalterabile del Signore; reclina il capo
soavemente sul petto dell'Autore della Vita, che fu suo figliuolo adottivo, ed
a lui ubbidiente
e
suddito per il corso di trent'anni. Posa il capo su quel Cuore divino, che è la
sede dell'Amore creativo, il tabernacolo della SS. Trinità; e le pupille tiene
affisse in Lui che è l’arbitro della Vita e della Morte eterna.
Ai
piedi suoi è Maria, la Vergine eletta tra tutte le creature, la Sposa del
Signore, la dolce compagna della sua vita di artigiano. È in ginocchio e prega.
Il volto di Lei, più bello di ogni fattezza Angelica, e oscurato dal dolore: ma
la rassegnazione e la pace di
Quell’anima
immacolata si leggono su quella fronte giammai velata da alcuna ombra di colpa. Il grande Artista, ispirandosi ai libri
rilevati della Mistica Città di Dio, ai libri scritti dal dotto P. Huguet, ed
alle considerazioni scritte dai Santi Padri, segnatamente da S. Bernardo, fa
intravvedere la celeste visione, o estasi che ebbe S. Giuseppe innanzi alla sua
partita.
Il
Cielo si apre allo sguardo del più grande tra i Patriarchi. Gli angeli, discesi
dal cielo in quella povera stanza, vennero a rallegrarlo con la loro presenza,
a consolarlo con i loro cantici, a profumare la sua casa dei più deliziosi odori.
E non deve recar meraviglia alcuna. Si assicura, (scrive il P. Huguet) che nei
giorni che precedettero la morte di S. Giuseppe, turbe di angeli vennero dal
cielo a consolarlo e rallegrarlo coi loro concenti. E la cosa è molto
credibile, poiché se Dio, come attestano autentici racconti delle vite dei
Santi, si è degnato concedere queste celesti consolazioni a gran numero dei
suoi servi, perché le avrebbe egli negate al più fedele dei suoi amici, al
Custode, al Padre adottivo del Verbo incarnato? Si dice che alla morte della
venerabile Isabella, religiosa carmelitana, si sono visti quattro angeli
collocarsi ai quattro angoli del letto, i quali per consolare la malata cantavano,
accompagnando con loro arpa, queste parole di Isaia: Dicite iusto quoniam bene
est: Dite al giusto che la sua felicità è assicurata.
Ma
chi mai più di Giuseppe ha meritato d'udire questo bel cantico? Non è egli
dallo Spirito Santo stesso che egli ha ricevuto il nome di giusto? «Passate
dunque ad un'altra vita, o Giuseppe, gli avranno detto gli angeli; nessuno più
di voi ha il diritto di morire della morte del giusto. Si, la vostra morte sarà
quella del giusto, essendo che renderete lo spirito nelle braccia di Colui ch'è
la Giustizia e la Santità, sul seno di Colui ch'è la Vita. Andate adunque, o
nobile Principe dei Patriarchi, andate a recare la notizia della loro prossima,
redenzione. Noi frattanto tesseremo una corona di gigli allo sposo vergine, una
corona di rose al primo membro perseguitato della Chiesa nascente, una corona di
risplendenti stelle al padre adottivo del Salvatore, a colui che ci sorpassa
tutti in virtù come in dignità. Noi andiamo a preparargli un trono vicino a
quello che sarà occupato dalla Vergine Madre, di lui sposa. Beato Giuseppe, più
grande nel cielo che mai non fu l’antico patriarca alla corte di Faraone, voi sarete
qual primo ministro dell’Altissimo, il dispensatore de suoi tesori, il
protettore della Chiesa, l'avvocato ed il patrimonio di tutti i cristiani».
Tutto
questo ti fa meditare in breve ora il Quadro di Ponziano Loverini.
Non
deve recar meraviglia il vedere gli angeli con le corone, che vanno incontro
all' anima giusta, dovunque sia per andare, o al Paradiso o al Limbo, perché, è
conforme alla tradizione dell'arte cristiana e al rito. Difatti la Chiesa
obbliga i fedeli a festeggiare la morte di S. Giovanni Battista, tuttoché S.
Giovanni morendo non andasse al Paradiso ma al Limbo, giacché morì prima di
Gesù Cristo, Ancora la Chiesa fa una festa apposita dei SS. Innocenti, tre
giorni dopo il Natale, tuttoché i SS. Innocenti morendo non andassero, per
allora al Paradiso, ma al Limbo, perché morirono più di 30 anni prima di
Cristo. Ciò nondimeno nei quadri delle chiese, anche di sommi pennelli
rappresentanti o la morte del Battista o la Strage degli Innocenti, si vedono gli
Angeli che discendono dal cielo recanti palme e corone.
Il
diverso atteggiamento in cui l'artista ha ritratto le due schiere angeliche, incarnano
mirabilmente la duplicità del momento.
Da
una parte sono gli Angeli che pregano atteggiati a mestizia, come specchianti
la mestizia del Redentore loro Capo e Re ivi presente.
Dall'altra
sono gli Angeli recanti la corona al Santo Patriarca, i quali si allungano
interminabilmente in uno sfondo luminoso che fa intravvedere la beatitudine del
seno di Dio. Non diciamo altro: vengano artisti e credenti a vedere questa nuova
opera d'arte, e vedranno che il quadro del Loverini, rappresentante il Transito
di San Giuseppe è di tale eccellenza sotto il punto di vista dell’ispirazione,
che è un nuovo documento di arte cristiana che si riattacca alla gloriosa tradizione
di quei grandi che resero immortali il loro nome nella rappresentazione
plastica de grandi ideali della fede cristiana. (Avv. Bartolo Longo)
*Vigilia della consacrazione dell'Altare di S. Giuseppe
Alle ore 5,30 p. m. si canteranno i primi Vespri solenni dei Santi, le cui Sacre Reliquie saranno depositate sull'Altare di S. Giuseppe.
Le Reliquie che noi abbiamo scelte per la consacrazione dell'Altare di S. Giuseppe, sono quelle degli Apostoli S. Pietro, S. Paolo, S. Giuda Taddeo, della nostra cara Protettrice Vergine e Martire S. Cecilia, e quella del Patriarca S. Giuseppe Sposo di Maria Vergine. Tutta la sera sarà passata in funzioni e preghiere pubbliche per venerare le Reliquie dei nominati Martiri e Santi.
*Consacrazione dell'Altare di San Giuseppe
Viene da Napoli S. Emin. za il Cardinal Guglielmo Sanfelice dei Duchi di Acquavella accompagnato dai Canonici del Duomo, Eddomadari, Seminaristi, e dalla sua Corte, per eseguire la solenne funzione di consacrare l’altare, dedicato all'inclito Patriarca.
Tra le speciali facoltà e prerogative concesse dal S. Padre Leone XIII a S. Emin. za il Card. Monaco La Valletta, Protettore del Santuario di Pompei, quella di consacrarne gli Altari e la Chiesa; ma l'Em.mo Protettore per atto di speciale deferenza verso il Cardinale Arcivescovo di Napoli, inteso il S. Padre, lo invitava por questa funzione a Sua Vece. Il santo Pastore della Chiesa di Napoli accettava di gran cuore che noi stessi avemmo la fortuna di recargli.
Si aggiungeranno il Clero locale e tutti i Sacerdoti e Vescovi che si troveranno in quella fausta occorrenza in Valle di Pompei, i quali insieme col popolo pompeiano e con la larga schiera dei nostri artisti, faranno le più festose accoglienze ed onoranze al Porporato, degno successore di Sant’Aspreno.
La solennissima funzione incomincerà all'arrivo del secondo treno da Napoli, cioè alle 9,30 a. m. Ore 12 m. Benedizione dei nomi degli oblatori che concorsero all'erezione dell'altare di San Giuseppe nel Santuario di Pompei; chiusura dell'urna che li contiene e collocazione della medesima sotto l'altare del Santo Patriarca.
In quel mattino medesimo, immediatamente dopo la consacrazione, verranno celebrate delle Messe al medesimo Altare di S. Giuseppe. Una di esse sarà celebrata con la ricca pianeta donata dall'Arcivescovo di Apamea, dotto filosofo storico vivente, Mons. Antonio Briganti, conforme venne detto nel nostro Periodico. Quell'Altare, dedicato al transito di S. Giuseppe, innanzi che fosse consacrato, fu già dichiarato Privilegiato dal magnanimo Pontefice Leone XIII con Rescritto del 7 marzo 1888. Per il che chiunque celebra la Messa, o l'ascolta all'altare di S. Giuseppe, guadagna l'Indulgenza Plenaria.
*La consacrazione dell'Altare di S. Giuseppe
Il sublime preludio delle feste di maggio fu la soave cerimonia, la quale consacrò l'Altare di quel dolcissimo Patriarca, che nel corso di un anno ebbe dai suoi figliuoli una testimonianza solenne di profonda devozione e di inalterabile fedeltà.
Giorno avventuroso! Tu suggellasti su quell'altare il patto di fortissima unione, il pegno di mutua corrispondenza tra lo Sposo di Maria e i suoi devoti figlioli; tu sciogliesti il voto delle migliaia di anime, il voto solenne di vedere sorgere accanto al trono di Maria, l'Ara del grande Patriarca S. Giuseppe.
Ognuno che concorse generosamente a glorificarlo in questo luogo, oggi, prostrandosi a piedi di quell'altare, sente nascere vivissima la confidenza nella protezione del celeste patrono dell'agonia, si abbandona con filiale tenerezza al patrocinio di Lui, e gli affida fin da ora le ansie segrete dei momenti supremi della vita.
La solenne glorificazione di S. Giuseppe nel tempio augusto ove la sua celeste Sposa raccoglie gli omaggi di tutta la cristianità, manifestò l'inestinguibile amore dei devoti, e fu il meraviglioso inizio delle altre feste annunziate nel programma.
Prima che cominciasse il mistico rito giungevano senza interruzione generosi manipoli di ferventi figliuoli del grande Patriarca. Essi recavano i voti di altre anime che non ebbero modo di venire personalmente a godere da vicino il compimento dei loro voti, a deliziare lo spirito alla Soavità della celeste funzione, ad ammirare la gloria che sfolgorava sulla testa del dolce patrono delle ultime ambasciate della vita. Il quadro nuovissimo collocato sull'altare rapiva a inesplicabile diletto i riguardanti. Contemplavano essi pieni di soave commozione il nostro celeste protettore in atto di spirare l'anima santissima tra i conforti di Gesù e il rassegnato dolore di Maria.
La vigilia del giorno 7, nel pomeriggio, si iniziò la cerimonia religiosa con la processione e venerazione delle Reliquie dei Martiri e dei Santi che dovevano collocarsi sulla mensa del nuovo Altare: il quale, scoperto agli sguardi dei fedeli, folgorava rilucente di marmi finissimi artisticamente lavorati di splendide dorature e di graziosi intagli.
La purezza e semplicità del disegno con la sobria castigatezza di linea e col profilo delicato, classico e di gusto squisitissimo, costituiva un nuovo trionfo dell'arte che abbelliva il trionfo del grande Patriarca.
Le reliquie dell'Altare di S. Giuseppe, come dicemmo, sono quelle dei SS Apostoli Pietro e Paolo, di S. Gennaro Vescovo di Napoli, di S. Cecilia Vergine e Martire patrona della Musica, e quella rarissima del grande Patriarca S. Giuseppe.
Cantati solennemente i vespri, fu data opera a disporre gli apparecchi per la funzione del giorno 7, giorno tanto sospirato da tutti e principalmente da noi, che con ardentissimi voti ne avevamo intravveduto la bellezza e la gloria.
Per la grande cerimonia ci eravamo recati già da tempo ad invitare L’Eminentissimo Cardinale Sanfelice Arcivescovo di Napoli, il quale con quella paterna effusione di cuore e soave amabilità che e lo fanno venerato a tutti, ci aveva promesso che sarebbe intervenuto ad assistere alla glorificazione di S. Giuseppe, consacrandone l'altare. A questo effetto inviò al Santuario il suo cerimoniere maggiore per apparecchiare l’occorrente per la funzione.
Spuntò finalmente il giorno sette. Tutti gli animi erano dolcemente rapiti per la prossima esultanza della festa per la venuta di quel santo Presule napoletano, che doveva con la sua presenza aprire il grandioso programma delle feste di maggio nella Nuova Pompei.
Alle 8,30 del mattino il Cardinale Sanfelice giunse nella nuova Pompei ricevuto da noi a duecento metri dal Santuario; mentre veniva salutato da grida entusiastiche della folla che si era raccolta sul suo passaggio. Gli operai napoletani addetti alle nostre opere improvvisano una grande dimostrazione al loro Pastore, si accalcano attorno alla carrozza, acclamandolo con le più vivaci espressioni di affetto. Si trovavano in nostra compagnia al solenne ricevimento la Giunta Municipale di Torre Annunziata col Vice Sindaco, con le guardie di città e un drappello di carabinieri, le nostre guardie particolari e le guardie municipali di Scafati. Noi, aperto lo sportello e baciata la mano all'Em. Porporato, gli presentammo nella persona dei loro capi e direttori la nostra colonia di operai che popolano presentemente la nascente città, e offrendogli due mazzi di rose gli rivolgemmo queste parole: - Prima che V. Em. ponga piede nel Santuario, si piaccia di gradire le primizie dei fiori di questa terra benedetta, cioè le rose del Roseto della Vergine di Pompei.
Il sacro Presule ci ringraziò visibilmente commosso, tra le acclamazioni di centinaia di operai giunse al Santuario. Qui il Cardinale Sanfelice viene accolto dal clero che lo conduce in processione fino all'altare della Madonna mentre le Orfanelle cantano l'inno del ricevimento, accompagnate dall'Armonium e dall'Arpa suonata magistralmente dalla Signorina Longobardo Saldutti.
Il Cardinale, celebrata la messa bassa pontificale all’altare della Vergine del Rosario, mosse in processione per la consacrazione dell'altare di S. Giuseppe, preceduto dai Seminaristi di Napoli, dai Cantori della Cattedrale, dai Canonici, dai Cerimonieri, dal Maggiordomo. Lo assistevano i due Canonici, Mons. Gennaro Granito Principe di Belmonte, Uditore di Sua Em. ed il Teologo della Metropolitana, L’ill. e Rev. Francesco De Leo. La cerimonia fu solenne e commovente: lo confessarono gli stessi Signori romani, presenti in quel giorno, i quali sono abituati alle grandi funzioni nella città Regina. La più dolce e devota soddisfazione si leggeva sul volto di tutti.
Verso mezzogiorno cominciò la celebrazione delle Messe all’altare di San Giuseppe.
La prima Messa venne celebrata dal costante Zelatore del Santuario di Pompei, l’Ecc. Vescovo di Gallipoli, Mons. Errico Carfagnini 0.C.
In quel mezzo, il Cardinale Sanfelice seduto in trono, ricevette la nostra offerta di rito, congratulandosi con noi dell'opera menata quasi a termine, e confortandoci a proseguire innanzi con la benedizione del Signore.
Il benigno Porporato si degnò poi di visitare le nostre opere, la esposizione dei doni e dei lavori delle nostre Orfanelle, encomiò i lavori tipografici esposti, e benedisse le Orfanelle e tutte le persone che formano la famiglia della Madonna nella Valle di Pompei, le quali erano in fila in due ali al passaggio del Santo Principe della Chiesa napoletana, infine si accomiatò da noi promettendoci che sarebbe ritornato il giorno successivo. Così finì quel mattino memorabile che segnò il principio di nuove meraviglie nel Santuario di Pompei.
In esso ebbero compimento i desideri di tanti fedeli voti alla generosa iniziativa di vedere regnare anche San Giuseppe nella terra di i Pompei. Possa la memoria di questo giorno risvegliarsi nelle ore della morte, e determinare il nostro cuore ad uno slancio fervido verso il soave Patrono dell'agonia; dal quale aspettiamo, in quei momenti, la retribuzione di quanto nella nostra debolezza abbiamo fatto per la sua gloria nella Valle di Maria. La famiglia cristiana, ogni classe della società, e segnatamente l'operaio, guardino da oggi innanzi al Santuario di Pompei, il quale accoglie dentro di sé quella Sacra Famiglia, che è tipo di ogni virtù e meta a tutti i santi desideri dell'anima.
*Prima festa in onore di San Giuseppe - 22-04.1883
Un Artista per Pompei
La collaborazione tra il Loverini e Bartolo Longo iniziò in occasione della costruzione di una Cappella in onore di S. Giuseppe. Al pittore fu commissionata una tela.
La tela era stata commissionata dal Vescovo e dal clero di Bergamo con l’intento di offrirla in dono al Papa Leone XIII nella ricorrenza del suo giubileo sacerdotale (1887). Il dipinto, portato a Roma, riscosse lusinghieri consensi nell'ambito della Curia, meritando così di figurare nell’Esposizione Vaticana del 1888.
Bartolo Longo in quella occasione ebbe l’opportunità di ammirare l’opera ricevendone un’impressione profonda. Quel "carattere spirituale e devoto" trasfuso nella figura della Santa, suscitava intensa commozione.
Il Maestro, senza mezzi troppi appariscenti e con lo studio profondo dei particolari, era riuscito ad assurgere ad un felice concetto, esprimendo tutta la santità della scena, piena di dolcezza e di mistico e puro senso di tristezza.
La tela e l’altare di S. Giuseppe
Il pittore, irretito da un invito così suadente, assicura di essere a Pompei il 24 luglio del 1889.
In quell’incontro Bartolo Longo dovette esporre al Loverini i suoi progetti inerenti i dipinti da sistemare sugli altari e, più di tutto, discussero sicuramente circa la tela rappresentante il transito di San Giuseppe da esporre sull’altare nella grande cappella, a destra della Crociera. Indubbiamente ci fu l’accordo e la commissione, lo apprendiamo da una lettera del Loverini da cui stralciamo: "Bergamo, 7 settembre 1889. Illustrissimo Signor Avvocato, ieri ricevetti la sua gentilissima lettera contenente un vaglia di lire 1.000. A tanta attenzione non posso che ringraziarla immensamente assicurandola che il quadro da lei commessomi: il Transito di S. Giuseppe, convenuto alla somma di lire 5.000, lo consegnerò infallibilmente il 15 aprile 1890".
Il quadro, infatti, spedito puntualmente, giunse per ferrovia, alla stazione di Scafati il 14 aprile 1890; per il trasporto Bartolo Longo pagò 73 lire e 25 centesimi. La grande tela fu sistemata su telaio dal Signor Chiariello "valente costruttore di tele" mentre, "l’artista Pesce, ne ricavò una magnifica fotografia".
Installato il dipinto, rapidamente fu ultimata la magnifica struttura dell’altare e del cappellone. Il 7 maggio, mercoledì del 1890, il Cardinale Guglielmo Sanfelice dei Duchi di Acquavella alle ore 12 benedisse la cappella e consacrò solennemente l’altare.
"Questo altare sebbene non importante quanto quello dell’abside, ne ricorda tuttavia le linee principali ed è degno di osservazioni perché ne risulta un insieme artistico ed altamente religioso.
Un marmo rosso sanguigno (Griotta di Cannes) ne forma l’orditura principale, alternandosi nei fondi con durissime stalattiti di abbagliante fosforescenza.
Nei Capi Altare, invece, i fondi sono di raro marmo multicolore (Serrangolino). Due magnifiche colonnine di marmo nero (breccia africana), calzate da basi attiche con i fregi di bronzo dorato, simili a quelle dei capitelli, sorreggono la mensa che è tutta di un pezzo.
Il Ciborio presenta sul suo fronte un pronato con colonne di stalattiti dalle basi e dai capitelli di bronzo dorato. La trabeazione e la cornice sono di un vivissimo marmo rosso (breccia). La porta e la parte interna del Ciborio sono di bronzo dorato, lavorato con grande finezza. La predella col sottostante scalino (marmo grigio dei Pirenei) forma base all’altare e si accorda perfettamente con esso.
L’altare è fornito di un parato di candelieri di bronzo massiccio dorato, che, sebbene più piccoli, riproducono nel disegno quelli dell’altare maggiore. A destra dell’altare è addossata al basamento di un pilastro la mensola per deporvi le ampolline. Essa è composta da una lastra di raro marmo giallo (giallo di Siena) e di una gran mensola scolpita (marmo bianco di Carrara)" (Bartolo Longo)
Abbiamo ritenuto utile riportare l’antica descrizione dell’altare per fornire elementi convenienti per un paragone storico.
Si ricordi che a seguito dell’ampliamento del Santuario (1934-1939), furono affiancate al primitivo corpo centrale del Tempio le due navate laterali. Durante la costruzione di esse fu inevitabile, per validi motivi tecnici e strutturali, modificare notevolmente la linea architettonica originaria sacrificando, in parte, anche il sontuoso rivestimento marmoreo dei due altari del braccio destro e sinistro della crociera.
Bartolo Longo nel Periodico di luglio del 1890 esultante scrive:
"Il Transito di San Giuseppe del Professore Ponziano Loverini: una nuova gloria dell’arte italiana che trae le sue ispirazioni dall’ideale religioso. L’Artista doveva incarnare un soggetto che va annoverato tra i più sublimi della storia della religione soprannaturale, e che si reputa il più difficoltoso dà grandi artisti.
Come abbiamo notato, la scena non è umana soltanto, ma umana e sovrumana ad un tempo.
I personaggi sono tre, tutti e tre offrono un grado di eccellenza che diventa ineffabile sotto il punto di vista dei rapporti che li uniscono nel compimento di una missione altissima.
Da una parte l’Uomo-Dio, dall’altra Maria e Giuseppe. L’Uomo-Dio entra in relazione sensibile con questi due esseri umani con il rapporto domestico e giuridico di figlio.
Maria, pur riconoscendo la sua inferiorità di natura a Gesù, è madre, e ne esercita il ministero.
Nella morte di San Giuseppe il Loverini, presentando i tre personaggi della scena tradizionale: (il protagonista che sta esalando lo spirito a Dio, la Vergine Santissima e il Divin Figliuolo che assistono), ha saputo con la fantasia variarla in modo nuovo e bello rischiarando la rustica camera del falegname di Nazareth con la luce che viene dal Cielo, e popolando l’aria di angeli lontani, di due che stanno sopra il moribondo con palme e di altri tre inginocchiati al suo fianco destro.
Così, un fatto del tutto conforme alla comune sorte dei mortali, prende carattere ascetico ed entra nei campi del sovrumano, dell’ideale.
(Da: Il Rosario e La Nuova Pompei – Anno 107 – n° 1 – Gennaio/Febbraio 1991)
(Autore: Nicola Avellino)
La tela era stata commissionata dal Vescovo e dal clero di Bergamo con l’intento di offrirla in dono al Papa Leone XIII nella ricorrenza del suo giubileo sacerdotale (1887). Il dipinto, portato a Roma, riscosse lusinghieri consensi nell'ambito della Curia, meritando così di figurare nell’Esposizione Vaticana del 1888.
Bartolo Longo in quella occasione ebbe l’opportunità di ammirare l’opera ricevendone un’impressione profonda. Quel "carattere spirituale e devoto" trasfuso nella figura della Santa, suscitava intensa commozione.
Il Maestro, senza mezzi troppi appariscenti e con lo studio profondo dei particolari, era riuscito ad assurgere ad un felice concetto, esprimendo tutta la santità della scena, piena di dolcezza e di mistico e puro senso di tristezza.
La tela e l’altare di S. Giuseppe
Il pittore, irretito da un invito così suadente, assicura di essere a Pompei il 24 luglio del 1889.
In quell’incontro Bartolo Longo dovette esporre al Loverini i suoi progetti inerenti i dipinti da sistemare sugli altari e, più di tutto, discussero sicuramente circa la tela rappresentante il transito di San Giuseppe da esporre sull’altare nella grande cappella, a destra della Crociera. Indubbiamente ci fu l’accordo e la commissione, lo apprendiamo da una lettera del Loverini da cui stralciamo: "Bergamo, 7 settembre 1889. Illustrissimo Signor Avvocato, ieri ricevetti la sua gentilissima lettera contenente un vaglia di lire 1.000. A tanta attenzione non posso che ringraziarla immensamente assicurandola che il quadro da lei commessomi: il Transito di S. Giuseppe, convenuto alla somma di lire 5.000, lo consegnerò infallibilmente il 15 aprile 1890".
Il quadro, infatti, spedito puntualmente, giunse per ferrovia, alla stazione di Scafati il 14 aprile 1890; per il trasporto Bartolo Longo pagò 73 lire e 25 centesimi. La grande tela fu sistemata su telaio dal Signor Chiariello "valente costruttore di tele" mentre, "l’artista Pesce, ne ricavò una magnifica fotografia".
Installato il dipinto, rapidamente fu ultimata la magnifica struttura dell’altare e del cappellone. Il 7 maggio, mercoledì del 1890, il Cardinale Guglielmo Sanfelice dei Duchi di Acquavella alle ore 12 benedisse la cappella e consacrò solennemente l’altare.
"Questo altare sebbene non importante quanto quello dell’abside, ne ricorda tuttavia le linee principali ed è degno di osservazioni perché ne risulta un insieme artistico ed altamente religioso.
Un marmo rosso sanguigno (Griotta di Cannes) ne forma l’orditura principale, alternandosi nei fondi con durissime stalattiti di abbagliante fosforescenza.
Nei Capi Altare, invece, i fondi sono di raro marmo multicolore (Serrangolino). Due magnifiche colonnine di marmo nero (breccia africana), calzate da basi attiche con i fregi di bronzo dorato, simili a quelle dei capitelli, sorreggono la mensa che è tutta di un pezzo.
Il Ciborio presenta sul suo fronte un pronato con colonne di stalattiti dalle basi e dai capitelli di bronzo dorato. La trabeazione e la cornice sono di un vivissimo marmo rosso (breccia). La porta e la parte interna del Ciborio sono di bronzo dorato, lavorato con grande finezza. La predella col sottostante scalino (marmo grigio dei Pirenei) forma base all’altare e si accorda perfettamente con esso.
L’altare è fornito di un parato di candelieri di bronzo massiccio dorato, che, sebbene più piccoli, riproducono nel disegno quelli dell’altare maggiore. A destra dell’altare è addossata al basamento di un pilastro la mensola per deporvi le ampolline. Essa è composta da una lastra di raro marmo giallo (giallo di Siena) e di una gran mensola scolpita (marmo bianco di Carrara)" (Bartolo Longo)
Abbiamo ritenuto utile riportare l’antica descrizione dell’altare per fornire elementi convenienti per un paragone storico.
Si ricordi che a seguito dell’ampliamento del Santuario (1934-1939), furono affiancate al primitivo corpo centrale del Tempio le due navate laterali. Durante la costruzione di esse fu inevitabile, per validi motivi tecnici e strutturali, modificare notevolmente la linea architettonica originaria sacrificando, in parte, anche il sontuoso rivestimento marmoreo dei due altari del braccio destro e sinistro della crociera.
Bartolo Longo nel Periodico di luglio del 1890 esultante scrive:
"Il Transito di San Giuseppe del Professore Ponziano Loverini: una nuova gloria dell’arte italiana che trae le sue ispirazioni dall’ideale religioso. L’Artista doveva incarnare un soggetto che va annoverato tra i più sublimi della storia della religione soprannaturale, e che si reputa il più difficoltoso dà grandi artisti.
Come abbiamo notato, la scena non è umana soltanto, ma umana e sovrumana ad un tempo.
I personaggi sono tre, tutti e tre offrono un grado di eccellenza che diventa ineffabile sotto il punto di vista dei rapporti che li uniscono nel compimento di una missione altissima.
Da una parte l’Uomo-Dio, dall’altra Maria e Giuseppe. L’Uomo-Dio entra in relazione sensibile con questi due esseri umani con il rapporto domestico e giuridico di figlio.
Maria, pur riconoscendo la sua inferiorità di natura a Gesù, è madre, e ne esercita il ministero.
Nella morte di San Giuseppe il Loverini, presentando i tre personaggi della scena tradizionale: (il protagonista che sta esalando lo spirito a Dio, la Vergine Santissima e il Divin Figliuolo che assistono), ha saputo con la fantasia variarla in modo nuovo e bello rischiarando la rustica camera del falegname di Nazareth con la luce che viene dal Cielo, e popolando l’aria di angeli lontani, di due che stanno sopra il moribondo con palme e di altri tre inginocchiati al suo fianco destro.
Così, un fatto del tutto conforme alla comune sorte dei mortali, prende carattere ascetico ed entra nei campi del sovrumano, dell’ideale.
(Da: Il Rosario e La Nuova Pompei – Anno 107 – n° 1 – Gennaio/Febbraio 1991)
(Autore: Nicola Avellino)
L’opera pompeiana tra cronaca e storia
Interessante, a distanza di tanti anni, costatare come il Beato volle sottolineare il momento di festa cittadina con un generoso atto di carità verso i più poveri.
La prodigiosa Immagine del Rosario resterà esposta nella nuova Chiesa sino alla Domenica 13 del Mese (1). Ed in quella Domenica per la prima volta in Pompei del Novello Santuario di Maria, accorreranno i poveri contadini ad onorare lo Sposo Immacolato dell’Immacolata Madre di Dio, il Patrono della Chiesa Universale (2), il Protettore della Chiesa di Pompei, e della nuova Casa del Rosario, e della buona morte (3), il Patrono della Chiesa Universale. I Contadini faranno la Comunione Generale, e vi sarà solennizzata la Prima Comunione dei fanciulli e delle fanciulle assidui al Catechismo. Ed il chiarissimo Missionario apostolico Sac. D. Francesco Scardaccione di Napoli farà il Colloquio della Comunione Generale ed il fervorino nella Benedizione di Gesù Sacramentato. Precederà la festa un triduo di Prediche, che farà il P. Maestro Fra Alberto Radente (4) dei Predicatori nominato dal Vescovo di Nola a Rettore della nuova Chiesa del Rosario in Pompei. La Festa sarà tutta di beneficenza e tutta a spese di alcune dame Napoletane devotissime del Santo Patriarca. Si darà il vestito ed il pranzo ad un vecchio, ad un fanciullo e ad una donna poveri (5), in onore della triade Terrestre. Si distribuiranno tre vestiti di premio a 3 fanciulli più assidui e più diligenti del catechismo festivo, ed altri 3 abiti alle fanciulle, ed un maritaggio di L. 50 (6). Si darà l’elemosina a 15 poveri in onore dei 15 Misteri. E il giorno vi sarà detto il panegirico, dal chiarissimo Oratore Domenicano P. Lettore F. Vincenzo Guida di Napoli.
Pompei il 22 di Aprile del 1883 – Bartolo Longo
Note
(1) I nostri lettori già sanno; più volte l’abbiamo riportato ed in varie occasioni abbiamo precisato che il Quadro miracoloso della Vergine, nei primordi dell’Opera Pompeiana, fu collocato provvisoriamente e per breve tempo nella vecchia e cadente chiesuola del SS. Salvatore in attesa di essere custodito ed esposto alla venerazione, nella cappella del SS. Rosario ubicato in un piccolo ambiente sulla sinistra per chi entra nell’attuale Santuario. In attesa che si completassero i lavori per la costruzione del grande Tempio e, soprattutto, dell’altare monumentale con il suo trono grandioso, le funzioni si svolgeranno appunto in quella piccola Cappella con naturale disagio per i fedeli, tutti desiderosi di prostrarsi ai piedi della Vergine miracolosa ed implorare da Lei ogni grazia.
Bartolo Longo addirittura fu costretto, specialmente per i pellegrinaggi con numerosi partecipanti, a stabilire un turno di prenotazione al fine di poter consentire a tutti di venerare, anche per breve tempo, più da vicino la Sacra Immagine. In qualche ricorrenza solenne, sempre compatibilmente con lo svolgimento dei lavori, il Quadro veniva trasferito nel Tempio in costruzione e collocato su un altare centrale, provvisorio, contornato da altri cinque altari più piccoli per dare agio ai numerosi sacerdoti di celebrare la Messa ed ai fedeli di raccogliersi in preghiera. Nel 1883, come Bartolo Longo ci testimonia. Il Quadro fu esposto infatti nell’erigendo del Tempio "occupato per metà da anditi; e stuccatori, e marmolai, e pittori, che già intendono a decorare la parte più eccelsa della Chiesa quale è la Cupola, ed i quattro archi maggiori, secondo le regole della buona architettura.
Pertanto i pellegrini entreranno dalla porta maggiore del Tempio, ascolteranno la Messa all’altare a bella posta eretto nel mezzo di esso per venerare l’immagine prodigiosa" (B.L.).
(2) Il Papa Pio IX, con proprio decreto del giorno 8 Dicembre 1870, aveva solennemente dichiarato San Giuseppe Protettore della Chiesa Universale.
(3) Bartolo Longo aveva fondato la Confraternita per gli agonizzanti ed aveva predisposto una speciale schiera di candide orfanelle, chiamate appunto Giuseppine, deputate a recitare particolari fervide preghiere per gli associati moribondi "soccorrendoli in quelle ore angosciose ed estremo bisogno con la prece potentissima dell’innocenza" (B.L.).
Il primo associato alla Confraternita fu proprio Leone XIII che, per felice coincidenza, morì il 20 luglio 1903, il giorno del Transito del Patriarca San Giuseppe da secoli celebrato dalla Chiesa e, per la prima volta, in quell’anno, commemorato e festeggiato nella Basilica di Pompei.
(4) Bartolo Longo profondamente commosso partecipa ai fratelli e alle sorelle del Terz’ordine della Penitenza di San Domenico, la morte del Padre Radente, il loro direttore. "Il nostro dolce, benigno e caritatevole Direttore, padre maestro Fr. Alberto Radente dei Predicatori, il vero sacerdote secondo il cuore di Dio, il degno rappresentante di San Domenico in mezzo a noi suoi figli, il primo Apostolo del Rosario in questa Valle di Pompei, il sottile filosofico, il profondo teologo, l’inarrivabile maestro di spirito, colui che possedette in grado eroico le virtù dell’umiltà, della carità, del disinteresse, della purità, della misericordia, della povertà e della obbedienza religiosa, il tenerissimo amante di Maria, venne a noi rapito da questa terra di esilio il giorno di lunedì 5 di gennaio (1885), nell’ora dei primi vespri dell’Epifania, lasciando noi tutti nel pianto e nell’amarezza… I suoi esempi ed eminenti virtù, le sue massime di una semplice ed insieme alta santità siano vive innanzi agli occhi nostri ed alla nostra mente" (B.L.).
Per inciso si ricordi che la memoria di Padre Radente, in relazione all’Opera Pompeiana, deve restare imperitura e, senza limiti, la riconoscenza. Egli aveva dato alla sua penitente, Suor Maria Concetta De Litala, la vecchia e sdrucita tela della Madonna del Rosario; su indicazione di Padre Radente, Bartolo Longo si recò da quella pia monaca e ne ebbe in dono il quadro che, portato a Valle di Pompei, fu esposto alla venerazione per la prima volta la sera di sabato, 13 Novembre 1875.
(5) Con l’istituzione dell’Ospizio per i figli dei carcerati (1892), la beneficenza ai poveri ed ai fanciulli veniva effettuata da Bartolo Longo in un ambito notevolmente più vasto. La cerimonia del pranzo si svolgeva infatti nel cortile dell’Istituto ed era una offerta simbolica, un piacevole dono fatto dai giovinetti ivi ricoverati, quasi a voler essi offrire un ringraziamento; un ricambio di carità, anzi, una sublime trasformazione: i beneficiati diventavano benefattori. Sul calendario del 1904, Bartolo Longo pubblicò la cerimonia del pranzo offerto il 24 maggio q903 a 100 vecchietti ed ai fanciulli poveri. È una pagina stupenda, la riproduciamo con qualche doloroso taglio.
"Quale caratteristica sfilata! Vecchi e fanciulli indossano abiti puliti, camicie di bucato, e forse in quel mattino avevano curata un poco più attentamente degli altri giorni la personale nettezza. Entravano, uno per volta, sotto il porticato, dove erano ordinate le mense. Tra i vecchi, chi zoppicava, chi poggiavansi su due bastoni; altri trascinavansi innanzi con movenze stentate, altri poggiavansi alla spalla del compagno vicino; qualche infelice, perché cieco, era condotto per mano, i fanciulli, invece, irruppero come un’ondata. Tutti portavano al collo, sospeso con un nastrino, il biglietto di invito fatto a forma di cuore.
Ogni povero aveva innanzi, al proprio posto, il suo tovagliolo, una bottiglia di vino, un mezzo pane bianchissimo, il piatto, il bicchiere e la posata. I Figli dei Carcerati nella loro tenuta di gala si affaccendavano intorno alle tavole; e dalle sale, che mettevano capo nella grande cucina dell’Ospizio, sino alle mense era una processione di fumiganti tondini pieni di saporose e odorose vivande.
Interessante, a distanza di tanti anni, costatare come il Beato volle sottolineare il momento di festa cittadina con un generoso atto di carità verso i più poveri.
La prodigiosa Immagine del Rosario resterà esposta nella nuova Chiesa sino alla Domenica 13 del Mese (1). Ed in quella Domenica per la prima volta in Pompei del Novello Santuario di Maria, accorreranno i poveri contadini ad onorare lo Sposo Immacolato dell’Immacolata Madre di Dio, il Patrono della Chiesa Universale (2), il Protettore della Chiesa di Pompei, e della nuova Casa del Rosario, e della buona morte (3), il Patrono della Chiesa Universale. I Contadini faranno la Comunione Generale, e vi sarà solennizzata la Prima Comunione dei fanciulli e delle fanciulle assidui al Catechismo. Ed il chiarissimo Missionario apostolico Sac. D. Francesco Scardaccione di Napoli farà il Colloquio della Comunione Generale ed il fervorino nella Benedizione di Gesù Sacramentato. Precederà la festa un triduo di Prediche, che farà il P. Maestro Fra Alberto Radente (4) dei Predicatori nominato dal Vescovo di Nola a Rettore della nuova Chiesa del Rosario in Pompei. La Festa sarà tutta di beneficenza e tutta a spese di alcune dame Napoletane devotissime del Santo Patriarca. Si darà il vestito ed il pranzo ad un vecchio, ad un fanciullo e ad una donna poveri (5), in onore della triade Terrestre. Si distribuiranno tre vestiti di premio a 3 fanciulli più assidui e più diligenti del catechismo festivo, ed altri 3 abiti alle fanciulle, ed un maritaggio di L. 50 (6). Si darà l’elemosina a 15 poveri in onore dei 15 Misteri. E il giorno vi sarà detto il panegirico, dal chiarissimo Oratore Domenicano P. Lettore F. Vincenzo Guida di Napoli.
Pompei il 22 di Aprile del 1883 – Bartolo Longo
Note
(1) I nostri lettori già sanno; più volte l’abbiamo riportato ed in varie occasioni abbiamo precisato che il Quadro miracoloso della Vergine, nei primordi dell’Opera Pompeiana, fu collocato provvisoriamente e per breve tempo nella vecchia e cadente chiesuola del SS. Salvatore in attesa di essere custodito ed esposto alla venerazione, nella cappella del SS. Rosario ubicato in un piccolo ambiente sulla sinistra per chi entra nell’attuale Santuario. In attesa che si completassero i lavori per la costruzione del grande Tempio e, soprattutto, dell’altare monumentale con il suo trono grandioso, le funzioni si svolgeranno appunto in quella piccola Cappella con naturale disagio per i fedeli, tutti desiderosi di prostrarsi ai piedi della Vergine miracolosa ed implorare da Lei ogni grazia.
Bartolo Longo addirittura fu costretto, specialmente per i pellegrinaggi con numerosi partecipanti, a stabilire un turno di prenotazione al fine di poter consentire a tutti di venerare, anche per breve tempo, più da vicino la Sacra Immagine. In qualche ricorrenza solenne, sempre compatibilmente con lo svolgimento dei lavori, il Quadro veniva trasferito nel Tempio in costruzione e collocato su un altare centrale, provvisorio, contornato da altri cinque altari più piccoli per dare agio ai numerosi sacerdoti di celebrare la Messa ed ai fedeli di raccogliersi in preghiera. Nel 1883, come Bartolo Longo ci testimonia. Il Quadro fu esposto infatti nell’erigendo del Tempio "occupato per metà da anditi; e stuccatori, e marmolai, e pittori, che già intendono a decorare la parte più eccelsa della Chiesa quale è la Cupola, ed i quattro archi maggiori, secondo le regole della buona architettura.
Pertanto i pellegrini entreranno dalla porta maggiore del Tempio, ascolteranno la Messa all’altare a bella posta eretto nel mezzo di esso per venerare l’immagine prodigiosa" (B.L.).
(2) Il Papa Pio IX, con proprio decreto del giorno 8 Dicembre 1870, aveva solennemente dichiarato San Giuseppe Protettore della Chiesa Universale.
(3) Bartolo Longo aveva fondato la Confraternita per gli agonizzanti ed aveva predisposto una speciale schiera di candide orfanelle, chiamate appunto Giuseppine, deputate a recitare particolari fervide preghiere per gli associati moribondi "soccorrendoli in quelle ore angosciose ed estremo bisogno con la prece potentissima dell’innocenza" (B.L.).
Il primo associato alla Confraternita fu proprio Leone XIII che, per felice coincidenza, morì il 20 luglio 1903, il giorno del Transito del Patriarca San Giuseppe da secoli celebrato dalla Chiesa e, per la prima volta, in quell’anno, commemorato e festeggiato nella Basilica di Pompei.
(4) Bartolo Longo profondamente commosso partecipa ai fratelli e alle sorelle del Terz’ordine della Penitenza di San Domenico, la morte del Padre Radente, il loro direttore. "Il nostro dolce, benigno e caritatevole Direttore, padre maestro Fr. Alberto Radente dei Predicatori, il vero sacerdote secondo il cuore di Dio, il degno rappresentante di San Domenico in mezzo a noi suoi figli, il primo Apostolo del Rosario in questa Valle di Pompei, il sottile filosofico, il profondo teologo, l’inarrivabile maestro di spirito, colui che possedette in grado eroico le virtù dell’umiltà, della carità, del disinteresse, della purità, della misericordia, della povertà e della obbedienza religiosa, il tenerissimo amante di Maria, venne a noi rapito da questa terra di esilio il giorno di lunedì 5 di gennaio (1885), nell’ora dei primi vespri dell’Epifania, lasciando noi tutti nel pianto e nell’amarezza… I suoi esempi ed eminenti virtù, le sue massime di una semplice ed insieme alta santità siano vive innanzi agli occhi nostri ed alla nostra mente" (B.L.).
Per inciso si ricordi che la memoria di Padre Radente, in relazione all’Opera Pompeiana, deve restare imperitura e, senza limiti, la riconoscenza. Egli aveva dato alla sua penitente, Suor Maria Concetta De Litala, la vecchia e sdrucita tela della Madonna del Rosario; su indicazione di Padre Radente, Bartolo Longo si recò da quella pia monaca e ne ebbe in dono il quadro che, portato a Valle di Pompei, fu esposto alla venerazione per la prima volta la sera di sabato, 13 Novembre 1875.
(5) Con l’istituzione dell’Ospizio per i figli dei carcerati (1892), la beneficenza ai poveri ed ai fanciulli veniva effettuata da Bartolo Longo in un ambito notevolmente più vasto. La cerimonia del pranzo si svolgeva infatti nel cortile dell’Istituto ed era una offerta simbolica, un piacevole dono fatto dai giovinetti ivi ricoverati, quasi a voler essi offrire un ringraziamento; un ricambio di carità, anzi, una sublime trasformazione: i beneficiati diventavano benefattori. Sul calendario del 1904, Bartolo Longo pubblicò la cerimonia del pranzo offerto il 24 maggio q903 a 100 vecchietti ed ai fanciulli poveri. È una pagina stupenda, la riproduciamo con qualche doloroso taglio.
"Quale caratteristica sfilata! Vecchi e fanciulli indossano abiti puliti, camicie di bucato, e forse in quel mattino avevano curata un poco più attentamente degli altri giorni la personale nettezza. Entravano, uno per volta, sotto il porticato, dove erano ordinate le mense. Tra i vecchi, chi zoppicava, chi poggiavansi su due bastoni; altri trascinavansi innanzi con movenze stentate, altri poggiavansi alla spalla del compagno vicino; qualche infelice, perché cieco, era condotto per mano, i fanciulli, invece, irruppero come un’ondata. Tutti portavano al collo, sospeso con un nastrino, il biglietto di invito fatto a forma di cuore.
Ogni povero aveva innanzi, al proprio posto, il suo tovagliolo, una bottiglia di vino, un mezzo pane bianchissimo, il piatto, il bicchiere e la posata. I Figli dei Carcerati nella loro tenuta di gala si affaccendavano intorno alle tavole; e dalle sale, che mettevano capo nella grande cucina dell’Ospizio, sino alle mense era una processione di fumiganti tondini pieni di saporose e odorose vivande.
Era grazioso vedere i fanciulli poveri che sgranavano tanto d’occhi all'arrivo di una grossa porzione di carne. I vecchi guardavano di preferenza le bottiglie, e vi fu pure chi cedette qualche pietanza in cambio del vino, al compagno. Ma la festa raggiunse il massimo brio, quando comparvero delle grosse torte dolci. I Fanciulli invitati, con gioia infantile, applaudirono, seguendo con gli occhi ogni porzione che veniva staccata dal piatto comune e servita per turno. Negli occhi dei vecchi tremolavano lacrime di riconoscenza, i monelli vociando e ridendo erano soddisfatti delle ore passate in tavola. Come ricordo della bella Festa furono donati ai centro poverelli i piatti, la posata, il bicchiere, la tovaglia e il tovagliolo che avevano usati per il pranzo".
(6) Maritaggio: istituto giuridico consistente nell'assegnazione di una somma di denaro o altro bene a titolo di dote per consentire di contrarre un matrimonio, socialmente decoroso, anche a donne non appartenenti a famiglia con adeguati mezzi economici. La somma destinata al maritaggio era di lire cinquanta ed assegnata ad una giovinetta bisognosa e meritevole tratta a sorte tra quelle che avessero raggiunto il quindicesimo anno di età ed a condizione che avessero frequentato l’Oratorio festivo con assiduità e per almeno quattro anni; dovevano, inoltre, aver serbato una condotta di vita lodevole come si conviene ad una fanciulla "educata alla scuola di Gesù Cristo e che abbia fatto profitto nel Catechismo" (B.L.).
Il premio toccato alla prescelta dalla sorte, veniva posto su di un libretto della Cassa di Risparmio e consegnato alla intestataria, con i rispettivi frutti maturati, al compimento del ventiquattresimo anno di età.
(6) Maritaggio: istituto giuridico consistente nell'assegnazione di una somma di denaro o altro bene a titolo di dote per consentire di contrarre un matrimonio, socialmente decoroso, anche a donne non appartenenti a famiglia con adeguati mezzi economici. La somma destinata al maritaggio era di lire cinquanta ed assegnata ad una giovinetta bisognosa e meritevole tratta a sorte tra quelle che avessero raggiunto il quindicesimo anno di età ed a condizione che avessero frequentato l’Oratorio festivo con assiduità e per almeno quattro anni; dovevano, inoltre, aver serbato una condotta di vita lodevole come si conviene ad una fanciulla "educata alla scuola di Gesù Cristo e che abbia fatto profitto nel Catechismo" (B.L.).
Il premio toccato alla prescelta dalla sorte, veniva posto su di un libretto della Cassa di Risparmio e consegnato alla intestataria, con i rispettivi frutti maturati, al compimento del ventiquattresimo anno di età.
(Autore: Nicola Avellino)


*Altarino N° 10 - Sant'Alfonso Maria de Liguori
Sant’Alfonso Maria dei Liguori, dottore della Chiesa, opera del pittore M. Richter (1938).
Nel catino il mosaico che riproduce la scena della nascita di Gesù Cristo nella grotta di Betlemme.
San Francesco d’Assisi nella grotta della Verna, opera del pittore Ponziano Poverini, (1892).
Nel mosaico del catino si rappresenta la visitazione di Maria Vergine a S. Elisabetta.


San Domenico di Guzman che risuscita il principe Napoleone Orsini, nipote del card. Stefano di Fossanova, divenuto poi Papa Gregorio IX. Il dipinto è opera del pittore Ponziano Poverini (1892).
Nel mosaico nel catino la scena dell’Annunciazione di Maria Vergine.
Continuando la visita, ripartendo dall’ingresso centrale, si può ammirare nella volta della navata la scena dell’Assunzione di Maria Vergine, affresco di Vincenzo Paliotti (1888).
Più avanti, in un riquadro, lo stemma di Bartolo Longo e quello del vescovo Mons. Antonio Anastasio Rossi, con una data del periodo dell’ampliamento del Santuario A.D. MCMXXXVIII.
Alle pareti i monumenti in bronzo di Bartolo Longo, a sinistra, inaugurato il 5 ottobre 1928, e a destra quello della contessa Marianna de Fusco, inaugurato il 13 febbraio 1930, entrambi opera del prof. Antonio Giuseppe Tonnini.
In basso sono inseriti quattro artistici confessionali ordinati da Bartolo Longo agli ebanista napoletani Vincenzo Truda e Luigi Bellavista. Un anonimo, devoto della Madonna, nel maggio del 1892 donò per quest’opera cento napoleoni d’oro.
Bellissimi lampadari sono appesi agli archi della navata e del presbiterio.
Un Artista per Pompei
La collaborazione tra il Loverini e Bartolo Longo iniziò in occasione della costruzione di una Cappella in onore di S. Giuseppe. Al pittore fu commissionata una tela.
La tela era stata commissionata dal Vescovo e dal clero di Bergamo con l’intento di offrirla in dono al Papa Leone XIII nella ricorrenza del suo giubileo sacerdotale (1887). Il dipinto, portato a Roma, riscosse lusinghieri consensi nell’ambito della Curia, meritando così di figurare nell’Esposizione Vaticana del 1888. Bartolo Longo in quella occasione ebbe l’opportunità di ammirare l’opera ricevendone un’impressione profonda. Quel “carattere spirituale e devoto” trasfuso nella figura della Santa, suscitava intensa commozione.
Il Maestro, senza mezzi troppi appariscenti e con lo studio profondo dei particolari, era riuscito ad assurgere ad un felice concetto, esprimendo tutta la santità della scena, piena di dolcezza e di mistico e puro senso di tristezza.
Un artista per il Santuario
Bartolo Longo aveva scoperto finalmente l’artista che desiderava lavorasse per il Santuario a Valle di Pompei.
Risoluto gli spedì una lettera da cui chiari traspaiono i suoi desideri e le sue emozioni: “Al Signor Ponziano Loverini, Pittore. Borgo S. Caterina – Bergamo. Chiarissimo Signore, vidi un suo quadro all’esposizione Vaticana, Santa Grata con Sant’Alessandro e fui invaghito dal suo stile e dalle sue concezioni nell’arte. Dissi tra me: l’opera di questo pittore non deve mancare nel santuario Monumentale di Pompei, che è una mostra dell’arte italiana cristiana moderna di fronte alle vestigia dell’arte pagana antica. Io non ho il bene di conoscerla di persona, né conosco le sue esigenze nei lavori di pittura. Però se ella pensasse, nel suo cuore, come tanti artisti italiani e stranieri hanno inteso un desiderio di visitare quest’opera di religione, di arte e di civiltà che sorge rimpetto all’antica Pompei, sarei ben lieto di comunicarle i miei sentimenti, e, col viso della voce, potremmo accordarci per qualche dipinto, che, usufruendo il lustro di questo Santuario, renderebbe mondiale anche il suo nome. Intanto per farle avere qualche breve ragguaglio di quest’opera che la Provvidenza ha affidato alle mie cure, le mando alcuni quaderni del mio Periodico ed una immagine della nostra Vergine del Rosario. Sono, con profondo ossequio, suo devotissimo Bartolo Longo”.
L’incontro con il pittore Loverini fu provvidenziale; Bartolo Longo aveva piena ed urgente necessità di un artista cristiano a cui poter commettere le pale per gli altari che andava man mano erigendo nel novello Tempio dedicato alla Vergine del Santo Rosario. L’occasione gli si offriva propizia per l’erezione dell’altare di S. Giuseppe.
Non conosciamo, purtroppo, la risposta del Loverini alla lettere così lusinghieri di Bartolo Longo.
Sappiamo, però, che l’Avvocato il 29 maggio del 1889 rinnovò l’invito all’artista con termini veramente affettuosi: “Venite a passare qualche giorno a Pompei, facendomi il più grande dei favori. Resterà a mio conto la spesa per il viaggio e starete con noi in quei giorni come persona di famiglia” (B.L.)
La tela e l’altare di S. Giuseppe
Il pittore, irretito da un invito così suadente, assicura di essere a Pompei il 24 luglio del 1889.
In quell’incontro Bartolo Longo dovette esporre al Loverini i suoi progetti inerenti i dipinti da sistemare sugli altari e, più di tutto, discussero sicuramente circa la tela rappresentante il transito di San Giuseppe da esporre sull’altare nella grande cappella, a destra della Crociera. Indubbiamente ci fu l’accordo e la commissione, lo apprendiamo da una lettera del Loverini da cui stralciamo: “Bergamo, 7 settembre 1889. Illustrissimo Signor Avvocato, ieri ricevetti la sua gentilissima lettera contenente un vaglia di lire 1.000. A tanta attenzione non posso che ringraziarla immensamente assicurandola che il quadro da lei commessomi: il Transito di S. Giuseppe, convenuto alla somma di lire 5.000, lo consegnerò infallibilmente il 15 aprile 1890”.
Il quadro, infatti, spedito puntualmente, giunse per ferrovia, alla stazione di Scafati il 14 aprile 1890; per il trasporto Bartolo Longo pagò 73 lire e 25 centesimi. La grande tela fu sistemata su telaio dal Signor Chiariello “valente costruttore di tele” mentre, “l’artista Pesce, ne ricavò una magnifica fotografia”.
Installato il dipinto, rapidamente fu ultimata la magnifica struttura dell’altare e del cappellone. Il 7 maggio, mercoledì del 1890, il Cardinale Guglielmo Sanfelice dei Duchi di Acquavella alle ore 12 benedisse la cappella e consacrò solennemente l’altare.
“Questo altare sebbene non importante quanto quello dell’abside, ne ricorda tuttavia le linee principali ed è degno di osservazioni perché ne risulta un insieme artistico ed altamente religioso.
Un marmo rosso sanguigno (Griotta di Cannes) ne forma l’orditura principale, alternandosi nei fondi con durissime stalattiti di abbagliante fosforescenza.
Nei Capi Altare, invece, i fondi sono di raro marmo multicolore (Serrangolino). Due magnifiche colonnine di marmo nero (breccia africana), calzate da basi attiche con i fregi di bronzo dorato, simili a quelle dei capitelli, sorreggono la mensa che è tutta di un pezzo.
Il Ciborio presenta sul suo fronte un pronato con colonne di stalattiti dalle basi e dai capitelli di bronzo dorato. La trabeazione e la cornice sono di un vivissimo marmo rosso (breccia). La porta e la parte interna del Ciborio sono di bronzo dorato, lavorato con grande finezza.
La predella col sottostante scalino (marmo grigio dei Pirenei) forma base all’altare e si accorda perfettamente con esso.
L’altare è fornito di un parato di candelieri di bronzo massiccio dorato, che, sebbene più piccoli, riproducono nel disegno quelli dell’altare maggiore.
A destra dell’altare è addossata al basamento di un pilastro la mensola per deporvi le ampolline. Essa è composta da una lastra di raro marmo giallo (giallo di Siena) e di una gran mensola scolpita (marmo bianco di Carrara)” (Bartolo Longo).
Abbiamo ritenuto utile riportare l’antica descrizione dell’altare per fornire elementi convenienti per un paragone storico.
Si ricordi che a seguito dell’ampliamento del Santuario (1934-1939), furono affiancate al primitivo corpo centrale del Tempio le due navate laterali. Durante la costruzione di esse fu inevitabile, per validi motivi tecnici e strutturali, modificare notevolmente la linea architettonica originaria sacrificando, in parte, anche il sontuoso rivestimento marmoreo dei due altari del braccio destro e sinistro della crociera.
Bartolo Longo nel Periodico di luglio del 1890 esultante scrive:
“Il Transito di San Giuseppe del Professore Ponziano Loverini: una nuova gloria dell’arte italiana che trae le sue ispirazioni dall’ideale religioso.
L’Artista doveva incarnare un soggetto che va annoverato tra i più sublimi della storia della religione soprannaturale, e che si reputa il più difficoltoso dà grandi artisti.
Come abbiamo notato, la scena non è umana soltanto, ma umana e sovrumana ad un tempo.
I personaggi sono tre, tutti e tre offrono un grado di eccellenza che diventa ineffabile sotto il punto di vista dei rapporti che li uniscono nel compimento di una missione altissima.
Da una parte l’Uomo-Dio, dall’altra Maria e Giuseppe. L’Uomo-Dio entra in relazione sensibile con questi due esseri umani con il rapporto domestico e giuridico di figlio.
Maria, pur riconoscendo la sua inferiorità di natura a Gesù, è madre, e ne esercita il ministero.
Nella morte di San Giuseppe il Loverini, presentando i tre personaggi della scena tradizionale: (il protagonista che sta esalando lo spirito a Dio, la Vergine Santissima e il Divin Figliuolo che assistono), ha saputo con la fantasia variarla in modo nuovo e bello rischiarando la rustica camera del falegname di Nazareth con la luce che viene dal Cielo, e popolando l’aria di angeli lontani, di due che stanno sopra il moribondo con palme e di altri tre inginocchiati al suo fianco destro.
Così, un fatto del tutto conforme alla comune sorte dei mortali, prende carattere ascetico ed entra nei campi del sovrumano, dell’ideale.
(Da: Il Rosario e La Nuova Pompei – Anno 107 – n° 1 – Gennaio/Febbraio 1991)
(Autore: Nicola Avellino)
La prima festa in onore a San Giuseppe
L’opera pompeiana tra cronaca e storia
Interessante, a distanza di tanti anni, costatare come il Beato volle sottolineare il momento di festa cittadina con un generoso atto di carità verso i più poveri
La prodigiosa Immagine del Rosario resterà esposta nella nuova Chiesa sino alla Domenica 13 del Mese (1). Ed in quella Domenica per la prima volta in Pompei del Novello Santuario di Maria, accorreranno i poveri contadini ad onorare lo Sposo Immacolato dell’Immacolata Madre di Dio, il Patrono della Chiesa Universale (2), il Protettore della Chiesa di Pompei, e della nuova Casa del Rosario, e della buona morte (3), il Patrono della Chiesa Universale. I Contadini faranno la Comunione Generale, e vi sarà solennizzata la Prima Comunione dei fanciulli e delle fanciulle assidui al Catechismo. Ed il chiarissimo Missionario apostolico Sac. D. Francesco Scardaccione di Napoli farà il Colloquio della Comunione Generale ed il fervorino nella Benedizione di Gesù Sacramentato. Precederà la festa un triduo di Prediche, che farà il P. Maestro Fra Alberto Radente (4) dei Predicatori nominato dal Vescovo di Nola a Rettore della nuova Chiesa del Rosario in Pompei. La Festa sarà tutta di beneficenza e tutta a spese di alcune dame Napoletane devotissime del Santo Patriarca. Si darà il vestito ed il pranzo ad un vecchio, ad un fanciullo e ad una donna poveri (5), in onore della triade Terrestre. Si distribuiranno tre vestiti di premio a 3 fanciulli più assidui e più diligenti del catechismo festivo, ed altri 3 abiti alle fanciulle, ed un maritaggio di L. 50 (6). Si darà l’elemosina a 15 poveri in onore dei 15 Misteri. E il giorno vi sarà detto il panegirico, dal chiarissimo Oratore Domenicano P. Lettore F. Vincenzo Guida di Napoli.
Pompei il 22 di Aprile del 1883 – Bartolo Longo
Note
(1) I nostri lettori già sanno; più volte l’abbiamo riportato ed in varie occasioni abbiamo precisato che il Quadro miracoloso della Vergine, nei primordi dell’Opera Pompeiana, fu collocato provvisoriamente e per breve tempo nella vecchia e cadente chiesuola del SS. Salvatore in attesa di essere custodito ed esposto alla venerazione, nella cappella del SS. Rosario ubicato in un piccolo ambiente sulla sinistra per chi entra nell’attuale Santuario. In attesa che si completassero i lavori per la costruzione del grande Tempio e, soprattutto, dell’altare monumentale con il suo trono grandioso, le funzioni si svolgeranno appunto in quella piccola Cappella con naturale disagio per i fedeli, tutti desiderosi di prostrarsi ai piedi della Vergine miracolosa ed implorare da Lei ogni grazia.
Bartolo Longo addirittura fu costretto, specialmente per i pellegrinaggi con numerosi partecipanti, a stabilire un turno di prenotazione al fine di poter consentire a tutti di venerare, anche per breve tempo, più da vicino la Sacra Immagine. In qualche ricorrenza solenne, sempre compatibilmente con lo svolgimento dei lavori, il Quadro veniva trasferito nel Tempio in costruzione e collocato su un altare centrale, provvisorio, contornato da altri cinque altari più piccoli per dare agio ai numerosi sacerdoti di celebrare la Messa ed ai fedeli di raccogliersi in preghiera. Nel 1883, come Bartolo Longo ci testimonia. Il Quadro fu esposto infatti nell’erigendo del Tempio “occupato per metà da anditi; e stuccatori, e marmolai, e pittori, che già intendono a decorare la parte più eccelsa della Chiesa quale è la Cupola, ed i quattro archi maggiori, secondo le regole della buona architettura.
Pertanto i pellegrini entreranno dalla porta maggiore del Tempio, ascolteranno la Messa all’altare a bella posta eretto nel mezzo di esso per venerare l’immagine prodigiosa” (B.L.).
(2) Il Papa Pio IX, con proprio decreto del giorno 8 Dicembre 1870, aveva solennemente dichiarato San Giuseppe Protettore della Chiesa Universale.
(3) Bartolo Longo aveva fondato la Confraternita per gli agonizzanti ed aveva predisposto una speciale schiera di candide orfanelle, chiamate appunto Giuseppine, deputate a recitare particolari fervide preghiere per gli associati moribondi “soccorrendoli in quelle ore angosciose ed estremo bisogno con la prece potentissima dell’innocenza” (B.L.).
Il primo associato alla Confraternita fu proprio Leone XIII che, per felice coincidenza, morì il 20 luglio 1903, il giorno del Transito del Patriarca San Giuseppe da secoli celebrato dalla Chiesa e, per la prima volta, in quell’anno, commemorato e festeggiato nella Basilica di Pompei.
(4) Bartolo Longo profondamente commosso partecipa ai fratelli e alle sorelle del Terz’ordine della Penitenza di San Domenico, la morte del Padre Radente, il loro direttore. “Il nostro dolce, benigno e caritatevole Direttore, padre maestro Fr. Alberto Radente dei Predicatori, il vero sacerdote secondo il cuore di Dio, il degno rappresentante di San Domenico in mezzo a noi suoi figli, il primo Apostolo del Rosario in questa Valle di Pompei, il sottile filosofico, il profondo teologo, l’inarrivabile maestro di spirito, colui che possedette in grado eroico le virtù dell’umiltà, della carità, del disinteresse, della purità, della misericordia, della povertà e della obbedienza religiosa, il tenerissimo amante di Maria, venne a noi rapito da questa terra di esilio il giorno di lunedì 5 di gennaio (1885), nell’ora dei primi vespri dell’Epifania, lasciando noi tutti nel pianto e nell’amarezza… I suoi esempi ed eminenti virtù, le sue massime di una semplice ed insieme alta santità siano vive innanzi agli occhi nostri ed alla nostra mente” (B.L.).
Per inciso si ricordi che la memoria di Padre Radente, in relazione all’Opera Pompeiana, deve restare imperitura e, senza limiti, la riconoscenza. Egli aveva dato alla sua penitente, Suor Maria Concetta De Litala, la vecchia e sdrucita tela della Madonna del Rosario; su indicazione di Padre Radente, Bartolo Longo si recò da quella pia monaca e ne ebbe in dono il quadro che, portato a Valle di Pompei, fu esposto alla venerazione per la prima volta la sera di sabato, 13 Novembre 1875.
(5) Con l’istituzione dell’Ospizio per i figli dei carcerati (1892), la beneficenza ai poveri ed ai fanciulli veniva effettuata da Bartolo Longo in un ambito notevolmente più vasto. La cerimonia del pranzo si svolgeva infatti nel cortile dell’Istituto ed era una offerta simbolica, un piacevole dono fatto dai giovinetti ivi ricoverati, quasi a voler essi offrire un ringraziamento; un ricambio di carità, anzi, una sublime trasformazione: i beneficiati diventavano benefattori. Sul calendario del 1904, Bartolo Longo pubblicò la cerimonia del pranzo offerto il 24 maggio q903 a 100 vecchietti ed ai fanciulli poveri. È una pagina stupenda, la riproduciamo con qualche doloroso taglio.
“Quale caratteristica sfilata! Vecchi e fanciulli indossano abiti puliti, camicie di bucato, e forse in quel mattino avevano curata un poco più attentamente degli altri giorni la personale nettezza. Entravano, uno per volta, sotto il porticato, dove erano ordinate le mense. Tra i vecchi, chi zoppicava, chi poggiavansi su due bastoni; altri trascinavansi innanzi con movenze stentate, altri poggiavansi alla spalla del compagno vicino; qualche infelice, perché cieco, era condotto per mano, i fanciulli, invece, irruppero come un’ondata. Tutti portavano al collo, sospeso con un nastrino, il biglietto di invito fatto a forma di cuore.
Ogni povero aveva innanzi, al proprio posto, il suo tovagliolo, una bottiglia di vino, un mezzo pane bianchissimo, il piatto, il bicchiere e la posata. I Figli dei Carcerati nella loro tenuta di gala si affaccendavano intorno alle tavole; e dalle sale, che mettevano capo nella grande cucina dell’Ospizio, sino alle mense era una processione di fumiganti tondini pieni di saporose e odorose vivande. Era grazioso vedere i fanciulli poveri che sgranavano tanto d’occhi all’arrivo di una grossa porzione di carne. I vecchi guardavano di preferenza le bottiglie, e vi fu pure chi cedette qualche pietanza in cambio del vino, al compagno. Ma la festa raggiunse il massimo brio, quando comparvero delle grosse torte dolci. I Fanciulli invitati, con gioia infantile, applaudirono, seguendo con gli occhi ogni porzione che veniva staccata dal piatto comune e servita per turno. Negli occhi dei vecchi tremolavano lagrime di riconoscenza, i monelli vociando e ridendo erano soddisfatti delle ore passate in tavola. Come ricordo della bella Festa furono donati ai centro poverelli i piatti, la posata, il bicchiere, la tovaglia e il tovagliolo che avevano usati per il pranzo”.
(6) Maritaggio: istituto giuridico consistente nell’assegnazione di una somma di denaro o altro bene a titolo di dote per consentire di contrarre un matrimonio, socialmente decoroso, anche a donne non appartenenti a famiglia con adeguati mezzi economici. La somma destinata al maritaggio era di lire cinquanta ed assegnata ad una giovinetta bisognosa e meritevole tratta a sorte tra quelle che avessero raggiunto il quindicesimo anno di età ed a condizione che avessero frequentato l’Oratorio festivo con assiduità e per almeno quattro anni; dovevano, inoltre, aver serbato una condotta di vita lodevole come si conviene ad una fanciulla “educata alla scuola di Gesù Cristo e che abbia fatto profitto nel Catechismo” (B.L.).
Il premio toccato alla prescelta dalla sorte, veniva posto su di un libretto della Cassa di Risparmio e consegnato alla intestataria, con i rispettivi frutti maturati, al compimento del ventiquattresimo anno di età.
(Autore: Nicola Avellino)
Inaugurata la Cappella di San Giuseppe Moscati
L’Associazione dei Medici Volontari San Giuseppe Moscati ha dato inizio alle sue attività culturali con una conferenza sulla figura di “Giuseppe Moscati: medico e Santo”, tenuta dal Prof Dott. Luca Steardo, docente presso la facoltà di Medicina dell’Università di Bari, uno dei fondatori dell’Associazione.
La conferenza ha avuto luogo il 22 dicembre 1997, nell’ambito dell’inaugurazione, benedizione e dedicazione a San Giuseppe Moscati di una nuova cappella nel Santuario di Pompei, presiedute dall’Arcivescovo Mons. Toppi.
La cerimonia è avvenuta alla presenza di numerose autorità, tra cui: Mons. Cece, Vescovo della diocesi di Castellammare, il Prof. G. Donsì, Rettore dell’Università di Salerno, il Prof. R. Pasquino e il Prof. F. De Simone, Presidi rispettivamente della facoltà di Ingegneria e di Farmacia dell’Università di Salerno, il G. Uff. Gen. U. Ianniello dell’O.E.S.S.G. e il Prof. Sandro Staiano, Sindaco di Pompei.
Spinta dalla presenza dell’Associazione nelle Opere di Pompei, Mons. Toppi, ha inteso interpretare un’aspettativa largamente diffusa tra i fedeli e dare testimonianza di una profonda devozione verso questo laico Santo dei nostri giorni, che nella pratica della sua professione seppe in maniera impareggiabile profendere, accanto ai frutti di un altissimo sapere scientifico, luce di fede e ardore di carità.
“Decisione questa particolarmente attesa e da tutti sentita opportuna” – ha sottolineato il Prof. Steardo – “soprattutto se si considerano i rapporti di caritatevole servizio che Moscati intrattenne con le Opere di Pompei. Difatti egli volle prestare come volontario, con la gratuità dell’atto d’amore più autentico, la propria opera di medico a quanti, in qualunque modo, appartenessero alle Opere”.
Il relatore ha poi rimarcato come Moscati fosse stato capace di superare limiti della visione dell’uomo del suo tempo. Egli “si formò in un ambiente culturale in cui si operavano i primi tentativi di riduzionismo biologico che desacralizzava la vita e imprigionava l’uomo in schemi classificatori ponendolo alla sommità della scala evolutiva, ma privandolo di ogni dignità di trascendenza. Egli seppe sfidare queste concezioni vivendo costantemente l’impegno di medico che riconosce in Dio l’origine della vita e il suo destino ultimo”.
Il Prof. Steardo ha poi continuato ricordando le tappe salienti della carriera accademica e ospedaliera di Moscati, rimarcandone l’originalità delle ricerche, il rigore intellettuale degli approcci e la visione estremamente moderna della medicina che caratterizzarono la sua opera di ricercatore e di clinico.
“Anticipatore con spunti originali di tante scoperte future, Moscati seppe, al tempo stesso, evitare il rischio di scomposizione dell’uomo, insito nella medicina moderna.
(…). Ma Egli seppe resistere ad un rischio ancora maggiore rappresentato da un meccanicismo che disumanizza la medicina riducendo l’uomo al suo fisicismo, escludendo la dimensione spirituale della malattia e negando che essa, al di là del suo substrato fisico, riguarda l’uomo nella sua interezza (…). Soltanto la volontà di cogliere nella sofferenza il senso che travalica il biologico, può introdurre la medicina nel mistero dell’uomo (…).
D’altra parte però, il solo accostarsi all’ammalato con sentimenti di umana solidarietà non porrebbe l’opera di Moscati al di fuori di una tradizione deontologica del pensiero occidentale che muove dalle posizioni etiche espresse nel giuramento di Ippocrate.
Se si fosse mosso in questo alveo di sentimenti e su questo registro di pensiero sarebbe stato un “medicus perfectus”.
Invece fu medico santo perché intuì sempre e in ognuno la sacralità della vita, la sua intangibilità, il suo valore supremo. Fu consapevole che c’è un Dio prima e dopo la vita e che l’uomo di scienza può aiutare veramente l’umanità solo se è capace di conservare il senso della trascendenza dell’uomo sul mondo e di Dio sull’uomo. Fu santo perché si credente capace di trovare un fondamento trascendente per l’etica, di radicare l’agire morale ad un pensiero forte, in un Dio personale che si è fatto uomo e si è fatto crocifiggere per la salvezza del genere umano. E questa capacità di ancorare l’agire medico ad un credo religioso è quanto mai necessaria oggi, dinanzi alle gravi problematiche morali derivanti dai progressi della medicina che scuotono profondamente le coscienze degli operatori sanitari”.
Infine, il relatore ha concluso ricordando che “Moscati non è un santo solo per i medici. Egli seppe operare cristianamente in tutte le espressioni del suo agire quotidiano, e la Chiesa lo offre come esempio a tutti quanti intendono percorrere sentieri di vita cristiana nel lavoro, nella famiglia, nella società civile”.
Alla fine della cerimonia ciascuno è andato via riflettendo sull’esemplarità della figura di questo medico Santo e considerando che non possiamo rimanere sordi ad una tale chiamata, se non vogliamo venir meno al nostro impegno di essere cristiani.
(Autore: Maria del Rosario Steardo)